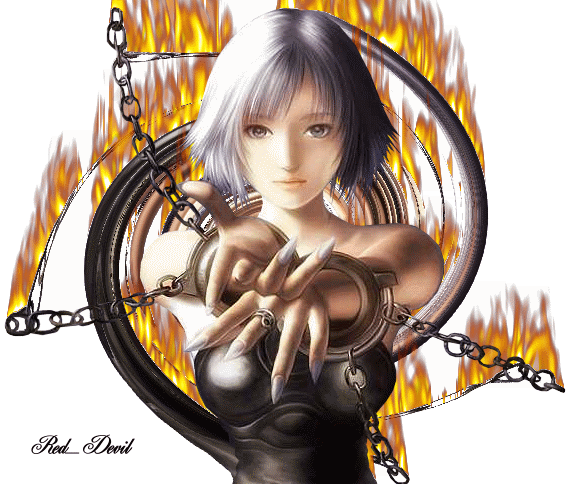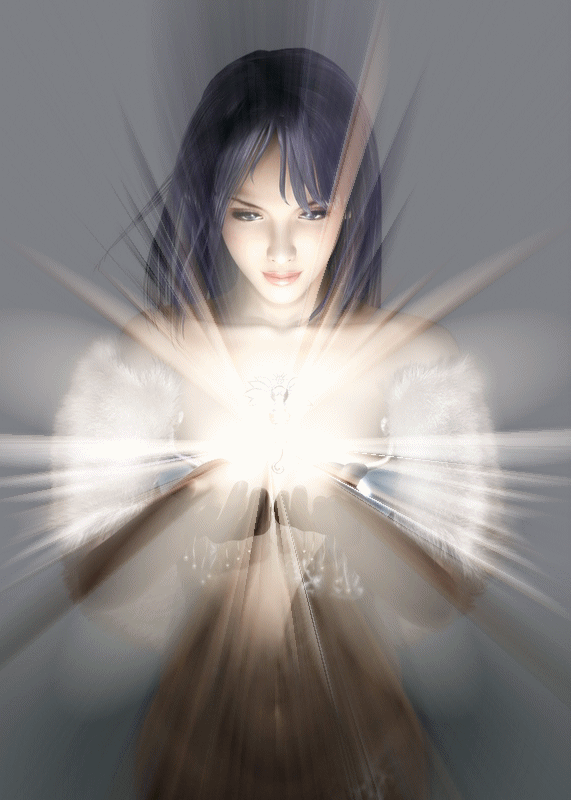Informativa Privacy e Privacy Policy
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice che trovi alla pagina: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
Se desideri che ShinyStat™ non raccolga alcun dato statistico relativo alla tua navigazione, clicca sul pulsante OPT-OUT.
AVVERTENZA: l'OPT-OUT avviene installando un cookie (nome cookie ShinyStat di opt-out: OPTOUT) se cancelli i cookies, sarà necessario ripetere l'opt-out in quanto cancellarei anche il cookie di opt-out
ALTALEX NEWS

venerdì 29 ottobre 2010
Nuovissimo Codice della Strada - SCARICALO GRATUITAMENTE
eBook , segnalazione del 03.08.2010
clicca qui per scaricarlo
http://www.altalex.com/index.php?idnot=11631
Facebook sbarca in Cassazione Penale (Cass. n. 37151 del 2010)
Sentenza 18 ottobre 2010, n. 37151
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
Sentenza 18 ottobre 2010, n. 37151
Svolgimento del processo
Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, con ordinanza in data 10 maggio 2010, rigettava la richiesta del PM di sostituzione, nei confronti di P.R. e M.G., della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per avere gli stessi violato la prescrizione loro imposta di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, comunicando via Internet, sul sito "Facebook", con altre
persone.
Proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ritenendo integrata la violazione della prescrizione di non comunicare con altre persone, imposte in sede di concessione della misura cautelare, stante i contatti intrattenuti con altre persone dagli imputati attraverso la rete.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La generica prescrizione di "non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi" prevista dall'art. 276 c.p.p., comma 1, va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet.
L'uso di Internet non può essere vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza di entrare in contatto, tramite il web, con altre persone.
La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di "comunicazione", pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico "divieto di comunicare", il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l'indagato con terzi ("pizzini", gesti, comunicazioni televisive anche mediate, etc.).
L'eventuale violazione di tale divieto va, comunque, provato dall'accusa e non può ritenersi presunto, nella fattispecie, dall'uso dello strumento informatico.
Non risulta, nella specie, alcuna motivazione da parte del G.I.P., in ordine all'eventuale comunicazione con terzi, posta in essere dall'indagato attraverso Facebook.
Va, quindi, annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame.
La prescrizione di cui all’art. 276 co. 1 c.p.p. di "non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi", va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet. Costituisce, pertanto, violazione di tale divieto la comunicazione con altre persone operata tramite “facebook”.
Chi è agli arresti domiciliari non può comunicare con Facebook ma solo limitarsi a usare Internet senza entrare in contatto con altre persone, lo ha stabilito con la sentenza n. 37151/2010 la Suprema Corte accogliendo il ricorso di un PM.
E’ stata così convertita la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, per due soggetti che comunicando via Internet, sul sito “Facebook”, hanno violato la prescrizione imposta di non comunicare e/o interagire con persone diverse dai familiari conviventi.
Secondo i giudici della Suprema Corte la prescrizione prevista dall’art. 276 c.p.p., comma 1, di “non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi”, deve intendersi come divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di non entrare in contatto con altri, ritenendo tali anche le comunicazioni vocali e scritte via Internet. Quando l’uso di Internet è attuato, proseguono i giudici, come funzione conoscitiva o di ricerca, senza entrare in contatto via web con altre persone può essere consentito.
Lo scambio di informazioni e la comunicazione fornita dalla moderna tecnologia via Web, deve intendersi ricompresa nel generico “divieto di comunicare”, violazione che comunque l’accusa deve provare. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.
(Altalex, 28 ottobre 2010. Nota di Cesira Cruciani) dal sito internet
http://www.altalex.com/index.php?idnot=12216
Reddito da considerare ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Sentenza 14 luglio - 12 ottobre 2010, n. 36362
1. Con istanza avanzata in data 29/7/2008, S.A. chiedeva l'ammissione al gratuito patrocinio in relazione ad un procedimento penale a suo carico pendente.
Con Decreto 29 luglio 2008 il GIP del Tribunale di Palmi, dichiarava inammissibile la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
A seguito di opposizione, il Presidente del Tribunale di Palmi, con provvedimento del 15/1/2009, confermava il decreto rigettando l'opposizione.
Osservava il Presidente che nel formulare l'istanza la S. aveva dichiarato di percepire annualmente la somma di Euro 1.680= quali contributi statali e somme da parte dei familiari. Tale ultima voce non era specifica, ma indicata in modo generico in violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lett. c).
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della S., lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito non aveva tenuto conto che il reddito tipizzato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 è costituito dal reddito imponibile, nell'ambito del quale non rientrano le erogazioni di parenti; inoltre gli artt. 96 e 72, nel valutare il superamento dei limiti per l'ammissione, prendevano in considerazione solamente i redditi dei parenti conviventi e non quelli di soggetti estranei.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va preliminarmente evidenziato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale... risultante dall'ultima dichiarazione", bensì anche ai "redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
Orbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 c.c., quali il tenore di vita ecc".
Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità laddove si è statuito che "Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (ex plurimis, Cass. 4, 45159/05, Bagarella; cfr. anche Corte Cost. sent. n. 144 del 1992).
Se ne deduce che qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale (non aggiuntivo dei familiari conviventi), ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76.
La ragione dell'esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante, risponde a quella di autorizzare il trasferimento alla Stato una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività.
Funzionale a ciò è la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lett. c) laddove è previsto che l'istante deve attestare "... la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione,, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dall'art. 76".
Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che nell'istanza presentata, la indicazione che "per il sostentamento mio e della mia famiglia riceviamo degli aiuti economici da parte dei familiari" era carente di specificità, in quanto non indicava l'ammontare di tali erogazioni, valutandola quindi inammissibile.
Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362 rimanendo fedele al precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
Dal punto di vista normativo, l’articolo 76 del D.P.R. 115/2002, nell'indicare le condizioni di ammissibilità al gratuito patrocinio non fa solo riferimento al reddito imponibile ai fini dell'Irpef bensì anche ai "redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva".
La Corte Costituzionale, dal canto suo, come ricordato dagli ermellini, ha evidenziato che "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 c.c., quali il tenore di vita, ecc".
Il principio sostenuto dal giudice nomofilattico, nella sentenza che qui si annota, va ad aggiungersi, come anticipato, ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa”.
(Altalex, 29 ottobre 2010. Nota di Simone Marani)
L’avvocato con l’apprendista deve pagare l’IRAP
Sentenza 20 ottobre 2010, n. 21563
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello di B.F., avvocato, gli ha negato il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.
Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il contribuente censura la sentenza d'appello per vizio di motivazione; con il secondo morivo, denuncia la violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione;
con il terzo motivo, deduce l'incompatibilità dell'IRAP con la normativa comunitaria.
Il ricorso è infondato perchè, pur essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata non conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia - secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzìdette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007) -, nondimeno essa contiene un inequivoco accertamento di fatto in ordine alla sussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, per essersi avvalso il contribuente essersi avvalso il contribuente di un lavoratore dipendente, definito nel ricorso per cassazione, che riporta un passo del ricorso introduttivo, "una sola apprendista part time", accertamento che non è oggetto di censura, e che rende il dispositivo conforme a diritto.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 3 ottobre 2006 in causa C-475/03, ha stabilito che l'art. 33 della sesta direttiva IVA del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991 n. 91/680/Cee, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il ricorso, in conclusione, previa correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, va rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Ancora gli avvocati nel “mirino” del fisco. Il professionista che nel proprio studio ha un apprendista (dipendente, anche se part-time) è soggetto al pagamento dell’IRAP.
Così hanno deciso i giudici della sezione V della Suprema Corte con la sentenza 20 ottobre 2010, 21563, i quali hanno giudicato che tale circostanza sia sufficiente a far presumere l’esistenza di autonoma organizzazione.
Con la sentenza in commento i giudici della Corte hanno respinto il ricorso di un avvocato (promosso avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale) il quale aveva chiesto il rimborso dell’imposta, l’IRAP, fornendo come motivazione il fatto che “impiegava nel proprio studio solamente una collaboratrice” e non riteneva, pertanto, sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.
Dello stesso avviso, però, non sono stati i giudici di legittimità (concordando con quanto già precisato dai colleghi di merito) i quali hanno, altresì, ribadito (sebbene la giurisprudenza non sia uniforme sul tema) che per coloro che svolgono arti o professioni si configura l’autonoma organizzazione e la debenza, quindi, dell’imposta, quando il contribuente:
sia il responsabile dell’organizzazione e non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita` anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.
Colpo “duro” per gli avvocati che almeno per quanto riguarda i fini impositivi dovranno considerare un praticante, regolarmente retribuito e inserito nella propria struttura organizzativa, come qualsiasi altro lavoratore dipendente.
(Altalex, 28 ottobre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
Anche per l’esame di avvocato come per quello di notaio la valutazione negativa va sempre motivata.
Sezione IV
Sentenza 14 ottobre 2010, n. 4200
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2010, proposto da: ………., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Cangemi, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a; contro Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Anno 2009 c/o Corte di Appello di Ancona 2^ Sottocomm., Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Corte di Appello di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; per l'annullamento del verbale n.10 del 7/5/2010 della seconda Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Ancona, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio insufficiente sulle tre prove scritte e del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Centrale Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Anno 2009 c/o Corte di Appello di Ancona 2^ Sottocomm. e di Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Corte di Appello di Messina;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Biagio Campanella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.Ritenuto in fatto quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio. Considerato che il ricorso appare fondato in quanto:A – Visti l’art. 23, comma 7, l’art. 24, comma 1, e l’art. 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellati dal D.L. 21 maggio 2003, n. 180, in base ai quali, nel valutare le prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Commissione giudicatrice assegna dei voti numerici ai singoli elaborati.Visto l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni, in base al quale “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento dei pubblici concorsi…deve essere motivato…La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.Viste le ordinanze 14 novembre 2005, n. 419 e 27 gennaio 2006, n. 28, con le quali la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 23, comma 5, 24, comma 1 e 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modificazioni (in quanto volte ad ottenere l’avallo della Corte ad una certa interpretazione delle disposizioni impugnate, piuttosto che a sottoporre ala stessa un dubbio di legittimità costituzionale), ha tuttavia esplicitamente escluso che “la tesi dell’inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania-Sezione 4^ ACCOGLIE il ricorso in epigrafe ed annulla, per l’effetto, gli atti con lo stesso impugnati, nei modi di cui in motivazione e con le prescrizioni ivi indicate.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:Biagio Campanella, Presidente, Estensore Dauno Trebastoni, Primo Referendario Giuseppa Leggio, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14/10/2010
In particolare, per il TAR etneo l’art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo di disciplina delle modalità di svolgimento delle prove orali del concorso notarile, secondo cui “La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione”, ancorché riferito al concorso di notaio, va considerato come espressione del principio di trasparenza dell’attività della pubblica Amministrazione sancito, a livello normativo, dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art. 97, comma 1 della Costituzione, la cui valenza deve essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale e quindi anche a quella relativa agli esami di avvocato.
Di conseguenza, il TAR adito ha ordinato alla Commissione, in diversa composizione, di ricorreggere entro 30 gg gli elaborati del ricorrente.
(Altalex, 25 ottobre 2010. Nota di Alfredo Matranga)
mercoledì 13 ottobre 2010
PIETRO BERTI: L’adozione
lunedì 11 ottobre 2010
SISTEMA SIAMM BOLOGNA
Corte d'Appello e Tribunale per i Minorenni
(dal sito web http://www.ordine-forense.bo.it/default.asp?id=1&ACT=5&content=503&mnu=1)
http://www.ordine-forense.bo.it/media/CorteAppelloIstanzeLiquidazioneTelematiche.pdf
http://www.ordine-forense.bo.it/media/TribunaleMinorenniIstanzeLiquidazioneTelematiche.pdf
è possibile scaricare i programmi dal sito web http://www.tribunaledimodena.it/
(a dx nella barra scendere fino a trovare la scritta SIAMM ove si possono trovare anche le istruzioni per l'uso)
nella speranza di aver reso un servizio utile
PIETRO BERTI: Minori e giustizia
PIETRO BERTI: Il Malato di mente tra Ospedale Psichiatrico Giudi...
Demansionamento
La Corte Costituzionale a riguardo con una sentenza del 2004 ha affermato infatti che: “…la violazione dell’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto (demansionamento) arreca danni alla sua professionalità intendendosi con essa il complesso delle capacità e attitudini del lavoratore. Tale danneggiamento provoca compromissione delle aspettative del lavoratore, danni alla persona e alla sua dignità…”.
Viene accolta così, a livello Costituzionale, una concezione del lavoro come attività che concorre al progresso materiale e spirituale della società di cui il divieto di demansionamento è garante. Viene così limitato, a tutela del lavoratore, lo ius variandi del datore di lavoro: ovvero il potere di quest’ultimo di modificare le mansioni in virtù di esigenze di organizzazione del lavoro a fronte di situazioni dinamiche e imprevedibili. La limitazione consiste in un divieto inderogabile (è nullo infatti ogni patto contrario)di demansionamento e in una facoltà quindi di adibire il lavoratore a mansioni diverse ma equivalenti e che vengano retribuite allo stesso modo o a mansioni superiori con conseguente innalzamento della retribuzione.
Il demansionamento perpetrato ai danni del lavoratore è, giusta quanto precede, un inadempimento del contratto di lavoro che legittima il lavoratore medesimo a richiedere il risarcimento del danno conseguentemente sofferto (sulla qualificazione del demansionamento come inadempimento contrattuale si veda, tra le recenti, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 21673/2005).
Al riguardo, si è posta in giurisprudenza la problematica relativa al riparto dell’onere della prova in merito ai danni subiti dal lavoratore a seguito del demansionamento e, più in particolare, la questione della risarcibilità del danno e delle componenti che vanno valutate in relazione al danno (qualora esso ci sia) e che vanno risarcite a seguito del demansionamento sono state oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale sul quale sembra avere messo la parola fine la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 6572/2006. La Cassazione in questa sede ha infatti affrontato analiticamente la questione del danno da professionalità specificandone in modo preciso il contenuto. Fino a questo momento infatti, in seno alla Giurisprudenza di legittimità, vigevano posizioni contrastanti che da un lato sostenevano che il danno da demansionamento , soprattutto quello esistenziale, conseguisse in re ipsa al fatto (in proposito si vedano Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13299 del 16 dicembre 1992; n. 11727 del 18 ottobre 1999; n. 14443 del 6 novembre 2000; n.13580 del 2 novembre 2001 , n. 15868 del 12 novembre 2002; n. 8271 del 29 aprile 2004; n. 10157 del 26 maggio 2004). Dall’altro lato invece veniva sostenuta la posizione per cui la risarcibilità del danno fosse subordinata all’assolvimento, da parte del lavoratore, dell’onere di provare l’esistenza del pregiudizio( si vedano in proposito Cass. Civ. Sze. Lav. nn. 7905 dell’11 agosto 1998; n. 2561 del 19 marzo 1999; n. 8904 del 4 giugno 2003; n. 16792 del 18 novembre 2004)
Il danno da demansionamento può assumere aspetti diversi, ha specificato la Suprema Corte. Esso può consistere, infatti, in un danno patrimoniale derivante in via diretta ed automatica dalla dequalificazione della capacità professionale del lavoratore e dalla mancata acquisizione di capacità maggiori con probabile perdita addizionale di un maggior guadagno. E può comporsi anche di aspetti non patrimoniali riconducibili alla più generale categoria del cd danno esistenziale. Esso si può a sua volta comporre di più parti come il danno all’integrità psicofisica o danno biologico, il danno all’immagine e/o quello alla vita di relazione . Proprio in virtù di ciò si rende necessaria, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore.L’inadempimento, infatti, è già sanzionato, di per sé, con l’obbligo di corrispondere la retribuzione nonostante lo svolgimento di mansioni inferiori o, nei casi più gravi, nonostante l’inattività del lavoratore, perciò il danno ulteriore, se c’è, deve essere specificatamente dimostrato in tutte le sue componenti. E’ così, dunque, che il contrasto è stato risolto dalla Suprema Corte che, inequivocabilmente, ha abbracciato il filone della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato secondo cui il danno, ove esistente, deve essere dimostrato a prescindere dal fatto che la dimostrazione sia difficoltosa. Il lavoratore si vede costretto, perciò, all’ardua prova della effettiva perdita di chance per quel che riguarda le effettive aspettative di carriera che avrebbe avuto se il demansionamento non fosse avvenuto.Deve dimostrare, inoltre, non solo la dequalificazione, l’isolamento, la forzata inoperosità, l’assegnazione a mansioni inferiori ma anche che tutto ciò abbia inciso negativamente nella sua sfera lavorativa, privata e familiare cambiando il suo stile di vita e alterando il suo equilibrio. In tale prospettiva, la Suprema Corte ha, dunque, affermato il principio per cui il danno professionale non può essere riconosciuto se non in presenza di una adeguata allegazione: si rende, così, necessaria, ad esempio, per dimostrare che c’è stato effettivamente un danno patrimoniale della professionalità e conseguirne il relativo risarcimento, la deduzione dell’ esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione e l’indicazione delle specifiche aspettative frustrate. Per quanto, invece, riguarda la componente del danno biologico, la Corte ha precisato che la prova può essere fornita attraverso l’allegazione della certificazione medica che attesti una lesione dell’integrità psicofisica e/o, in sede giudiziale, a mezzo di consulenza tecnica.Per ciò che concerne il danno esistenziale, è necessario allegare fatti e prove che dimostrino il rapporto di causalità tra il deterioramento della vita sociale e familiare e il demansionamento stesso. La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di chiarire che, se è vero che il pregiudizio esistenziale oggetto di un risarcimento non può limitarsi alla mera sofferenza emotiva, ciò significa che deve dimostrarsi che si sarebbero fatte effettivamente scelte di vita diverse se l’evento dannoso non si fosse verificato. Tale dimostrazione, che può essere fatta attraverso prove testimoniali e documentali, può procedere, e necessariamente procederà, anche per presunzioni. La Corte recupera così l’importanza di questo mezzo di prova per quei fatti che difficilmente posono essere oggetto di altri metodi di allegazione e di prova. A questo scopo, il lavoratore ricorrente deve allegare una serie concatenata di fatti noti che, complessivamente considerati, diano prova che c’è stato un danno e che questo sia conseguente al demansionamento. La sentenza in commento ha, da un lato, finalmente fatto chiarezza nella disordinata e controversa materia del danno da demansionamento ma ha presumibilmente aperto una nuova stagione di dibattiti sulla possibilità, per il lavoratore demansionato, di trovare, in sede processuale, una effettiva tutela. Non si può sottacere, infatti, che, se questa sentenza ha avuto il pregio di chiarire finalmente un dibattito che da troppo tempo si trascinava, essa ha comunque caricato il lavoratore demansionato di pesanti, e in taluni casi forse insormontabili, oneri probatori. E’ doveroso, infatti, sottolineare come il filone giurisprudenziale disatteso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione aveva l’indubitabile pregio di assistere in chiave processuale una parte, come quella del lavoratore demansionato, che, in quanto tale, incontrava ed incontrerà particolari difficoltà nell’allegazione di fatti e, ancora più, nel reperimento di specifici mezzi di prova atti a dimostrare i danni subiti. In tal senso la riconduzione del demansionamento a quei casi in cui vige la presunzione del danno appariva, forse, giustificata proprio dal rango costituzionale del bene protetto: il lavoro come mezzo di autorealizzazione della personalità e dignità dell’individuo.
Ricorso per demansionamento: un quadro sistematico sui presupposti e sui requisiti
I ricorsi in tema di demansionamento rappresentano, senza dubbio, una quota non indifferente del contenzioso giuslavoristico, sia sotto il profilo quantitativa, sia in riferimento agli importanti valori costituzionali sottesi. Con il presente articolo, si intende fornire un primo quadro sintetico in merito ai presupposti ed ai requisiti di un ricorso per demansionamento, rinviando a successivi approfondimenti l'esame di specifiche problematiche connesse all'art. 2103 c.c.
I ricorsi in tema di demansionamento rappresentano, senza dubbio, una quota non indifferente del contenzioso giuslavoristico, sia sotto il profilo quantitativa, sia in riferimento agli importanti valori costituzionali sottesi. Con il presente articolo, si intende fornire un primo quadro sintetico in merito ai presupposti ed ai requisiti di un ricorso per demansionamento, rinviando a successivi approfondimenti l'esame di specifiche problematiche connesse all'art. 2103 c.c.
(tratto da http://www.previdenza-professionisti.it/idarticolo=476)
Ricorso per demansionamento
1) fondamenti normativi
Il ricorso per demansionamento trova fondamento nel divieto previsto dall’art 2103 del c.c. che limita a tutela del lavoratore lo ius variandi del datore di lavoro: ovvero il potere di quest’ultimo di modificare le mansioni in virtù di esigenze di organizzazione del lavoro a fronte di situazioni dinamiche e imprevedibili. La limitazione consiste in un divieto inderogabile (è nullo infatti ogni patto contrario)di demansionamento e in una facoltà quindi di adibire a mansioni diverse ma equivalenti che vengano però retribuite allo stesso modo o a mansioni superiori con conseguente innalzamento della retribuzione.Demansionamento: l’art. 2103 c.c. va interpretato in modo elastico
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 05.04.2007 n° 8596
(tratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=36998)
La disciplina di cui all’art. 2103 c.c. va interpretata in modo elastico, ammettendo che il lavoratore possa essere assegnato a mansioni diverse, in ragione dell’esigenza dell’impresa, e perfino a mansioni di minore rilevanza, quando per ristrutturazione aziendale la contrattazione collettiva lo prevede, a propria garanzia o anche per evitare il licenziamento.
Nel caso di specie, un dipendente delle Spa Poste Italiane assunto con la qualifica di operatore specializzato di officina ed inquadrato nella quinta categoria secondo il previgente contratto, veniva successivamente inquadrato nella sesta categoria, svolgendo mansioni di manutenzione meccanica ed elettromagnetica (e molto marginalmente elettronica) degli impianti postali (apparecchiatura e componentistica varia).
A seguito della trasformazione dell’ex amministrazione Poste in Ente Pubblico Economico e con la stipula di un nuovo contratto nazionale di lavoro che prevedeva l’abolizione delle precedenti categorie e l’inquadramento, al fine di consentire la massima flessibilità gestionale del personale, in sole quattro aree di classificazione, sicché gli ex dipendenti della quarta, quinta e sesta categoria, l’interessato confluiva nell’area operativa.
Inoltre, nell’attività di ristrutturazione aziendale, ritenuta antieconomica la gestione diretta dell’attività di manutenzione degli impianti di ripartizione meccanizzata della corrispondenza, la stessa si era poi affidata ad una ditta esterna, e l’interessato veniva tolto dal servizio tecnico di manutenzione apparecchiature, al quale era da tempo addetto, ed assegnato a servizi di sportelleria.
Ad avviso dello stesso ciò avrebbe comportato una sua dequalificazione, e, pertanto, presentava ricorso chiedendo quindi di essere riassegnato alle mansioni precedentemente svolte od altre equivalenti, per avvenuta soppressione, però sempre di natura tecnica, oltre il risarcimento del danno.
La soluzione della Corte
La Corte affrontava la questione rifacendosi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 25033/06, la quale dava un’interpretazione più “elastica” del disposto di cui all’art. 2103 cc, asserendo da un lato che questa norma garantisce la professionalità acquisita dal prestatore di lavoro, sanzionando con la nullità ogni regolamento negoziale o clausola con essa configgente, dall’altro è stato anche affermato che la contrattazione collettiva può introdurre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni nella stessa area per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in una certa qualifica, senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del comma secondo della citata disposizione dell’articolo 2103 c.c..
Pertanto, secondo il Collegio giudicante, in adesione all’indirizzo delle Sezioni Unite, nelle nuova interpretazione dell’articolo 2103 c.c. si deve effettuare un ponderato esame del dato normativo che tenga pure conto dei complessi problemi di riconversione e di ristruttuazìone delle imprese, ed in tale contesto, si ammetta alla contrattazione collettiva di gestire i rapporti lavorativi delle imprese, in ragione delle specifiche situazioni che si possono verificare nelle varie realtà aziendali e territoriali, e che possono richiedere un adeguamento degli organici con una accentuata flessibilità proprio per soddisfare le diverse esigenze sopravvenute in dette realtà.
Nella fattispecie in esame, atteso che il servizio di manutenzione delle apparecchiature era stato esternalizzato dalle Poste, in quanto giudicato antieconomico, con l’adibizione del ricorrente a compiti diversi ma con il mantenimento dello stesso trattamento retributivo, si rendeva necessario gestire le nuove esigenze dell’impresa, che con il coinvolgimento delle parti sociali, si è trovata una soluzione - unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo - che ha attenuato una rigidità che altrimenti sarebbe stata incompatibile con l’introduzione nel ciclo produttivo di innovazioni tecnologiche.
In definitiva, conclude il Collegio, rigettando il ricorso, “alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte – restando immutato il livello retributivo – non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”
Approfondimenti
La questione del c.d. “demansionamento” è uno tra gli argomenti più volte oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina.
Il demansionamento si concreta nella privazione in tutto o in parte delle mansioni.
Invero, sussiste in capo al lavoratore non solo il dovere di espletare le funzioni relative alle proprie mansioni ma, altresì, il diritto di svolgere "un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4 Cost.) nonché il diritto alla tutela della professionalità nel luogo di lavoro, inteso come "formazione sociale ove si svolge la propria personalità" (art. 2 Cost.).
In questo contesto la legge pone dei vincoli, ed, in particolare, con l’art. 2103 cc. si tutela il lavoratore, limitando lo ius variandi del datore di lavoro, cioè il potere di quest’ultimo di modificare unilateralmente la mansioni le mansioni. In altre parole, il baricentro di tale disposizione è la protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro (Cass., sez. un., 24 novembre 2006, n. 25033).
La stessa norma ammette l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse purché equivalenti a quelle svolte, che sono quelle oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e che, soggettivamente, si armonizzano con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendone comunque la dequalifìcazione o la mortificazione (Cass., sez. un., 7 agosto 1998, n. 7755).
Il demansionamento provoca un danno patrimoniale diretto ed immediato per la dequalificazione della capacità professionale del lavoratore, e consiste sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore che dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità ed eventuale perdita di changes (Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572). Può, però, integrare altre forme di danno, al di fuori della sfera patrimoniale, che possono essere ricondotte al danno esistenziale (danno biologico, alla vita di relazione, all’immagine).
Prima del 2006 riguardo la prova del danno vi erano diversi contrasti giurisprudenziali che possono essere ricondotti a tre indirizzi:
Secondo un orientamento dominante, il danno da demansionamento è in re ipsa e quindi non necessita di prova. ( Cass. n. 10157 del 25/6/2004; - Cass. n. 10 del 2/1/2002; Cass. n. 7980 del 27/4/2004; - Cass. n. 7967 del 1/6/2002; Cass. n. 8721 del 29/4/2003; - Cass. n. 13033 del 3/101/2001; Cass. n. 12553 del 27/8/2003; - Cass. n. 14443 del 6/11/2000; Cass. n. 2763 del 22/2/2003; - Cass. n. 11727 del 18/10/1999)
Un altro indirizzo, sostenendo la necessità di una prova specifica, afferma che spetta al lavoratore provare non solo l'attività illecita ma anche l'oggettiva consistenza del pregiudizio che da essa derivi, non potendo confondersi il risarcimento con l'inflizione di una sanzione civile, o pena privata, soltanto quest'ultima conseguente automaticamente alla condotta illecita (Cass. n. 26666 del 6/12/2005; Cass. n. 8904 del 4/6/2003; Cass. n. 6992 del 14/5/2002)
Infine, un terzo filone, intermedio tre i primi due, ammette l'obbligo a carico del lavoratore di provare il danno alla professionalità, anche in via presuntiva e lascia al giudice il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussiste, individuarne la specie e determinarne l'ammontare, eventualmente procedendo ad una liquidazione in via equitativa (Cass., 14.5.2002, n. 6992; Cass., 2.11.2001, n. 13580; Cass., 14.11.2001, n. 14199)
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 6575 del 24/3/2006 si accoglie il secondo indirizzo, in base al quale va fornita da parte del lavoratore la prova la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, ed altresì la prova in concreto del danno, indicandone le aspettative che sarebbero state conseguibili senza il demansionamento.
Nel 2006 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono ancora sul demansionamento con la sentenza 24 novembre 2006 n. 25033, ed in particolare, affrontando la questione (ripresa nella sentenza della Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 05.04.2007 n. 8596) se una "clausola di fungibilità" delle mansioni introdotta dalla contrattazione collettiva sia compatibile, o meno, con il precetto inderogabile posto dal primo comma dell'art. 2103 c.c. che disciplina lo jus variandi.
Al riguardo, l’alto Consesso, ha fornito una risposta positiva, ammettendo che le parti sociali possano legittimamente prevedere nella contrattazione collettiva clausole di fungibilità, collocando plurime e diverse mansioni nella stessa qualifica, senza incorrere nell’ipotesi di nullità prevista dall’art. 2103 cc, potendo così il lavoratore inquadrato in quella qualifica svolgere mansioni diverse ed anche di livello diverso.
(Altalex, 28 maggio 2007. Nota di Gesuele Bellini)
Gesuele Bellini demansionamento interpretato elastico
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 5 aprile 2007, n. 8596
Massima e Testo Integrale
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 5 aprile 2007, n. 8596
(Presidente Mercurio – Relatore Vidimi)
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 1999 avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Verona, Mario N. lamentava che illegittimamente la Spa Poste Italiane lo avesse tolto dal servizio tecnico di manutenzione apparecchiature, al quale era da tempo addetto,ed assegnato a servizi di sportelleria, con conseguente dequalificazione, e chiedeva quindi di essere riassegnato alle mansioni precedentemente svolte (od altre equivalenti,in caso di soppressione, però sempre di natura tecnica), oltre il risarcimento del danno.
Dopo la costituzione del contraddittorio e l’espletamento della prova per testi, il giudice respingeva il ricorso.
A seguito di gravame del Nascimbene, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 21 gennaio 2003, rigettava l’appello e compensava le spese. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale premetteva che il N., assunto con la qualifica di operatore specializzato di officina ed inquadrato nella quinta categoria secondo il previgente contratto, era stato successivamente inquadrato nella sesta categoria, svolgendo in concreto, a partire dal 1995,mansioni di manutenzione meccanica ed elettromagnetica (e molto marginalmente elettronica) degli impianti postali (apparecchiatura e componentistica varia).
A seguito della trasformazione dell’ex amministrazione Poste in Ente Pubblico Economico era stato stipulato, in data 26 novembre 1994, un nuovo contratto nazionale di lavoro che prevedeva l’abolizione delle precedenti categorie e l’inquadramento, al fine di consentire la massima flessibilità gestionale del personale, in sole quattro aree di classificazione, sicchè gli ex dipendenti della quarta,quinta e sesta categoria erano confluiti nell’area operativa. Nell’attività di ristrutturazione aziendale, ritenendosi antieconomica la gestione diretta dell’attività di manutenzione degli impianti di ripartizione meccanizzata della corrispondenza, si era poi affidata alla ditta Elsag Bailey di Genova la suddetta attività.
Con ordine di servizio del 21 luglio 1999 il N. era stato assegnato a Sora e poi in accoglimento di una sua specifica domanda di trasferimento, datata 29 settembre 1999, alla agenzia di Verona.
A fronte di tale realtà fattuale la Corte territoriale osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non rispondeva al vero che il suo trasferimento era stato oggetto di un accordo sindacale relativo alla mobilità collettiva, da ritenersi nullo per « asserita insindacabile discrezionalità del datore di lavoro» atteso che tale accordo faceva riferimento ad altra struttura diversa da quella interna nella quale il Nascimbene era destinato ad operare, se non avesse chiesto il trasferimento a Verona. Inoltre non rispondeva al vero che erano residuati, a seguito della ristrutturazione, ruoli tecnici come quello al quale il suddetto N. era addetto mentre doveva ritenersi che quest’ultimo non aveva subito una riduzione del trattamento retributivo.
Per concludere, nel caso di specie era emerso che, pur essendo le nuove mansioni del N. non equivalenti a quelle precedentemente svolte dallo stesso, queste ultime erano state dimesse o ridimensionate dal datore di lavoro per cui ne conseguiva ‑ come unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ‑ la accettazione di mansioni diverse della stessa area, come liberamente aveva fatto l’appellante dichiarando di accettare la mobilità volontaria.
Avverso tale sentenza Mario N. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la Spa Poste Italiane. Ambedue le parti hanno depositato note difensive.
Motivi della decisione
Con il ricorso il N. propone ricorso violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c. e comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare il ricorrente denunzia che la sola unicità dell’ inquadramento nell’area operativa di Spa Poste Italiane non poteva di per sè essere ostativa alla sussistenza di sostanziali dequalificazioni ove di fatto vi era stata una adibizione a mansioni oggettivamente inferiori a quelle in precedenza svolte. Rimarcava poi il ricorrente che il disposto dell’articolo 2103 c.c. era inderogabile per cui la soluzione presa dal giudice d’appello avrebbe potuto trovare giustificazione solo se il datore di lavoro avesse dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rinvenire in azienda mansioni equivalenti a quelle prima esercitate dal N. e soltanto dopo tale dimostrazione si sarebbe potuto procedere alla dequalificazione.La mera esternalizzazione del servizio di manutenzione degli impianti di corrispondenza non poteva però essere nel caso concreto idonea a soddisfare tutti i bisogni di assistenza tecnica delle numerose altre attrezzature e macchine della società Poste Italiane. In ogni caso dalla documentazione in atti non emergeva in alcun modo che esso ricorrente volesse rinunziare a far valere il suo diritto al riconoscimento della acquisita professionalità, con conseguente rinunzia all’esercizio giudiziario delle proprie ragioni.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con sentenza 25033/06, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno ritenuto che il disposto dell’articolo 2103 c.c., nella formulazione introdotta dallo Statuto dei lavoratori, garantisce la professionalità acquisita dal prestatore di lavoro,e che la violazione della prescrizione del citato articolo è sanzionata dalla nullità di ogni regolamento negoziale o clausola con essa confliggente. Hanno, però, poi affermato che la contrattazione può introdurre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni nella stessa area per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del comma secondo della citata disposizione dell’articolo 2103 c.c..
In particolare i giudici di legittimità hanno evidenziato come le parti sociali possano legittimamente introdurre nella contrattazione collettiva clausole di fungibilità compatibili con l’articolo 2103 c.c., collocando plurime e diverse mansioni nella stessa qualifica, sicché il lavoratore inquadrato in quella qualifica è idoneo, e sa di poter essere chiamato a svolgere, mansioni diverse, in ipotesi anche di livello diverso. Deve, pertanto, considerarsi legittima una clausola che, per contingenti esigenze aziendali (ìl riferimento è alle “necessità di servizio” di cui all’articolo 46 del contratto di categoria), consente al datore di lavoro l’esercizio dello jus variandi indirizzando il lavoratore verso altre mansioni contrattualmente equivalenti. In tal modo le parti sociali finiscono per farsi carico di un’esigenza “collettiva” di estrinsecazione della professionalità dei lavoratori inquadrati nella medesima qualifica.
La dimensione individuale della garanzia dell’articolo 2103 c.c. crea degli steccati che certamente valgono a protezione del lavoratore nei confronti di un indiscriminato jus variandi del datore di lavoro; ma possono rappresentare anche un attrito di resistenza alla progressione professionale della collettività dei lavoratori inquadrati in quella stessa qualifica. Ed allora, se come deve ritenersi in materia , rileva non solo quello che il lavoratore fa, ma anche quello che sa fare (ossia la professionalità potenziale), la contrattazione collettiva può legittimamente farsi carico di ciò, prevedendo e disciplinando meccanismi di scambio o di avvicendamento o di rotazione che non violano la garanzia dell’articolo 2103 c.c., ma che con quest’ultìma sono compatibili.
In questo quadro ricostruttivo può portarsi ad ulteriori sviluppi la giurisprudenza sulle mansioni promiscue e vicarie. Più specificamente la contrattazione collettiva può prevedere che le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza siano costituite dallo svolgimento (promiscuo, appunto) di plurime attività diverse, talune anche con carattere di prevalenza rispetto ad altre (Cassazione, Sezione lavoro, 1987/04; 16461/03), ovvero che le mansioni assegnate comprendano eventualmente anche attività vicarie di diverso livello (Cassazione, Sezione lavoro, 9141/04; 14738/99) analogamente la stessa contrattazione collettiva può introdurre clausole di fungibilità che, verificandosi specifici presupposti di fatto, consentano una mobilità orizzontale tra le mansioni svolte e quelle, pur diverse, rispetto alle quali sussiste un’originaria idoneità del prestatore a svolgerle secondo un criterio di professionalità potenziale per ciò che il lavoratore sa fare, anche se attualmente non fa.
In sintesi, ed in conclusione, va affermato, come principio di diritto, che la contrattazione collettiva se da una parte deve muoversi all’interno, e quindi nel rispetto, della prescrizione posta dal comma 1 dell’articolo 2103 c.c., dall’altra fa però divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e quindi pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale. Le convenzioni delle parti sociali pongono, dunque, legittimi e razionali meccanismi di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni diverse ma con un nucleo di omogeneità ed affinità al fine di sopperire, come detto, a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere in alcuna sanzione di nullità.
In linea con la ratìo delle enunciate statuizioni - cui questa Sezione del lavoro è tenuta ad uniformarsi in ragione dei compiti di nomofilachia rafforzati dal recente D.Lgs 40/2006 e dalla mancata prospettazione di ragioni suscettibili di metterne in dubbio la validità (cfr.al riguardo 374, comma 3, Cpc nel testo novellato) - e sulla strada indicata, quindi, dalla recente decisione delle Su.può procedersi ad una lettura dell’articolo 2103 c.c. più flessibile di quella che, patrocinata da pur autorevole dottrina, è volta ad attribuire una assoluta inderogabilità al disposto dell’articolo 2103 c.c. sul presupposto, di indiscussa vincolatività, che il fondamento della disposizione scrutinata debba essere individuata dal rispetto ‑ nella materia della qualificazione professionale e dell’esercizio delle mansioni ‑ dei principi costituzionali di tutela della dignità umana dei lavoratori e del divieto di discriminazioni, nonchè dei principi generali dell’ordinamento giuridico vigente, che risulta ispirato anche da fonti di diritto internazionale (cfr. al riguardo Corte Costituzionale 103/89).
E’ stato ripetuto più volte che il disposto dell’articolo 2103 c.c.,che pone ‑ come detto - un limite allo ìus varíandi del datore di lavoro, offrendo una tutela contro i provvedimenti unilaterali di quest’ultimo, sancisce la nullità di ogni patto contrario, al fine di eliminare ogni possibilità di elusione del divieto di variazione ín peius delle mansioni del lavoratore e della regolamentazione legale del trasferimento, impedendosi in tal modo con tale sanzione di nullità che attraverso l’adesione del lavoratore interessato al provvedimento unilaterale del datore. di lavoro possa derogarsi al rigido meccanismo di tutela approntato dall’articolo 2103 c.c., anche per quanto riguarda il principio dell’intangibilità della retribuzione(cfr. Corte Cassazione 8125/87, cui adde più di recente tra le altre : Cassazione 16106/03;Cassazione 3683/90).
Come detto, però, una siffatto indirizzo deve essere radicalmente rivisitato alla stregua della più volte citata sentenza delle Su 25033/06, atteso che detta decisione ‑ è opportuno ribadirlo ‑ con l’affermare che attraverso clausole del contratto collettivo si possa legittimare «una fungibilità funzionale tra mansioni diverse al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali», da un lato, legittima una ponderata valutazione della professionalità dei lavoratori ‑ non disgiunta dall’interesse dell’impresa a perseguire un efficace e produttivo assetto organizzativo ‑ e, dall’altro, riconosce al sindacato un potere suscettibile di incidere in modo rilevante sulla stessa gestione dei rapporti lavorativi all’interno delle imprese in momenti qualificanti della vita delle stesse, con l’assunzione di una doverosa responsabilizzazione che ne deve caratterizzare la istituzionale funzione.
Le considerazioni ora fatte inducono a ribadire che una interpretazione dell’articolo 2103 c.c. abbandonando l’ottica di una cristallizzata tutela del “singolo lavoratore” a fronte dello jus variandi dell’imprenditore ‑ debba privilegiare un ponderato esame del dato normativo che tenga pure conto dei complessi problemi di riconversione e di ristruttuazìone delle imprese (che impongono una attenuazione di una rigidità della regolamentazione del rapporto di lavoro capace di ostacolare detti processi) e che, in tale direzione, venga a configurarsi come naturale evoluzione di un indirizzo giurisprudenziale volto ad assegnare alla contrattazione collettiva incisivo rilievo nella gestione dei rapporti lavorativi delle imprese anche nelle sue articolazioni locali, in ragione delle specifiche situazioni che si possono verificare nelle varie realtà aziendali e territoriali, e che possono richiedere un adeguamento degli organici con una accentuata flessibilità proprio per soddisfare le diverse esigenze sopravvenute in dette realtà (cfr. al riguardo per alcune ricadute della contrattazione collettiva nell’assetto delle relazioni industriali, Cassazione, Su, 4588/06).
In verità i diversi passaggi motivazionali della sentenza 25033/06, che inducono ad una globale rivisitazione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali sull’articolo 2103 c.c., con il riconoscere, nella materia in esame alla contrattazione collettiva la possibilità di una identificazione di mansioni fungibili (e tra di esse legittimamente interscambiabili), condizionato la legittimità di detta flessibilità alla circostanza che tra le suddette mansioni si riscontri quantomeno un nucleo di omogeneità ed affinità; condizione questa che non ricorre, di certo, nella
fattispecie in esame per essere stato il N. trasferito da mansioni di tecnico di manutenzione di apparecchiature (del Centro Meccanizzato Primario di Verona) a compiti del tutto differenti, che non consentono una sia pure residuale utilizzazione della sua acquisita professionalità, non avendo le ultime mansioni con quelle spiegate in precedenza alcuna affinità o analogia di alcun genere.
Una tale puntualízzazione, presa in sè, potrebbe indurre a ritenere fondata la domanda del lavoratore ; osta però ad una tale conclusione la doverosa collocazione del surriportato passaggio della ricordata decisione nell’ambito della articolata motivazione, che ne esprime la unificante “ratio” in quella di attribuire il necessario rilievo ad obiettive anche se «temporanee» esigenze delle imprese di attenuare ‑ con il coinvolgimento delle parti sociali ‑ una rigidità altrimenti incompatibile con l’introduzìone nel ciclo produttivo di innovazioni tecnologiche, che sempre più di frequente impongono ristrutturazione e riconversioni aziendali.
A seguito dell’indicato approdo giurisprudenziale sull’articolo 2103 c.c. diviene, dunque, doveroso – per ragioni di nomofilachia cui è tenuta anche questa Sezione lavoro ‑ una interpretazione ben più elastica rispetto al passato della norma codicistica, già patrocinata da autorevole dottrina, e che trova fondamento in una nuova nozione di «capacità professionale» e dí «equivalenza di mansioni», scaturente dalla presa d’atto della necessità di una tutela dinamica delle doti lavorative, da accrescere anche attraverso costanti corsi professionali ormai indispensabili in ragione, proprio, delle continue innovazioni di carattere tecnologico e organizzativo.
Così, la recente decisione delle Sezioni Unite si pone come intervento volto ad autorevolmente confortare quell’indirizzo giurisprudenziale, che in una logica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ha cercato un equilibrio tra il diritto dell’imprenditore ad una gestione razionale ed efficiente delle proprie risorse ed il diritto, anche esso costituzionalmente tutelato, al posto di lavoro, individuando numerose fattispecie di legittima assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori.
Così si sono ritenuti legittimi patti di assegnazione a mansioni di minore rilevanza a garanzia dell’interesse ad evitare il licenziamento (cfr. ex plurimis :Cassazione 10339/04; Cassazione 3827/00; Cassazione 3314/99; Cassazione 9386/93. Contra però 624/84; Cassazione 1026/80) o anche di un diverso interesse del lavoratore (cfr. Cassazione 10793/93 Cassazione 5693/93; Cassazione 6515/88); si è legittimata l’assegnazione unilaterale a mansioni non equivalenti per un limitato periodo di tempo al fine dell’apprendimento di nuove tecniche(cfr. Cassazione 2948/01 che, infatti, ha reputato non configurare inadempimento ‑ ovvero adempimento in contrasto con il requisito della buona fede - l’adibizione temporanea del lavoratore a diverse mansioni, seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza, al fine dell’acquisizione di una più ampia professionalità), ovvero per improrogabili esigenze aziendali (cfr. Cassazione 10187/02) , ovvero ancora per la necessità di limitare le ricadute dannose derivanti da uno sciopero (cfr. Cassazione 9709/02, che ha reputato non configurabile una condotta antinsindacale nel comportamento del datore di lavora che, in concomitazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali, aveva assegnato a mansioni inferiori il personale rimasto in servizio) ; e si è, infine, reputato consentita ‑ in una fattispecie presentante connotati di qualche somiglianza con quella in esame ‑ un mutamento in peius della mansioni a seguito anche di una deliberazione datoriale unilaterale sul presupposto che il divieto di una siffatta variazione, sancito dall’articolo 2103 c.c., non trovi applicazione nel caso in cui vi sia una sopravvenienza che non consenta la conservazione della precedente posizione lavorativa nè lo spostamento a mansioni non pregiudizievoli della professionalità pregressa(cfr. Cassazione 4790/04 in un caso in cui la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte aveva escluso l’applicabilità dell’articolo 2103 c.c. in riferimento alla posizione di un dipendente delle Poste Italiane che, originariamente inquadrato nel quarto livello con la qualifica di pittore, era stato poi addetto alle mansioni di portalettere, appartenenti alla medesima area funzionale, a seguito di ristrutturazione aziendale che aveva comportato la soppressione delle mansioni di pittore).
Nè può sottacersi ‑ al fine di confortare ulteriormente una interpetrazione della contrattazione collettiva e delle sue clausole che voglia risultare rispettosa del criterio letterale e di quello logico‑ sistematico e nello stesso tempo coerente con l’attuale assetto normativo delle relazioni industriali nel settore giuslavoristico ‑che deve assegnarsi, nell’opera ermeneutica, il dovuto rilievo alla considerazione che la ricerca di un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco risulta sottesa ad ogni intervento legislativo in materia, si da costituirne l’elemento unificante, come è attestato in maniera palmare da numerose norme, quali quelle riguardanti le lavoratrici madri, che durante il periodo di gestazione e sino a sette mesi dopo il parto ‑ se il tipo di attività o le condizioni ambientali ‘sono pregiudizievoli alla loro salute ‑ devono essere spostate ad altre mansioni anche inf eriori a quelle abituali, conservando la retribuzione precedente (cfr. articolo 7, comma 5, D.Lgs 151/01); quella relativa ai lavoratori divenuti inabili durante il rapporto lavorativo, che possono essere licenziati solo se risulti impossibile adibirli in mansioni disponibili in azienda, anche se non equivalenti, con la conservazione del trattamento della precedente qualifica(cfr. articolo 1, comma 7, legge 68/1999) ; ed infine ‑ in modo ancora più significativo in considerazione di quanto interessa in questa sede ‑ quella attinente i lavoratori esuberanti, il cui lícenziamento può essere evitato proprio attraverso un accordo collettivo che permetta loro di essere adibiti a mansioni anche inferiori alle precedenti ai fini della conservazione nel posto di lavoro(cfr. articolo 4, comma 11, D.Lgs 223/91).
Corollario di quanto sinora detto è la conferma della impugnata sentenza.
Ed invero, la Corte d’appello di Venezia, dopo avere accertato sulla base delle risultanze istruttorie, che il servizio di manutenzione delle apparecchiature era stato esternalizzato dalle Poste, perchè ritenuto antieconomico, con l’adibizione dell’attuale ricorrente (e di quanti erano addetti al suddetto servizio) a compiti diversi con il mantenimento da parte del N. dello stesso trattamento retributivo, ha evidenziato, poi, come da tale decisione ne scaturiva come unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’accettazione di mansioni diverse da parte del N., che ben era a conoscenza della ristrutturazione aziendale ed era consapevole che le sue precedenti mansioni « erano in via di esaurimento per l’esternalizzazione delle stesse e comunque che i posti disponibili erano quelli di sportelleria ai del principio di diritto che può enunciarsi nei seguenti termini: «La disposizione dell’articolo 2103 c.c. sulla regolamentazione delle mansioni del lavoratore e sul divieto del declassamento di dette mansioni va interpretata ‑ stante le statuizioni di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 25033/06, ed in coerenza con la ratio sottesa ai numerosi interventi in materia del legislatore ‑ alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte – restando immutato il livello retributivo – non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo». Per concludere, il ricorso del Nascimbene va, come detto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi ‑ tenuto conto della natura della controversia e della questioni trattate in relazione alle quali non sono mancati anche in giurisprudenza contrasti ‑ per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2007.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5 APRILE 2007.
Cassazione: lavoratore demansionato merita risarcimento consistente se c'è mortificazione lavorativa
I danni da demansionamento vanno risarciti con importi adeguati. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno considerato troppo basso il risarimento riconosciuto dai giudici di merito a un dirigente del pubblico impiego per la frustrazione professionale subita. Dopo un ordine di servizio che lo aveva assegnato a mansioni di minor livello il lavoratore era stato posto nell'arco di pochi mesi in una condizione di quasi "quasi totale inattivita' e al disimpegno di compiti mortificanti" tanto che ne erano seguiti disturbi di natura psicosomatica che lo avevano indotto al pensionamento. In primo grado il Tribunale gli aveva riconosciuto un risarcimento di circa 17mila euro oltre 2mila euro per differenze retributive. La Corte d'Appello però aveva ridotto il risarcimento alla somma complessiva di soli 4mila euro Troppo poco per essere accettata dal dirigente che rivolgendosi alla Supremna Corte ha evidenziato come "la vissuta e credibile mortificazione accertata dalla stessa sentenza avrebbe dovuto comportare la configurazione di danno da mobbing anche a prescindere dal demansionamento e da uno specifico intento persecutorio". Piazza Cavour (sentenza 4063/2010) ha accolto il ricorso del dirigente rinviando il caso alla Corte d'appello di Bologna che dovra' ora accordare un risarcimento più elevato. Nella parte motiva della sentenza la Corte osserva che "l'esistenza del demansionamento e' stata accertata dai giudici di merito in base ad una ricostruzione puntuale dei compiti affidati al dipendente dopo la sua assegnazione alla sede della direzione provinciale sino alla cessazione del rapporto per pensionamento". Sarebbe oltretutto emersa la "sostanziale privazione di mansioni" ai danni del lavoratore che, per "caratteristiche, durata, gravita' e frustrazione professionale", e' stata esattamente identificata "negli aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti dalla situazione lavorativa in cui si trovo' ad operare".(Data: 25/02/2010 10.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)
Cassazione: risarcimento del danno per demansionamento e mobbing
La Corte di Cassazione, sezioni Unite, con sentenza nr. 4063 del 22 febbraio scorso ha stabilito che quando il demansionamento comporta disturbi di natura psicofisica relativi alla salute del lavoratore, lo stesso sfocia nel mobbing con relativo diritto del dipendente frustrato a ottenere un adeguato risarcimento per il demansionamento subito.
Tale condotta lesiva, può prefigurarsi anche da parte di una Amministrazione Pubblica allorquando a quest’ultima sia imputabile la violazione di specifici obblighi di natura contrattuale ex art. 2087 del c.c.
Il fatto ha riguardato un impiegato amministrativo dell’Inps che dal 1996 al 1999 aveva, di fatto, guidato il suo ufficio (venendo anche nominato “reggente ad interim”) ma che, successivamente, veniva trasferito all’Ufficio Provinciale e costretto ad una quasi totale inattività e al disbrigo di compiti mortificanti (addetto alle informazioni generali sulle competenza della DPL e addetto al protocollo) per di più, collocato in un ufficio minuscolo, sprovvisto anche di computer, tanto da essere colpito da disturbi di natura psico – somatica che lo avevano costretto al pensionamento
Il dipendente aveva ottenuto il riconoscimento di una cospicua somma in primo grado, drasticamente ridotta dai giudici di appello.
La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore mobbizzato, ha dato il via a un risarcimento da «mortificazione professionale» aumentando nuovamente la somma risarcitoria, in considerazione “della persistenza del comportamento lesivo di circa due anni ( sia pure in mancanza di intenti di discriminazione o di persecuzione idonei a qualificarlo come mobbing), la lunga durata di reiterate situazioni di disagio professionale e personale, consistite tra l’altro, nel dover operare in un locale piccolo, fatiscente e privo di computer nonchè, per “l’inerzia dell’amministrazione, rispetto alle accertate richieste del dipendente intese a non compromettere il patrimonio di esperienza e qualificazione professionale, che costituiva un suo primario diritto a prescindere dall’esistenza di specifiche aspettative di carriera”.
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
Ricorso per demansionamento: fondamenti teoriciIl divieto di demansionamento e la possibilità di reagire alla sua violazione trova fondamento nel principio che la qualifica della propria mansione sia un diritto soggettivo del lavoratore. Questo perchè la mansione è collegata alla professionalità del lavoratore che non può essere per nessun motivo danneggiata perché, come ha affermato la Corte Costituzionale con sentenza del 2004: Tale danneggiamento provoca compromissione delle aspettative del lavoratore, danni alla persona e alla sua dignità. Viene accolta, così, a livello Costituzionale, una concezione del lavoro come attività che concorre al progresso materiale e spirituale della società di cui il divieto di demansionamento è garante.Ricorso per demansionamento: inderogabilità del divietoIl divieto può essere derogato solo in quei casi, che proprio per la loro natura sono possibili, perché tutelano il lavoratore in situazioni in cui la sua capacità a svolgere determinate mansioni è diminuita o è a rischio il posto di lavoratore stesso prevalendo così l’interesse alla conservazione del posto di lavoro. Le deroghe sono infatti nei casi in cui:- si è in presenza di esigenze straordinarie- è imposto al datore di lavoro di adibire le lavoratrici in gestazione e fino a sette mesi dopo il parto a mansioni non pregiudizievoli per la sua salute e quindi anche a mansioni inferiori (art 3 L 1204/71)- ci siano lavoratori eccedenti che devono essere riassorbite secondo le modalità previste in un accordo sindacale che lo preveda.Ricorso per demansionamento: mansioni equivalentiAl datore di lavoro che, per esigenze organizzative, abbia l’esigenza di adibire il lavoratore a mansioni diverse rimane la facoltà di assegnarlo a mansioni equivalenti.. La determinazione del concetto di equivalenza non è sempre agevole. La giurisprudenza tende a fare questa valutazione in termini di professionalità, intendendosi così, per equivalenti, quelle mansioni che necessitino per il loro svolgimento l’utilizzo delle abilità e esperienze acquisite dal lavoratore e che fanno parte del suo bagaglio professionale. Non è sufficiente perciò una equivalenza retributiva e/o un’astratta equivalenza dell’inquadramento contrattuale per escludere il demansionamento e quindi per ritenere non fondato il ricorso.Ricorso per demansionamento: mansioni superioriPer quel che concerne l’assegnazione a mansioni superiori essa comporta un automatico e definitivo avanzamento di carriera se viene protratta per più di tre mesi a meno che non sia previsto un termine inferiore nei contratti collettivi. Per quanto attiene ad inquadramenti caratterizzati da responsabilità e autonomia decisionali, tuttavia, il lavoratore che volesse dare prova di un’assegnazione a mansioni superiori e volesse vedersi riconosciuta la maggiore qualificazione deve dare prova non solo delle mansioni che adduce di aver svolto ma anche di essere stato assegnato alle responsabilità e attribuzioni proprie della qualifica rivendicata. Fa eccezione alla regola dell’automatico avanzamento di qualifica per mansioni superiori il caso in cui tale assegnazione sia avvenuta per sostituire un lavoratore in malattia. In questo caso infatti, per non pregiudicarne il diritto del lavoratore sostituito di ritornare al proprio posto, la disposizione non è operativa. Inoltre, nel caso che la sostituzione diventi definitiva, il computo per la promozione decorre, non dal momento in cui la sostituzione è avvenuta, ma solo dal momento in cui si è generata la causa che l’ha resa definitiva.Ricorso per demansionamento: diminuzione quantitative delle mansioni e inattivitàSi è ritenuto che esistano gli estremi del demansionamento anche qualora le mansioni non siano state modificate ma vengano quantitativamente ridotte. Tale riduzione deve essere, però, in grado di abbassare il livello delle prestazioni del lavoratore impoverendo conseguentemente la sua professionalità. Ciò va valutato in relazione alla natura e alla portata della riduzione, e all’incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione in azienda (in tal senso, tra le altre, Cass. Sez lavoro 20 marzo 2004 n.5651). Costituisce violazione del divieto ex art 2103, senza dubbio, anche il caso in cui il lavoratore tenga il dipendente in forzata inattività alla luce del principio sopraenunciato che il lavoro non costituisca solo fonte di guadagno ma anche modo di espressione della persona umana.Ricorso per demansionamento: finalitàIl ricorso è mezzo attraverso cui il giudice viene chiamato ad accertare la violazione del divieto di demansionamento che costituisce, infatti, inadempimento contrattuale del datore di lavoro e che, una volta accertato, comporta:- la condanna del datore al ripristino della situazione precedente con obbligo per questo di reintegrare il lavoratore nella posizione precedente o in una equivalente;- l’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, ove il livello della retribuzione stessa sia stato, medio tempore, diminuito;- l’obbligo di risarcimento del danno eventualmente provocato con il demansionamento.Ricorso per demansionamento: risarcimento del dannoLa risarcibilità del danno e delle componenti che vanno valutate in relazione al danno (qualora esso ci sia) e che vanno risarcite a seguito del demansionamento sono state oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale sul quale sembra avere messo la parola fine la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 6572/2006. La Cassazione in questa sede ha infatti affrontato analiticamente la questione del danno da professionalità specificandone in modo preciso il contenuto. Il danno da demansionamento può assumere aspetti diversi, ha specificato la Suprema Corte. Esso può consistere, infatti, in un danno patrimoniale derivante in via diretta ed automatica dalla dequalificazione della capacità professionale del lavoratore e dalla mancata acquisizione di capacità maggiori con probabile perdita addizionale di un maggior guadagno. E può comporsi anche di aspetti non patrimoniali riconducibili alla più generale categoria del cd danno esistenziale. Esso si può a sua volta comporre di più parti come il danno all’integrità psicofisica o danno biologico, il danno all’immagine o alla vita di relazione . Ricorso per demansionamento: onere della provaLa suddetta sentenza ha anche chiarito che, proprio in virtù della complessità del danno, si rende necessaria una specifica allegazione, a fini probatori, da parte del lavoratore. Il danno, se c’è, deve essere specificatamente dimostrato in tutte le sue componenti. Il lavoratore deve fornire la prova della effettiva perdita di chance per quel che riguarda le aspettative di carriera che avrebbe avuto se il demansionamento non fosse avvenuto. Deve dimostrare la dequalificazione e che ciò abbia inciso negativamente nella sua sfera lavorativa privata e familiare cambiando il suo stile di vita e alterando il suo equilibrio. Mentre il danno biologico può essere semplicemente provato attraverso l’allegazione della certificazione medica che attesti una lesione dell’integrità psicofisica o mediante C.T.U., per ciò che concerne il danno esistenziale, è necessario allegare fatti e prove che dimostrino il rapporto di causalità tra il deterioramento della vita sociale e familiare e il demansionamento stesso. Tale dimostrazione, che può essere fornita attraverso prove testimoniali e documentali, può procedere anche per presunzioni. Ricorso per demansionamento: criteri di liquidazione del danno alla professionalitàPer ciò che concerne la quantificazione del danno alla professionalità e la sua liquidazione, la giurisprudenza di merito ha fatto ricorso, come parametro di riferimento, alla retribuzione del lavoratore demansionato. La scelta di tale parametro e della percentuale da applicare alla base retributiva, che viene comunque fatta dal giudice, tiene conto delle circostanze che delineano il caso concreto. A questo riguardo possono essere considerati, quali presupposti rilevanti: la durata del demansionamento, l’anzianità del dipendente il livello professionale conseguito.
Ricorso per demasionamento:eccezione di inadempimentoIl lavoratore demansionato può rifiutarsi di svolgere le mansioni inferiori in virtù del principio di eccezione per inadempimento di cui all’art 1460 c.c. proprio alla luce del fatto che il demansionamento costituisce un inadempimento contrattuale del datore di lavoro nei confronti del lavoratore( a riguardo Cass. sez. lav. 23-11-1995 n.12121). Tale rifiuto non costituisce perciò una violazione in grado di generare una responsabilità disciplinare purchè tale reazione risulti proporzionata e conforme a buonafede.Questo requisito è soddisfatto quando il lavoratore rifiutatosi di svolgere le mansioni inferiori alla sua qualifica si mostri comunque disponibile a continuare a svolgere le proprie mansioni o mansioni equivalenti. Il rifiuto non può quindi spingersi fino alla cessazione totale della attività perché questa costituirebbe una inammissibile forma di autotutela anche alla luce del fatto che il datore non è totalmente inadempiente se continua ad assolvere ai suoi obblighi retributivi( Cass. Civ. sez. lav. 07-02-1998 n.1307). Se vengono soddisfatti questi requisiti di proporzionalità e buonafede quindi l’eventuale licenziamento del lavoratore derivante dal rifiuto di eseguire le mansioni inferiori, dovrà ritenersi illegittimo.Ricorso per demansionamento: procedimento ordinarioPer contrastare una situazione di demansionamento pregiudizievole, è certamente possibile agire giudizialmente chiedendo di essere adibiti alle stesse o a mansioni di contenuto equivalente a quelle svolte prima del perpetrarsi del demansionamento stesso. E’ anche possibile agire per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa dell’illegittima condotta datoriale. In via ordinaria è necessario, in via preliminare, avanzare istanza di convocazione della Commissione di Conciliazione delle controversie individuali del lavoro presso la Direzione Provinciale del lavoro competente. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione ovvero, qualora decorso il termine di sessanta giorni della presentazione dell’istanza il tentativo di conciliazione ancora non sia stato espletato, il lavoratore potrà proporre ricorso al Tribunale Civile in funzione di Giudice del Lavoro.Ricorso per demansionamento: procedimento d’urgenzaQuando, per il solo fatto del demansionamento, può generarsi un pregiudizio irreparabile e qualora ricorrano i requisiti del fumus bonis iuris, è possibile reagire giudizialmente attraverso il procedimento d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c. In tal caso non è necessario preliminarmente svolgere il tentativo di conciliazione. La irreparabilità del pregiudizio è ravvisabile qualora si sia in presenza di una lesione di diritti di natura strettamente personale quali l’elevazione e la formazione professionale soggetti a rapido danneggiamento. E’ quanto accade quando, ad esempio, per il tipo di mansione cui il lavoratore risultava inizialmente adibito, si possa verificare una rapida obsolescenza della professionalità in quanto l’attività lavorativa sia strettamente legata alle tecnologie che si evolvono rapidamente. Per verificare se le ragioni d’urgenza che giustificano il procedimento ricorrano, bisogna avere riguardo, però, non già dell’inizio del demansionamento ma al momento in cui il pregiudizio rischia di divenire irreparabile. Non si può contestare, perciò, la legittimità del procedimento cautelare alla luce del fatto che il demansionamento si protragga già da molto tempo se sono sopraggiunti fatti che hanno aggravato il rischio che il danno sia irreparabile.
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 23.09.2010 n° 34375 patrocinio infedele
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 23.09.2010 n° 34375
Per aversi infedele patrocinio non è necessario che sia ancora aperto il giudizio. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza 23 settembre 2010, n. 34375 attraverso la quale affinché la condotta del legale possa essere considerata infedele non si richiede che la medesima si concretizzi attraverso atti o comportamenti processuali.
In tal modo gli ermellini rigettano il ricorso presentato dall’avvocato Tizio avverso la decisione con cui i giudici territoriali gli avevano confermato la condanna per infedele patrocinio nei confronti di alcuni clienti.
Tizio, in particolare, era stato ritenuto responsabile per aver omesso di portare a esecuzione una sentenza favorevole ai patrocinati nell'ambito di un giudizio diretto a far dichiarare l'illegittimità di una concessione edilizia rilasciata dall'autorità comunale a dei soggetti contro-interessati.
Il legale, dopo aver inviato al sindaco una diffida ad adempiere, aveva successivamente revocato detto atto comunicando l'avvenuta bonaria composizione della controversia e paralizzando, di fatto, l'effetto della diffida.
Secondo il difensore, nel momento dell'emissione della sentenza si era esaurito il rapporto giudiziario pendente tra le parti. Di conseguenza, in assenza della pendenza del giudizio, non poteva configurarsi alcuna ipotesi di patrocinio infedele a suo carico.
Secondo quello che è l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale dominante, orientamento richiamato dal giudice nomofilattico nella sentenza che si annota, “la fattispecie di cui all'art. 380 c.p. configura un reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore", qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, sicché, ai fini della integrazione del reato in esame, non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, essendo necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, poiché l'attività del patrono infedele è assunta per scelta del legislatore come lesiva dell'interesse tutelato solo nel momento dell'esercizio effettivo della giurisdizione”
Questo non significa che la condotta dell’infedele patrocinatore si debba concretizzare necessariamente mediante atti o comportamenti processuali, perché ciò non è richiesto dalla norma incriminatrice, la quale si riferisce unicamente al fatto del patrocinatore che si rende infedele ai propri doveri professionali; ci si riferisce, quindi, ad una condotta che si può estrinsecare, eventualmente, anche al di fuori del processo.
“Ne è riprova la fattispecie aggravata considerata dal n. 1 del comma 2, che perfettamente si attaglia al caso di specie, contestata in imputazione, che prevede che il fatto sia commesso colludendo con la parte avversaria. Il patrocinatore che realizza, a latere del processo, le condizioni di fatto perché il suo assistito non ottenga il risultato processuale auspicato è non meno colpevole di chi ometta volontariamente di svolgere le opportune iniziative processuali a sostegno delle ragioni del cliente”.
(Altalex, 11 ottobre 2010. Nota di Simone Marani) infedele patrocinio giudizio concluso Simone Marani
");
//]]>-->
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 7 luglio - 23 settembre 2010, n. 34375
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ribadiva la responsabilità per il delitto aggravato di infedele patrocinio dell'avv.to L., affermata con pronuncia del l'8 maggio 2007, di quel Tribunale e ne confermava anche il trattamento sanzionatorio.
Escludeva in primo luogo che il reato fosse prescritto; calcolava tutte le sospensioni subite dal procedimento e determinava la possibile estinzione alla data del 16 dicembre 2010. Rigettava nel merito il gravame, ripercorrendo la vicenda, che in breve può essere compendiata nell'avere il L., difensore in un procedimento amministrativo, volto a far dichiarare la illegittimità della concessione edilizia dalla amministrazione comunale di ****, rilasciata alla Dolceria ****, dei contro interessati C.A., G. ed An., R. M.E. e D.N.F.A., ometteva di portare ad esecuzione la sentenza pronunciata dal Tar di Lecce in data 15 luglio 1997, favorevole ai suoi assistiti; inviata in data 18 novembre 2000 al Sindaco una diffida ad adempiere alla demolizione del manufatto realizzato dalla controparte, in data 21 dicembre 2000 il L. revocava l'atto, comunicando la avvenuta bonaria composizione della controversia da parte dei C. e la rinuncia al mandato conferitogli dalla R. e dalla D.N.; in realtà, egli si era accordato con il proprietario della Dolceria ****, che gli aveva dato L. 37.000.000 di cui L. 12.000.000 per le spese legali e L. 25.00.000 per paralizzare gli effetti della diffida; le due assistite, che in corso di trattative avevano manifestato la volontà di ottenere la demolizione del manufatto, non erano state avvisate dell'operazione in corso ed era stato solo loro comunicata, un giorno prima della revoca della diffida, la rinunzia al mandato. Il giudice distrettuale, individuate le violazioni del codice deontologico e la non necessità del conferimento di un apposito mandato per la esecuzione della sentenza del Tar, ravvisava i presupposti del delitto contestato, giacchè era pendente un giudizio, affidato al patrocinio del L., nel cui ambito, dunque, egli aveva compiuto atti a detrimento delle sue assistite, di cui non aveva coltivato l'interesse alla demolizione ed aveva così pregiudicato la soddisfazione delle loro pretese sia perchè esse pativano la permanenza del manufatto, sia perchè di fatto le aveva escluse dalla monetizzazione della transazione, sia perchè aveva inciso sul giudizio innanzi al consiglio di stato, consentendo il consolidarsi della nuova situazione. Riteneva esattamente negate le generiche e confermava le statuizioni in favore della due donne, costituite parti civili, con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese.
Con il ricorso presentato dal difensore nell'interesse del L., viene in primo luogo eccepita la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, essendo stato concesso al difensore nominato in udienza dal L., in sostituzione di quello revocato, il termine a difesa di gg. 8 e poi, sostituito ex officio quello di fiducia con altro reperito in udienza, per svolgere la difesa in attesa del decorso del termine ex art. 107 c.p.p., il collegio aveva immediatamente introitato la causa a sentenza. Il ricorrente si duole e che non sia stato concesso analogo termine al difensore reperito in udienza e che il sistema adottato sia un atto di pura creazione giudiziale.
Con il secondo motivo insiste per la declaratoria di prescrizione del reato, contestando i periodi di sospensione del termine estintivo, come ritenuti dai giudici di merito; con il terzo nega che la configurabilità del delitto in esame, perchè tra le parti non vi era in atto alcun processo in corso innanzi al Tar.
Con i motivi personalmente presentati, l'avv.to L. (in data 26.2.2010) aderisce al quello inerente alla nullità della sentenza e denuncia la illogicità della motivazione, al pari di quanto già esposto dal difensore, per avere ritenuto vigente un rapporto di difesa, dato che il Tar di Lecce aveva emanato una sentenza che aveva definito il rapporto giudiziario pendente tra le parti, da lui assistite ed i loro contraddittori. La motivazione aveva dato atto che le due odierne p.o. erano assistite da altro difensore presso il Consiglio di Stato, epperò illogicamente aveva affermato che pur essendo oggetto del mandato conferitogli in precedenza l'interesse ad ottenere la demolizione, e che nel caso della sentenza esecutiva non occorreva alcun nuovo mandato, esso difensore avrebbe dovuto comunque farsi rilasciare la procura necessaria per esperire i rimedi processuali a ciò opportuni; inoltre la Corte non aveva considerato che a seguito della nuova concessione edilizia rilasciata alla Dolceria Marinucci nessun danno era stato cagionato ai due rappresentati, poichè la PA consentiva il mantenimento dell'edificio realizzato. I motivi concernenti la prescrizione del reato sono sovrapponibili a quelli del difensore; in aggiunta per il rinvio dal 27 febbraio al 22 maggio 2009 eccepisce che deve prevalere l'impedimento del giudice e non quello della difesa, con conseguente erroneo computo; con il 4^ motivo lamenta violazione di legge nella valutazione delle parti offese, per l'erronea individuazione dell'aggravante e per la negazione delle generiche; impugna, ancora, la liquidazione delle spese perchè priva di specificazione.
Tutti i detti profili di gravame sono stati ripresi ed ulteriormente illustrati con memoria depositata il 21 giugno 2010, con particolare riguardo alla prescrizione maturata ed alla struttura del reato in esame.
Motivi della decisione
Il ricorso è da rigettare.
1. Non ha pregio l'eccepita violazione del diritto di difesa.
Sul punto occorre innanzi tutto rilevare che la norma di cui all'art. 108 c.p.p., che regola la concessione di un termine al difensore "nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono", non prevede alcun termine entro il quale l'evento posto a base dell'istanza di termine a difesa debba verificarsi; e pertanto siffatto diritto sorge in capo all'imputato anche nell'ipotesi che la nomina di nuovo difensore, con revoca del precedente, sia intervenuta nella immediatezza della celebrazione del giudizio, posto che in ogni caso siffatta evenienza determina obiettivamente una compromissione del diritto di difesa alla quale il legislatore ha ritenuto di porre rimedio attraverso l'istituto della concessione del termine a difesa, termine la cui congruità deve essere rapportata alla complessità del processo.
Posto ciò osserva ulteriormente il Collegio che il diniego di concessione di detto termine, in violazione dell'art. 108 c.p.p., integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, sicchè deve essere dedotta entro il termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, e quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo costituito, nell'ipotesi in questione, dal provvedimento del giudice che denegava la concessione del termine (Cass. sez. 1, 20.5.2003 n. 25325; Cass. sez. 5, 7.5.2004 n. 26650), essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 c.p.p. e segg. (Cass. sez. 5, 7.3.2002, B., rv. 221685). Orbene, nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la difesa, alla predetta udienza dell'11 dicembre 2009, dopo il sostanziale diniego della concessione del termine,- posto che con il meccanismo adottato la Corte ha praticamente negato che il difensore di fiducia potesse godere del termine di gg 8 investendo d'ufficio della difesa altro professionista, presente in aula e invitandolo a concludere -, non ebbe ad eccepire siffatta nullità, di talchè devono ritenersi verificate le sanatorie o preclusioni di cui al predetto art. 182 c.p.p.. Nè può sul punto obiettarsi che nessuna eccezione poteva essere sollevata dal difensore d'ufficio, in forza della considerazione che a costui ex art. 97 c.p.p. non spetta analogo termine, dato che era comunque onere dello stesso eccepire la irritualità dell'ordinanza, che di fatto vanificava la concessione del termine a quello di fiducia.
2. Nel merito il ricorso non ha fondamento.
Va in primo luogo osservato che la condotta contestata rientra appieno nel paradigma dell'art. 380 c.p..
Non è qui in discussione il consolidato, e comunque prevalente, orientamento giurisprudenziale e dottrinale per il quale la fattispecie di cui all'art. 380 c.p. configura un reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore", qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, sicchè, ai fini della integrazione del reato in esame, non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, essendo necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, poichè l'attività del patrono infedele è assunta per scelta del legislatore come lesiva dell'interesse tutelato solo nel momento dell'esercizio effettivo della giurisdizione (Sez. 6A, 21 ottobre 2004, Ariis; Sez. 6A, 28 marzo 2201, Achille; Sez. 6A, u.p. 19 maggio 1998, Bove; Sez. 6A, u.p. 8 luglio 1997, Chiaberti; Sez. 6A, u.p. 28 marzo 1995, Layne; Sez. 3A, u.p. 19 dicembre 1978, Abeatici). Militano in tal senso diversi argomenti: in primo luogo, la lettera della norma, secondo la cui la condotta tipica è presa in considerazione in quanto si realizzi attraverso una assistenza o rappresentanza "dinanzi all'Autorità giudiziaria"; in secondo luogo, la nozione di patrocinatore - necessario soggetto attivo del reato - che non può assumere formale riconoscimento se non nell'ambito di una procedura giudiziaria; in terzo luogo, il bene tutelato dalla norma, che va individuato nell'interesse al regolare funzionamento della amministrazione della giustizia (che sarebbe pregiudicato da comportamenti sleali da parte dei patrocinatori), e solo accessoriamente (o, se si vuole, contestualmente) nell'interesse del cliente (v. in tal senso, Rel. Prog. Def., p. 177).
Ciò non significa, peraltro, che la condotta infedele del patrocinatore debba concretarsi necessariamente attraverso atti o comportamenti processuali, perchè ciò non è richiesto dalla lettera della norma, che si riferisce solo al fatto del patrocinatore che si rende "infedele ai suoi doveri professionali", e quindi a una condotta libera, eventualmente anche estrinsecantesi al di fuori del processo.
Ne è riprova la fattispecie aggravata considerata dal n. 1 del comma 2, che perfettamente si attaglia al caso di specie, contestata in imputazione, che prevede che il fatto sia commesso "colludendo con la parte avversaria". Il patrocinatore che realizzi, a latere del processo, le condizioni di fatto perchè il suo assistito non ottenga il risultato processuale auspicato è non meno colpevole di chi ometta volontariamente di svolgere le opportune iniziative processuali a sostegno delle ragioni del cliente. Nel caso di specie, non è dubbia la pendenza di un giudizio in cui le parti erano rappresentate dal L.; basta al riguardo por mente che, ottenuta in favore dei suoi assistiti una sentenza favorevole emessa dal Tar nel 1999 era pendente il procedimento innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla resistente - condannata -, Dolceria ****, e che comunque per la esecuzione della sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva, non era necessario un apposito mandato per il giudizio di ottemperanza, essendo bastevole quello ampio ed omnicomprensivo conferito in prime cure. Il rinvio ad un dato formale, in cui si sostanzia la censura (non collocabilità della condotta incriminata nell'ambito di una procedura giudiziaria) non ha, quindi, alcun valore, perchè era in corso una procedura esecutiva a completamento della giudiziaria, tant'è che lo stesso L. riteneva sussistente il rapporto con le parti, per le quali sia aveva posto in essere le preliminari iniziative (atto di diffida al Comune) nei confronti di una delle controparti, quella pubblica, per l'adempimento, sia aveva avviate le trattative per addivenire ad un bonario componimento con quella privata (la convenuta Dolceria), con evidente intento di un ritorno economico.
Nell'ambito, dunque, di una attività connessa ad un procedimento, come esattamente messo in rilievo dalle pronunce di merito, il comportamento tenuto nei confronti della R. e della D.N. è stato marcato da uno sviamento dai canoni deontologici professionali.
Il L., invero, con la comunicazione inviata all'autorità comunale, dal lessico volutamente ambiguo, in quanto riferibile genericamente alla vicenda in atto, senza una chiara distinzione delle posizioni soggettive diversificate, che le parti avevano assunto nel corso delle trattative con il M., ha enunciato la mancanza di interesse dei signori C. per la intervenuta definizione della vicenda e la rinunzia da parte sua al mandato conferitogli dalle altre due assistite, ed ha concluso con l'invito esplicito all'autorità comunale di voler considerare l'atto di diffida a demolire "come mai pervenuto con conseguente messa nel nulla di qualsivoglia effetto giuridico". Il risultato sperato, ossia la paralisi delle iniziative nei confronti dell'ente comunale, tale da consentire a questa di potere rinnovare, come nella specie avvenuto, la concessione edilizia in favore della Dolceria (OMISSIS), è stato altresì preceduto dall'accordo diretto tra difensore e convenuto, che a tale fine gli ha versato un congruo compenso, come risulta dalla ricostruzione della vicenda operata da giudici di merito e di fatto neanche contestata dal ricorrente.
Una volta accertata la detta condotta, è evidente che la stessa è stata immediatamente produttiva di una lesione del rapporto di fiducia intercorrente con le patrocinate e del conseguente nocumento agli interessi di queste. Infatti, la sleale operazione, ancorchè dissimulata con la rinunzia al mandato, che è stata comunicata alla R. ed alla D.N., solo il giorno prima dell'invio della rinunzia alla diffida al Comune, è stata, invero, condotta in costanza di rapporto professionale ed in concreto il L. non ha dato alle stesse le notizie e le informazioni che avrebbero consentito loro di reimpostare la strategia sia extraprocessuale che processuale, così cagionando un danno.
E' invero pacifico che l'evento di danno, e quindi il nocumento agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, non va inteso nel senso civilistico e quindi non è necessario che si verifichi un pregiudizio patrimoniale, potendo essere integrato, come nel caso in esame, nella non adozione di contromosse, determinate dalla non conoscenza dello stato delle cose, imputabile alla mancanza di complete informazioni.
Non possono trovare ingresso poi le censure relative alla violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione delle testimonianze delle due parti offese; invero sotto tale veste il L. introduce una diversa ricostruzione di fatti, che viceversa sono stati analizzati adeguatamente dalla Corte di Appello e, logicamente valutati, sono stati ritenuti irrilevanti per la prospettata ipotesi alternativa. Esula, in particolare, dal controllo di questa Corte la interpretazione che i giudici di merito hanno dato alla corrispondenza scambiata da una parte offesa, la D.N., con l'avvocato L.; in particolare, l'analisi del contenuto della missiva con cui costei annunciava la intenzione di non aderire alla proposta transattiva appare priva di evidenti salti logici, e condotta con buon metodo inferenziale, con una lettura complessiva delle proposizioni formulate dalla parte; sicchè la conclusione cui è pervenuta la Corte, ossia il fatto che la D.N. non avesse revocato il mandato al professionista, ma solo escluso che costui potesse impegnarsi per un accordo, è una ipotesi di merito plausibile ed insindacabile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E).
Non ha, poi, pregio il denunciato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 380 cpv. c.p., n. 1, atteso che la sentenza si è diffusamente impegnata nel corso del suo iter argomentativo ad individuare le ragioni e le modalità dell'accordo intervenuto con il M., e del pagamento da costui effettuato al L. per indurlo a rinunziare alla diffida ad adempiere; il ricorrente non pone peraltro specifiche censure, estrapolando passi della motivazione di cui deduce la illogicità, che invece sono inesistenti avuto riguardo al tenore complessivo dello sviluppo motivazionale. E', infine, da sottolineare che la data commissione del reato è da individuare nel (OMISSIS), ossia nel momento in cui è stata posta in essere la condotta infedele e non può affatto retrodatarsi al momento della pronuncia della sentenza del Tar atteso che il momento consumativo non può essere confuso con quello della esecutività della decisione, ma come detto va riferito alla effettiva deviazione del patrocinatore dal canone di fedeltà e lealtà nell'esercizio del mandato.
3. Parimenti infondata è la eccezione di estinzione del reato per prescrizione. Escluso innanzi tutto che possa tenersi conto della proposta retrodatazione della consumazione del delitto, non ha ragione d'essere il primo rilievo, relativo all'asserito computo in numero di giorni maggiore ai 60 per l'impedimento legittimo del difensore, giacchè al contrario, pur essendo il rinvio della udienza superiore al detto termine di legge, ai fini della prescrizione è stato calcolato solo il termine di cui all'art. 159 c.p. (al riguardo il primo punto dello specchietto delle sospensioni di cui a pag.15 della impugnata sentenza). Quanto ai rimanenti conteggi, deve ribadirsi, in punto di diritto, che la disposizione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, così come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3, regola in via generale le cause di sospensione del corso della prescrizione, stabilendo che la prescrizione è sospesa, tra l'altro, in caso di sospensione del procedimento o del processo penale "per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore", in tal modo distinguendo l'ipotesi della sospensione determinata da un impedimento delle parti o dei difensori dall'ipotesi di sospensione concessa a richiesta dell'imputato o del difensore dell'imputato. La disposizione in esame disciplina la durata della sospensione del processo, stabilendo che, in ipotesi di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori (e non quindi anche nell'ipotesi di sospensione a richiesta dell'imputato o del suo difensore), l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, ovvero calcolando la sospensione della prescrizione per il solo tempo dell'impedimento, aumentato di sessanta giorni.
Sulla base delle espressioni usate dal legislatore, è, pertanto, chiaro che la limitazione di giorni sessanta, oltre il tempo dell'impedimento, del periodo, che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione, si applica solo ai rinvii determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche ai rinvii concessi a seguito di una richiesta dell'imputato o del suo difensore. Nel caso in esame, la Corte di Appello ha fatto esatta applicazione di dette regole, giacchè ha tenuto conto che tutti i rinvii, con l'eccezione di quello che si dirà seguito, sono stati concessi su istanza del difensore.
Si tratta infatti o di rinvii richiesti a ragione della proposta istanza di ricusazione del collegio, che non integra alcun obbligo di sospensione del processo o sollecitati per esigenze personali del difensore, non concernenti un impedimento in senso tecnico.
Viceversa, deve darsi atto che effettivamente uno dei differimenti avvenuto invece per malattia del difensore è stato erroneamente conteggiato oltre il 60^ giorno e che il corso della prescrizione è da incrementare di gg 10 (si tratta del rinvio per un intervento chirurgico richiesto all'udienza del 3.12.2008).
Essendo, tuttavia, gli altri differimenti tutti richiesti ad istanza del difensore ed in assenza di una delle ragioni indicate dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, il consequenziale arretramento del termine prescrizionale è praticamente irrilevante, dato che allo stato attuale la scadenza è comunque da determinare al 6 dicembre 2010 anzichè al 16 dicembre 2010. 4 - Inammissibile perchè generico è il motivo con cui il L. si duole della liquidazione delle spese in favore delle parti civili, non avendo che dedotta la mera erroneità della determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non indicando in concreto se la forfetizzazione operata abbia ecceduto i massimi tariffari o abbia violato i criteri di liquidazione riportati nella relativa tabella.
5. Anche il motivo inerente alla mancata concessione delle generiche non ha ragioni di essere; la Corte si è diffusa nell'enunciare le ragioni che portavano ad una valutazione negativa della personalità del L. e quindi alla non meritevolezza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p..
La motivazione adotta che corrisponde a criteri di adeguatezza a fronte della quale il L. introduce censure di merito, che non possono essere esaminate in questa sede. In conclusione, il ricorso è da rigettare ed il L. è da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Debito pubblico pro-capite
Contatore del debito pubblico italiano
Amore e Psiche

Maddalena - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!