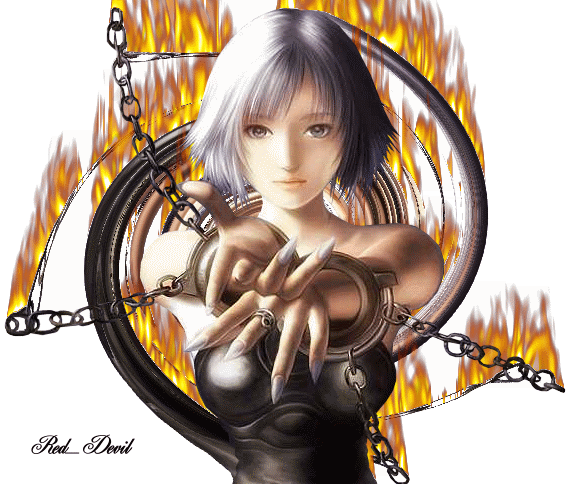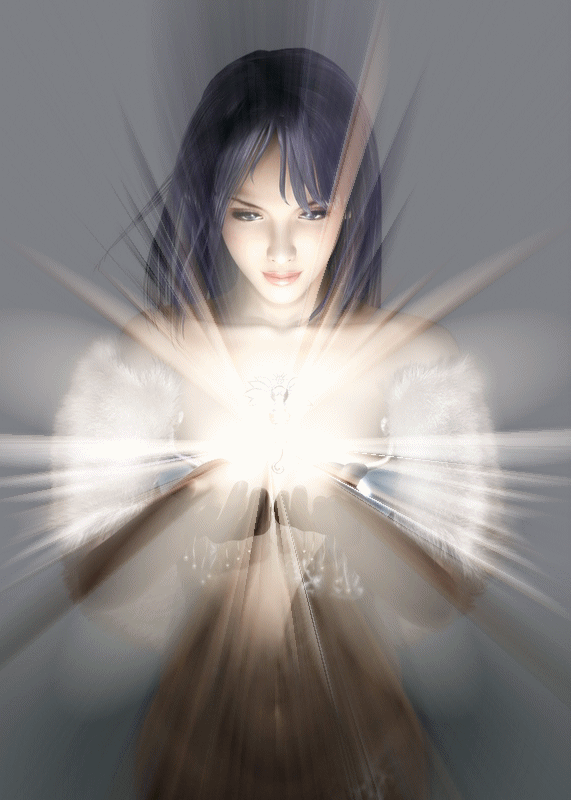Pubblico impiego e mansioni superiori di fatto (Cons. Stato, n. 4890/2011)
massima: Anche nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori comporta, in favore del pubblico dipendente, il diritto alla corresponsione del trattamento retributivo corrispondente alla mansione di livello superiore effettivamente svolta.
1. Premessa
La decisione in esame ribadisce che è vero, infatti, che, a norma dell'art. 56 co. 6 d.l.vo 3.2.1993, nel testo sostituito dall'art. 25 d.lgs. 31.3.1998 n. 80, poi modificato dall'art. 15 d.l.vo 29.10.1998 n. 387 e corrispondente ora all'art. 52 co. 5 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, l'assegnazione è nulla, "ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore", e ciò senza sbarramenti temporali, in applicazione del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 (1).
Inoltre, a norma dell'art. 52 co. 3 d.l.vo 165/01, "si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri dì dette mansioni''.
La giurisprudenza di
legittimità ha conseguentemente affermato che "nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di mansioni dirigenziali a un funzionario è illegittimo, ma, ove tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto dette funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato) (2).
2. Mansioni superiori e d.lgs. 387/1998
La nozione di "mansione" nel settore del pubblico impiego assume aspetti di peculiarità e non si identifica nel mero collegamento materiale di taluni compiti espletati dal dipendente a quelli di una diversa o superiore qualifica, ma presuppone il concorso di qualità professionali e di livello culturale da vagliarsi preventivamente in base ai giudizi idoneativi previsti dalle norme di settore, i quali soli
[...] [...]
garantiscono l'effettiva corrispondenza della professionalità richiesta - cui corrisponde un determinato livello di trattamento economico - agli scopi che l'Amministrazione intende perseguire avvalendosi di una determinata prestazione lavorativa
L'irrilevanza delle mansioni rese in fatto dal pubblico dipendente a costituire il diritto alla retribuzione della corrispondente qualifica ha, inoltre, trovato conferma nella decisione dell'Adunanza Plenaria n. 3 del 24.03.2006, che solo a partire dall'entrata in vigore dell' art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha riconosciuto, in base al carattere innovativo e non interpretativo della norma, la possibilità di riconoscere un più elevato trattamento economico per il periodo di effettiva prestazione di mansioni superiori.
Infatti, va precisato che il diritto ad una retribuzione superiore non può fondarsi:
a) sull'art. 2041 cod. civ.: come affermato in giurisprudenza il diritto del pubblico dipendente al trattamento corrispondente a quello di una qualifica superiore per lo svolgimento delle relative funzioni (o mansioni) non può fondarsi sull'ingiustificato arricchimento dell' Amministrazione, atteso che l'esercizio di tali funzioni o mansioni, svolto durante l'ordinaria prestazione lavorativa, non crea alcuna effettiva diminuzione patrimoniale in danno del dipendente. Non è configurabile, pertanto, il c.d. depauperamento che costituisce requisito essenziale dell'azione esperibile ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. è (3);
b) l'art. 2126,
primo comma, cod. civ.: tale disposizione, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità del titolo (4), riguarda un fenomeno del tutto diverso (e cioè lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile pubblico dipendente) ed afferma il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato. Pertanto essa non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento, emanati in conformità alle leggi ed ai regolamenti (5).
Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù
(estratto da: http://www.diritto.it/docs/32232-pubblico-impiego-e-mansioni-superiori-di-fatto-cons-stato-n-4890-2011?page=2 )
_____________
(1) Così: Cass. civ., Sez. Un., 11.12.2007, n. 25837; Cass. civ., 14.6.2007, n. 13877 e Cass. civ., 17.4.2007, n. 9130.
(2) Cfr. Cass. civ., 12.4.2006, n. 8529.
(3) Cfr. Cons. St., Sez. IV, 06.04.2004, n. 1831; Cons. Stato, sez. VI, 31.03.2004, n. 1727; Cons. Stato, sez. V, 18.3.2002, n. 1552.
(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27.3.2003, n. 1595; Cons. Stato, Sez. V, 24.3.1998, n. 354.
(5) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24.1.2003, n. 329; Cons. Stato, Sez. V, 17.5.1997, n. 515.
_____________________________
Pubblico impiego – Concorso – Differenze retributive – Mansioni superiori
Consiglio di Stato n. 4890/2011, sez. III del 31/8/2011
FATTO
Il geom. Antonio Sculli, collaboratore amministrativo (VII liv.) presso l’ASL n. 9 di Locri (già USL n. 28 e USSL n. 9), espone di aver svolto dal 1982 mansioni del tutto analoghe a quelle di capo ufficio tecnico (XI liv.) prima coadiuvando il titolare e sostituendolo in caso di assenza, come risulta dalla deliberazione 19 giugno 1992 n. 669 dell’Amministratore straordinario dell’USL n. 28, poi su incarico appunto di capo ufficio tecnico disposto con ordine di servizio 7 luglio 1994 n. 1164 mentre al titolare era stata attribuita la responsabilità del più ampio servizio n. 11.
Inoltre, in applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 25 del d.lgs. n. 547 del 1993, con deliberazione 27 giugno 1995 n. 571 gli sono state conferite le funzioni di capo ufficio tecnico con diritto alle differenze retributive, ma a seguito di rilievi del collegio dei revisori con deliberazione 5 febbraio 1996 n. 273 il provvedimento è stato parzialmente revocato nel senso del riconoscimento delle differenze retributive solo tra il VII livello e quello immediatamente superiore.
Ancora sulla base di rilievi del collegio dei revisori, le deliberazioni n. 153 del 1996 e n. 571 del 1995 sono state
annullate d’ufficio con deliberazione 8 marzo 1996 n. 272, comunicatagli (essa sola e non anche le altre) con nota 22 marzo 1996 spedita il giorno 26 ed a lui pervenuta almeno il giorno seguente.
L’interessato ha proposto, perciò, nel 1996 davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, un ricorso avente ad oggetto la declaratoria del suo diritto a percepire le differenze retributive tra la qualifica formalmente ricoperta e quella corrispondente alle mansioni superiori svolte dal 1982, previa declaratoria di illegittimità delle deliberazioni 5 febbraio 1996 n. 153 e 8 marzo 1996 n. 272.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività con sentenza 27 dicembre 2004 n. 1016.
In particolare, il TAR ha ritenuto che la pretesa di riconoscimento della rilevanza delle mansioni superiori ai fini giuridici ed economici, non potesse prescindere dall’annullamento di tali deliberazioni, tuttavia impugnate tardivamente.
Di qui l’appello, inoltrato per la notifica il 6 dicembre 2005 e depositato il 30 seguente, cui il geom. Sculli, ricordati i motivi formulati in primo grado, ha dedotto:
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e 31 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Violazione e
[...] [...]
falsa applicazione delle norme relative alla esecutività, pubblicazione e comunicazione delle delibere dell’amministrazione sanitaria. Insufficienza e/o carenza della motivazione.
In primo luogo, oggetto del ricorso erano solo le differenze retributive, ossia una pretesa costituente diritto soggettivo di natura patrimoniale non soggetta a termine di decadenza. In secondo luogo, erroneamente il TAR ha computato il termine per l’impugnazione della data di adozione delle deliberazioni e non dalla piena conoscenza della relativa comunicazione.
2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, 36 della Costituzione, 2126 cod. civ. e dei principi stabiliti in materia dalla Corte Costituzionale.
Per il periodo dal 1982 al 1994, la deliberazione 19 giugno 1992 n. 669 riconosce ampiamente le funzioni svolte dal geom. Sculli, il quale ha coadiuvato il capo ufficio svolgendo mansioni del tutto analoghe a questi; e ciò essendo incontrovertibile, può prescindersi dalla sussistenza delle condizioni del posto vacante d’organico e del conferimento con provvedimento formale.
Per il secondo periodo, decorrente dall’assunzione della citata disposizione di servizio 7 luglio 1994 n. 1164, cui ha fatto seguito deliberazione n. 571 del 1995, ricorrono tutte le condizioni richieste dall’orientamento più restrittivo, sicché le deliberazioni nn. 153 e 272 del 1996 devono ritenersi
illegittime.
3.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in relazione all’omessa comunicazione avvio procedimento di revoca.
4.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Non è stato tenuto conto che la deliberazione n. 669 del 1992 e la disposizione di servizio del 1994 non erano state revocate, né è stato esplicitato il superiore interesse pubblico alla revoca in comparazione col sacrificio imposto al dipendente.
L’Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.
DIRITTO
Col ricorso di primo grado il geom. Antonio Sculli chiedeva «l’accertamento del diritto a percepire le differenze stipendiali maturate per lo svolgimento, di fatto, delle funzioni superiori dal 1982 ad oggi, oltre accessori»; chiedeva, altresì, l’annullamento delle deliberazioni 5 febbraio 1996 n. 153 e 8 marzo 1996 n. 272 del Direttore generale dell’ASL n. 9 di Locri, con le quali sono stati annullati d’ufficio i provvedimenti di attribuzione delle differenze retributive così rivendicate.
In tal modo il ricorrente, che non ha affatto posto questioni di incidenza delle predette funzioni superiori sul proprio status giuridico, ha introdotto un’azione chiaramente di accertamento della sussistenza di diritto soggettivo perfetto di
[...] [...]
carattere patrimoniale, soggetta al termine di prescrizione e non a quello di decadenza, giacché le deliberazioni menzionate consistono in atti c.d. paritetici, i quali non sono suscettibili di incidere negativamente sul diritto in questione e la cui impugnativa resta, quindi, del tutto irrilevante.
Pertanto, è pienamente fondato il primo profilo del primo motivo d’appello, col quale tanto si sostiene per confutare la declaratoria di inammissibilità per tardività (rectius: irricevibilità) del ricorso di primo grado. Ne consegue che per questo aspetto la sentenza appellata non può che essere riformata.
Nel merito, tuttavia, all’anzidetta rivendicazione si oppone il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori alla qualifica rivestita da parte dei dipendenti delle unità (o aziende) sanitarie locali.
Come infatti ha ribadito l’Adunanza plenaria con la nota decisione 24 marzo 2006 n. 3, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 1998 e salva diversa disposizione di legge specifica, nel settore del pubblico impiego le mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica ricoperta formalmente erano del tutto ininfluenti sul piano giuridico e su quello economico e non consentivano, perciò, il pagamento delle differenze retributive eventualmente pretese dal pubblico dipendente.
Solo con la norma
di cui all’art. 15 de detto decreto legislativo la retribuibilità di tali mansioni ha assunto carattere di generalità. Tanto anche nella considerazione, in primo luogo, che la stessa norma non può ritenersi interpretativa del combinato disposto dei pregressi artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29 del 1993, poiché la scelta con essa assunta non rientra in nessuna delle varianti di senso compatibili con il tenore letterale delle medesime disposizioni; pertanto, non può che disporre per il futuro; e, in secondo luogo, che il riconoscimento generalizzato del diritto dei pubblici dipendenti alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori solo a decorrere dall’entrata in vigore del ripetuto d.lgs. n. 387 del 1998 trova la sua ratio nell’introduzione da parte dell’art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 (che ha sostituito l’art. 56 del d.lgs. n. 19 del 1993 ed abrogato il successivo art. 57) di un’organica disciplina delle mansioni, rispettosa dei principi costituzionali ricavabili dagli artt. 51, 97 e 98 Cost..
D’altro canto, con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, l’art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 – costituente, in relazione al settore di attività del dipendente,
[...] [...]
il riferimento normativo in materia per il rispettivo periodo di vigenza - subordina la possibilità di riconoscere le differenze retributive per l’espletamento fattuale di mansioni superiori al ricorrere di tre condizioni, giuridiche e di fatto, operanti in modo concomitante:
- le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, vacante e disponibile;
- su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso;
- l’incarico deve essere stato attribuito dall’organo gestorio, competente, con una formale deliberazione e da tale deliberazione deve emergere l’avvenuta verifica dei presupposti di cui innanzi, nonché l’assunzione di tutte le relative responsabilità (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. V, 6 marzo 2007 n. 1048 e 16 maggio 2006 n. 2790)
Nella fattispecie in trattazione non sussistono quanto meno la prima e la terza condizione.
Infatti i compiti che il geom. Sculli assume di aver espletato, consistenti nel coadiuvare il capo ufficio tecnico e nel sostituirlo nei periodi di congedo ordinario ed in caso di assenza o impedimento, non sono riconducibili ad un posto vacante d’organico giacché il posto di capo ufficio era, invece, regolarmente ricoperto, mentre nessun incarico formale (da cui può eventualmente prescindersi soltanto per il personale sanitario ed
esclusivamente nell’ipotesi di sostituzione del primario, data l’indefettibilità della funzione) risulta conferito all’interessato. Non è tale evidentemente la deliberazione 19 giugno 1992 n. 669 dell’Amministratore straordinario dell’USL n. 28, per il periodo in questione meramente ricognitiva dell’avvenuto svolgimento di dette mansioni. D’altra parte è noto che l’occasionale sostituzione del capo dell’ufficio, assente per ferie o malattia, etc., da parte del funzionario di grado immediatamente inferiore, rientra fra i compiti ordinari di quest’ultimo e non costituisce esercizio delle mansioni superiori.
Analoghe conclusioni si raggiungono con riguardo al periodo successivo, in cui il riferimento normativo è costituito dall’art. 55 del cit. d.P.R. n. 384 del 1990, concernente specificamente l’area non medica ed in relazione al quale a maggior ragione deve escludersi rilevanza economica alle mansioni superiori svolte in via di fatto, atteso che la disposizione non solo richiede l’attribuzione dell’incarico relativo alla copertura di posto vacante mediante apposito atto formale adottato “secondo le vigenti disposizioni”, ma anche l’attivazione delle “procedure concorsuali” per “provvedere alla regolare copertura” dello stesso posto vacante, alla quale nella specie neppure si accenna.
In ogni caso, anche con riferimento al periodo decorrente dall’adozione dell’ordine di servizio in data 7 luglio 1994 dell’Amministratore straordinario dell’USSL n. 9, la Sezione osserva che si tratta di pur sempre di incarico su posto d’organico coperto dal titolare, a sua volta investito dell’incarico “provvisorio” di responsabile del servizio n. 11, come confermato dalla successiva deliberazione 27 giugno 1995 n. 571 del Direttore generale dell’ASL n. 9, di attribuzione per tre mesi al geom. Sculli delle mansioni in parola ai sensi del cit. art. 57, lett. b), del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (come sostituito dall’art 25, d.lgs. 547 del 1993), ossia “nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto…”.
In conclusione, il ricorso di primo grado deve ritenersi infondato nel merito al pari, per questa parte, dell’appello. Ne consegue la riforma della sentenza appellata nel senso della reiezione del medesimo ricorso di primo grado, in luogo della declaratoria di inammissibilità per tardività.
Nella mancata costituzione nel presente giudizio dell’Amministrazione, non v’è luogo a provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie in parte e per il resto respinge il medesimo appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
estratto da: http://www.diritto.it/docs/21251-pubblico-impiego-concorso-differenze-retributive-mansioni-superiori?page=4&tipo=content
Svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego
Solo a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 è riconoscibile, in favore dei dipendenti pubblici, la retribuibilità delle mansioni superiori svolte; ciò esclusivamente per il periodo futuro e non già per il periodo pregresso per il quale trova applicazione il principio della irrilevanza dello svolgimento delle mansioni medesime
Data di pubblicazione: 29/07/2010
La retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico non trovava base normativa in alcuna norma o principio generale desumibile dall’ordinamento. Ciò, neppure nell’art. 2126 c.c., che concerne solo l’ipotesi della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato, né nell’applicazione diretta dell’art. 36 Cost., la cui incondizionata applicazione al pubblico impiego resta impedita dalle contrastanti previsioni degli artt. 97 e 98 Cost.; parimenti inapplicabile si palesa l’art. 2041 c.c., in ragione della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa.
Solo a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 – che con l’art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell’art. 56 D.Lgs. n. 29/1993 – le dette differenze retributive sono riconoscibili, e non per il periodo pregresso per il quale trova applicazione il principio della irrilevanza dello svolgimento delle mansioni medesime.
E quindi, deve escludersi qualsiasi possibilità di individuare, nella previsione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 29/1993, un principio generale di ampia portata avente ad oggetto la pretesa retribuibilità; del resto, non può sfuggire che, di fronte agli espliciti interventi del legislatore per differire l’attuazione della disciplina generale delle mansioni superiori recata dall’art. 57 cit., sarebbe arbitrario individuarne una portata generale nel senso
della applicabilità della disposizione a far tempo dalla sua emanazione e, comunque, da data anteriore.
N. 04596/2010 REG.DEC.
N. 00034/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 34 del 2007, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Mannucci Marcello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Manzi Stefano Betti e Paolo Sivori, elettivamente domiciliato in Roma, presso e nello studio del primo difensore, via Federico Confalonieri n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. II, n. 795/2006;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere Bruno Mollica;
uditi, altresì, nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010, l’Avvocato dello Stato Cristina Gerardis, l’avv. Stefano Betti e l’avv. Luigi Manzi su delega dell’avv. Andrea Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
[...]
[...]
e DIRITTO
1.- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugna la sentenza di TAR indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal dott. Marcello Mannucci, dipendente dell’Amministrazione finanziaria presso il Centro Servizio delle imposte dirette di Genova, con qualifica di funzionario tributario (ottava q.f.), inteso ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive asseritamente spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori dal 22 marzo 1994 al 10 dicembre 1997 e dal 11 dicembre 1997 al 30 giugno 1998 in relazione, rispettivamente, alla nomina alla funzione di direttore ad interim del reparto contabilità, in conseguenza della vacanza registratasi in quell’ufficio, nonché alla successiva destinazione presso il reparto addestramento.
La difesa dell’appellato eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per genericità e, nel merito, ne sostiene l’infondatezza, chiedendone il rigetto.
2.- L’eccezione di inammissibilità deve essere disattesa.
L’Avvocatura erariale ripropone, invero, in questa sede di appello, le ragioni di doglianza – riferite a costante orientamento giurisprudenziale, anche di questo Consesso – in ordine alla “irrilevanza giuridica ed economica delle mansioni svolte” dal pubblico dipendente incaricato (in ipotesi) di mansioni superiori; questa è l’intitolazione del mezzo e questo è il punto nodale della questione sottoposta all’attenzione del Collegio: non si vede quale altro argomento giuridico avrebbe dovuto proporre la difesa dell’Amministrazione nel chiedere la riforma della sentenza gravata.
3.- Quanto al merito della controversia, sono ovviamente ben noti al Collegio i contrasti giurisprudenziali delineatisi sulla questione per cui è causa; peraltro, gli arresti cui è pervenuta l’Adunanza plenaria (nonchè l’evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni di questo Consesso) orientano per la condivisione della prospettazione dell’Amministrazione e per il conseguente accoglimento del ricorso.
Va invero ricordato che, giusto condivisibile assunto dell’Adunanza plenaria (n. 22/1999), la retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico non trovava base normativa in alcuna norma o principio generale desumibile dall’ordinamento; ciò, neppure nell’art. 2126 Cod.civ., che concerne solo l’ipotesi della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato; nè nell’applicazione diretta dell’art. 36 Cost., la cui incondizionata applicazione al pubblico impiego resta impedita dalle contrastanti previsioni degli artt. 97 e 98 Cost.; parimenti inapplicabile si palesa l’art. 2041 Cod.civ., in ragione della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa (cfr., fra le tante, anche VI Sez., 22.1.2001, n. 177, 22.1.2001, n. 5958).
Solo a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 – che con l’art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell’art.
[...] [...]
56 D.Lgs. n. 29/1993 e la cui portata non interpretativa bensì di valenza per il futuro è stata condivisibilmente ribadita da Ad. Plen. 24 marzo 2006 n. 3 – le dette differenze retributive sono riconoscibili, e non per il periodo pregresso (come nel caso che ne occupa), per il quale trova applicazione il principio della irrilevanza dello svolgimento delle mansioni medesime (cfr., fra le tante, VI Sez., 27.1.2001, n. 177, 7.5.2001, n. 2520, 27.11.2001, n. 5958 e 8.1.003, n. 17), nonchè, da ultimo, IV Sez., 24.4.2009 n. 2626).
La soluzione era stata già affermata dalle decisioni dell’Adunanza plenaria nn. 10 del 28 gennaio 2000 e 11 del 23 febbraio 2000, che hanno escluso qualsiasi possibilità di individuare, nella previsione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 29/1993, un principio generale di ampia portata avente ad oggetto la pretesa retribuibilità; del resto, non può sfuggire che, di fronte agli espliciti interventi del legislatore per differire l’attuazione della disciplina generale delle mansioni superiori recata dall’art. 57 cit., sarebbe arbitrario individuarne una portata generale nel senso della applicabilità della disposizione a far tempo dalla sua emanazione e, comunque, da data anteriore (cfr., ancora, Ad. plen. n. 10/2000).
4.- Privo di pregio appare altresì il tentativo defensionale di parte appellata che, nel richiamare le conclusioni ribadite dalla decisione dell’Adunanza plenaria 24 marzo 2006 n. 3 nel senso della assoluta irrilevanza delle mansioni svolte dal pubblico dipendente prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 387 del 1998, ne valorizza l’inciso “salva diversa disposizione di legge”.
Ed invero, il quadro normativo richiamato nella sentenza di prime cure si limita a consentire, a tutto concedere, nel ricorrere di determinate condizioni, la preposizione del dipendente allo svolgimento di mansioni superiori ma non contempla, in relazione a tale svolgimento, la corresponsione di indennità o di trattamenti economici correlati alle mansioni stesse (non è questo il senso – neppure – della istituzione della IX qualifica funzionale ex art. 2 D.L. n. 9 del 1986).
Il che conferma ulteriormente la validità del principio di “irrilevanza economica” postulato dai precitati arresti giurisprudenziali e dallo stesso ricorso in appello.
A tale proposito, occorre un’ultima annotazione.
Nel contestare la prospettazione dell’Avvocatura erariale, la pur attenta difesa del Mannucci afferma che essa non coglie nel segno neppure se riferita a fattispecie antecedenti all’entrata in vigore del D.L.vo n. 387 cit., e ciò “in quanto, in tale periodo di tempo, le mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente avevano invece rilevanza pur nei limiti di cui sopra”; e sotto tale specifico profilo “la difesa avversaria non ha minimamente censurato l’impugnata sentenza”, osserva ancora l’appellato Mannucci.
Posto che i “limiti di cui sopra” non sono rinvenibili nell’indicato quadro normativo (che non contempla assolutamente la corresponsione di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori), non è dato rilevare l’erroneità della pretesa omissione.
5.- Per le esposte considerazioni, il ricorso in appello dell’Amministrazione va in conclusione accolto.
6.- Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di 1° grado.
Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
estratto da: http://www.diritto.it/docs/29982-svolgimento-di-mansioni-superiori-nel-pubblico-impiego?page=3
Le mansioni superiori nel pubblico impiego
L'esercizio di mansioni superiori da parte di un dipendente pubblico, e la loro retribuibilità, presuppongono che vi sia stato un posto disponibile in organico e che l'attribuzione delle mansioni sia avvenuta con atto formale
Data di pubblicazione: 11/03/2010
Nel pubblico impiego, è principio di diritto consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale sia l'esercizio di mansioni superiori, sia la loro retribuibilità presuppongono che vi sia un posto disponibile in organico e che l'attribuzione delle mansioni sia avvenuta con atto formale.
Peraltro, gli ordini di servizio non possono qualificarsi come incarico formale, essendo essi solamente atti di organizzazione dell'attività lavorativa, volti alla pianificazione delle mansioni dei pubblici impiegati, la cui efficacia giuridica è meramente interna all'ufficio di appartenenza.
Un tale sistema normativa non risulta in contrasto né con i principi costituzionali nè con lo statuto dei lavoratori.
N. 01283/2010 REG.DEC.
N. 06604/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6604 del 1998, proposto da:
De Razza Rosina, Liguori Massimiliano e Liguori Giovanni Rocco nella qualità di eredi del Sig. Liguori Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avv. Ciro Centore e Francesco D'Angelo, con domicilio presso il Consiglio di Stato, Segreteria, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Regione Campania -Gestione liquidatoria ex Usl 42 Napoli, Gestione Liquidatoria U.S.L. 39; A.S.L. Napoli 1,
rappresentate e difese dall'avv. Antonio Iodice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Tupini in Roma, via Ghino Valenti 9;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI: Sezione IV n. 00015/1998, resa tra le parti, concernente DIPENDENTE: CORRESPONSIONE SOMME.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il Cons. Gianpiero Paolo Cirillo e uditi per le parti gli avvocati Scotto per delega dell'avv.Iodice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor Giuseppe Liguori impugnò avanti al TAR Campania il silenzio- rigetto formatosi sulla diffida rivolta all'azienda sanitaria locale NA1, con la quale aveva chiesto la liquidazione del proprio trattamento economico per le superiori mansioni svolte. In particolare aveva dedotto che , assunto con la qualifica pari al sesto livello funzionale, aveva svolto fin dal 1983 funzioni superiori di settimo livello, sulla base di reiterati ordini di servizio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania rigettava il ricorso.
Ha proposto originariamente appello il signor Liguori -poi riassunto, a seguito del decesso del medesimo, dagli eredi, con atto notificato il 29 aprile 2009-
[...]
deducendo l'erroneità della sentenza, laddove non ha tenuto conto che del caso di specie operano i principi collegati alla legge n. 300 del 1970 sullo statuto dei lavoratori, in quella parte in cui si statuisce che il lavoratore che ha dovuto disimpegnare comunque mansioni superiori, e lo abbia fatto non per sua spontanea volontà, debba essere sempre retribuito per dette funzioni, particolarmente laddove il tutto sia avvenuto non per 90 giorni ma per mesi ed anni, in termini continuativi.
Si è costituita la regione Campania, resistendo all’appello.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 novembre 2009.
DIRITTO
L'appello non è fondato.
L'appellante ha chiesto la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori di collaboratori amministrativo svolte ininterrottamente dal 1983.
La sezione ha già avuto modo in varie occasioni (vedasi per tutte quella cui si è uniformato il giudice di primo grado, sez. V, 7 marzo 1997, n. 218) di stabilire che l'esercizio delle mansioni superiori e la loro retribuibilità presuppongono che vi sia un posto disponibile in organico e che l'attribuzione delle mansioni sia avvenuta con atto formale.
Nel caso di specie, l'appello non è sorretto da nessun atto idoneo a fornire la prova della sussistenza delle due condizioni di cui sopra.
Il ricorrente ha esibito nel corso del giudizio solamente degli ordini di servizio.
Sul punto la sezione ha già avuto modo di stabilire che gli ordini di servizio non possono qualificarsi come incarico formale, essendo essi solamente atti di organizzazione dell'attività lavorativa, volti alla pianificazione delle mansioni dei pubblici impiegati, la cui efficacia giuridica è meramente interna all'ufficio di appartenenza.
E’appena il caso di osservare che nessun contrasto è possibile ravvisare nel sistema della legge, così come interpretato dalla unanime giurisprudenza, con i principi costituzionali e con lo statuto dei lavoratori (cfr, tra le altre C.S., VI, 23 gennaio 2007, n. 231).
In conclusione l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3000,00
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere, Estensore
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
estratto da: http://www.diritto.it/docs/29137-le-mansioni-superiori-nel-pubblico-impiego?page=2
Mansioni superiori nel pubblico impiego
Data di pubblicazione: 09/12/2010
Nel pubblico impiego, con l’art. 15, del D.L.vo n. 387/98 si è operato il riconoscimento legislativo del diritto del dipendente al riconoscimento economico delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale posseduta in base al provvedimento di nomina o di inquadramento. La norma ha un evidente carattere innovativo per la sua apertura nei confronti del “mansionismo” e non opera retroattivamente.
Nell’ambito del pubblico impiego è irrilevante, sia ai fini economici che a quelli di progressione di carriera, lo svolgimento da parte del dipendente, ancorché con attribuzione per atto formale, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale posseduta in base al provvedimento di nomina o di inquadramento.
L’attribuzione delle mansioni ed il relativo trattamento economico trovano, infatti, il loro indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o di inquadramento ad eccezione del caso in cui una norma speciale non disponga altrimenti.
In particolare, l'art. 33 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 stabilisce, infatti, che il dipendente dello Stato (rectius, impiegato pubblico) ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia «nella misura stabilita dalla legge». Inoltre, l’art. 2126 c.c. disciplina l’ipotesi, diversa, del rapporto di lavoro dichiarato “nullo” (poiché costituitosi in violazione dei divieti
legali) attribuendo rilevanza alle prestazioni di fatto comunque effettuate in esecuzione dello stesso: la norma opera, dunque, in funzione di conservazione dei valori giuridici ed economici del negozio colpito da un giudizio di disvalore ordinamentale.
Neppure può farsi applicazione, dell’art. 36 Cost. che non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego concorrendo, in detto ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale (artt. 97 e 98 Cost.).
Ed allora, nell’ambito del pubblico impiego è la qualifica (e non sono le mansioni) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l’assetto rigido della Pubblica amministrazione sotto il profilo organizzatorio, collegato anch’esso, secondo il paradigma dell'art. 97 C., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica” (sentenza 22/99, citata).
Pertanto, l’Amministrazione è tenuta a corrispondere la retribuzione propria della qualifica superiore solo quando una norma speciale preveda tale assegnazione e consenta la relativa maggiorazione retributiva.
Infine, con l’art. 15, del D.L.vo n. 387/98 (successivamente, il suo contenuto è stato riprodotto nell’attuale testo unico sul pubblico impiego) si è operato il riconoscimento legislativo del diritto di che trattasi con un evidente carattere innovativo per la sua apertura nei confronti del “mansionismo”; pertanto, va attribuito, con carattere di
[...] generalità, soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. vo n. 387/1998.
N. 35274/2010 REG.SEN.
N. 00681/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 1993, proposto da:
Occhipinti Silvestro, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Giurato, con domicilio eletto presso Ugo Giurato in Roma, p.zza Adriana, 11;
contro
Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituito;
per l'annullamento del
SILENZIO-RIFIUTO SULLA DOMANDA DI INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE E PROFILO PROFESSIONALE SUPERIORI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto:
-ad essere inquadrato nella qualifica funzionale VII e prof. professionale 203, corrispondenti alle mansioni di fatto espletate, come da sua richiesta del 4/6/1992;
-al maggiore trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni effettivamente
svolte ed assegnate anche in relazione all’art. 2103 c.c., nonché il riconoscimento delle mansioni superiori di fatto espletate ex art. 2126 c.c..
In punto di fatto, l’interessato riferisce:
-di essere dipendente del ministero della difesa;
-di essere inquadrato ai sensi dell’art. 4, c. VIII della legge n. 312/1980 nel profilo professionale n. 73della VI qualifica funzionale;
-di espletare sin dal 1975 le mansioni di capo tecnico inerenti il superiore livello VII;
-lo svolgimento di tali mansioni risulta da atti formali provenienti dalla P.A. quali la scheda relativa all’indagine conoscitiva.
L’interessato fonda le proprie pretese sull’art. 4 della legge n. 312/1980 nonché sugli artt. 2103 e 2126 c.c..
L’amministrazione ha denegato i richiesti benefici.
Il ricorso è infondato.
L’art. 4 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) così recita(va) al comma 10^ (comma abrogato dall'art. 74, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29; abrogazione confermata dall'art. 72, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165:
“Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
[...] e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità”.
La prescrizione del termine di 90 giorni era già stata abrogata dall'art. 4, L. 7 luglio 1988, n. 254.
Come si evince dal testo della norma in esame, l’avvio del procedimento di inquadramento in qualifica superiore era subordinato alla seguenti condizioni:
-domanda da parte dell’impiegato;
-valutazione favorevole da parte del consiglio di amministrazione dell’ente;
-sottoposizione a prova selettiva.
A fronte di un così articolato iter procedimentale, l'amministrazione non aveva un preciso obbligo di provvedere sulle istanze di inquadramento, ciò in quanto l'inquadramento dei pubblici dipendenti corrispondeva, alla luce del quadro normativo di riferimento, ad un'attività discrezionale (ancorché di natura tecnica in ordine alla verifica di corrispondenza delle mansioni al profilo professionale o qualifica funzionale) rispetto alla quale non erano ravvisabili diritti soggettivi (al preteso inquadramento) bensì interessi legittimi tutelabili con l'impugnativa o degli atti di inquadramento ritenuti invalidi nel termine di decadenza oppure del rifiuto/silenzio dall’amministrazione opposto all’istanza di inquadramento.
Riprova della natura discrezionale (tecnica) del potere conferito all’amministrazione si ha ove si consideri, sotto altro profilo, che la deliberazione della Commissione paritetica, con la quale furono determinati i criteri
concreti che perfezionavano i presupposti della fattispecie dell'inquadramento, venne adottata soltanto il successivo 28 settembre 1988; fu da questa data che l’attività amministrativa divenne priva, a quel punto, di connotati di discrezionalità ed autoritatività fino a quel momento non essendo in grado, l’amministrazione, di ascrivere i dipendenti al profilo professionale corrispondente alla qualifica precedentemente rivestita in base ad atto formale, adottando provvedimenti di inquadramento definitivo dei singoli dipendenti.
Va soggiunto, che nessuna delle due condizioni sopra descritte (valutazione favorevole e sottoposizione a prova selettiva) si era, comunque, verificata perché il ricorrente potesse vantare, in punto di fatto e di diritto, l’azionata pretesa.
Quest’ultima, ad ogni modo, risulta definitivamente sbarrata sia dall’abrogazione dei commi 10 e 11 dell’art. 4, L. n. 312/1980 ad opera dell'art. 74, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 - abrogazione confermata dall'art. 72, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 – che dal sopravvenuto art. 52 del d. lgs. n. 165/01 (applicabile, ratione temporis, anche alla fattispecie in esame non risultando in atti esaurito il dedotto rapporto) il quale, con disposizione di carattere imperativo ed a regime, stabilisce che “in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti
[...]
automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore”.
Per quanto sin qui argomentato, la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento è destituita di giuridico fondamento e non può, pertanto, essere accolta.
Parte ricorrente chiede, altresì, ai sensi dell’art. 2103 c.c., il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore anche in ragione del consolidamento dell’assegnazione, da parte dell’amministrazione, allo svolgimento di mansioni superiori; quest’ultime assertivamente comprovate, in punto di fatto, dalla scheda relativa all’indagine ricognitiva.
In via gradata, l’interessato chiede il riconoscimento del maggior trattamento economico sulla base anche del disposto dell’art. 2126 c.c.
Anche queste domande sono infondate.
I presupposti per il riconoscimento del diritto del pubblico dipendente alla retribuzione per lo svolgimento delle funzioni superiori (Cfr Cons. Giust. Amm. n. 583, del 9/10/02) sono i seguenti:
1) la sostituzione del titolare dell’ufficio da parte dell’inferiore gerarchico deve avvenire in occasione di assenze non temporanee;
2) il posto cui le mansioni si riferiscono deve essere necessariamente vacante o disponibile in pianta organica;
3) l’adibizione a mansioni superiori deve avvenire con incarico promanante dagli organi dell’Amministrazione.
Nel caso in esame, nessuna delle tre condizioni si era verificata nei confronti del ricorrente.
Segnatamente, l’assenza nel caso di specie dei prefati presupposti e circostanze impedisce
- per effetto del carattere formale che contrassegna l’organizzazione della p.a., in sintonia con i principi di legalità e di buon andamento - il riconoscimento a fini giuridici e retributivi di pretese fondate su iniziative libere (recte, su atti causalmente nulli per violazione di norme imperative), assunte da soggetti che, seppure interni all’apparato dell’amministrazione, risultano privi della potestà di immutazione dello status del dipendente anziché sulla base di provvedimenti adottati dagli organi istituzionalmente competenti, titolari della potestà organizzatoria dell’ente.
Più in generale, la Sezione, aderendo ad un ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativo, non può che ribadire nell’ambito del pubblico impiego l’irrilevanza, sia ai fini economici che a quelli di progressione di carriera, dello svolgimento da parte del dipendente, ancorché con attribuzione per atto formale, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale posseduta in base al provvedimento di nomina o di inquadramento.
L’attribuzione delle mansioni ed il relativo trattamento economico trovano, infatti, il loro indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o di inquadramento ad eccezione del caso in cui una norma speciale non disponga altrimenti (C. Stato, Ad. Plen. 18.11.1999, n. 22; C. Stato, Ad. Plen. 28.1.2000, n. 10).
La scheda relativa all’indagine conoscitiva non è atto giuridicamente e fattualmente idoneo, per quanto sopra esposto, a precostituire il diritto al superiore inquadramento ovvero a percepire le differenze economiche di livello.
Non ravvede motivi, il Collegio, per discostarsi dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, prima della definitiva privatizzazione del pubblico impiego (ed escluso il campo sanitario), le mansioni superiori non erano di regola riconoscibili sotto il profilo giuridico ed economico (cfr. C.d.s. Sez. V - 21/1/02). Il principio dell'irrilevanza giuridica ed economica dello svolgimento, in tutte le sue forme, di mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego - salvo che tali effetti derivino da un’espressa previsione normativa - è un dato acquisito alla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.s. IV Sez., 17 maggio 1997 n. 647; C.G.A.R.S. 27 maggio 1997 n. 197; C.d.s. V Sez., 30 aprile 1997 n. 429, 24 marzo 1997 n. 290, 28 gennaio 1997 n. 99; VI Sez., 26 giugno 1996 n. 860 e 10 febbraio 1996 n. 189).
Nessuna norma o principio generale desumibile dall'ordinamento, infatti, consente la retribuibilità, in via di principio, delle mansioni superiori comunque svolte nel campo dell’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Anzi, dalla disciplina di settore si ricava esattamente un opposto principio: l'art. 33 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.
3 stabilisce, infatti, che il dipendente dello Stato (rectius, impiegato pubblico) ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia « nella misura stabilita dalla legge ».
In disparte quanto sopra, va osservato, in via tranciante, che l’art. 2126 c.c. disciplina l’ipotesi, affatto diversa, del rapporto di lavoro dichiarato “nullo” (poiché costituitosi in violazione dei divieti legali) attribuendo rilevanza alle prestazioni di fatto comunque effettuate in esecuzione dello stesso: la norma opera, dunque, in funzione di conservazione dei valori giuridici ed economici del negozio colpito da un giudizio di disvalore ordinamentale.
Neppure può farsi applicazione, a tutto concedere, dell’art. 36 Cost., in virtù del quale sussiste “l’obbligo d’integrare il trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato”. L’articolato, costituendo parametro precettivo di immediata applicazione al rapporto di lavoro, consentirebbe – nella prospettiva della ricorrente - l’attribuzione diretta del trattamento economico corrispondente alla superiore qualifica rivestita.
Non v’è dubbio che l’art. 36 Cost. sancisca il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. Senonché la norma, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria (sentenza n. 22/99), non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego concorrendo, in detto ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale (artt. 97 e 98 Cost.).
In particolare, l’operatività dell’art. 36 nell’ambito del pubblico impiego trova un limite invalicabile nell’art. 97 della Carta fondamentale.
L'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, infatti, contrasta con il buon andamento e l’imparzialità dell'Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. Ed invero, la posizione di chi svolge mansioni superiori non può essere assimilata (sotto il profilo giuridico-economico) a quella di colui che il medesimo incarico ricopre sulla base di una qualificazione professionale oggettivamente accertata all’esito di procedure selettive e/o concorsuali (art. 97, comma III, Cost.).
L'affidamento di mansioni superiori a pubblici dipendenti, invece, avviene spesso con criteri che non garantiscono l'imparzialità dell'Amministrazione (A.p. 22/99).
Nell’esercizio dei propri poteri d'organizzazione (art. 97, comma I Cost.) l’amministrazione potrebbe, per esigenze particolari di buon andamento dei servizi, prevedere in sede regolamentare - anche - la possibilità d'assegnazione temporanea di dipendenti a mansioni superiori alla loro qualifica senza, però, diritto a variazioni del trattamento economico (cfr. Ap., dec. 4/9/97, n. 20).
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, concordemente a quanto sostenuto dall’Alto Consesso, che “nell’ambito del pubblico impiego è la qualifica e non le
mansioni il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l’assetto rigido della Pubblica amministrazione sotto il profilo organizzatorio, collegato anch’esso, secondo il paradigma dell'art. 97, ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica” (sentenza 22/99, citata).
Pertanto, l’Amministrazione è tenuta a corrispondere la retribuzione propria della qualifica superiore solo quando una norma speciale preveda tale assegnazione e consenta la relativa maggiorazione retributiva (come accade nel campo sanitario – cfr. D.P.R. n. 761/79): circostanza, quest’ultima, che non ricorre affatto nel caso di specie.
Neppure può trovare applicazione alla fattispecie l’invocato art. 2126 Cod. civ. in virtù del “principio della prestazione di fatto”.
Ed invero, il prefato articolato disciplina l’ipotesi, affatto diversa, del rapporto di lavoro dichiarato “nullo” (poiché costituitosi in violazione dei divieti legali) attribuendo rilevanza alle prestazioni di fatto comunque effettuate in esecuzione dello stesso: la norma opera, dunque, in funzione di conservazione dei valori giuridici ed economici del negozio colpito da un giudizio di disvalore ordinamentale.
Va considerato, infine, che neppure sussistono i presupposti per l’applicazione al caso in esame della nuova normativa sul pubblico impiego. Ed invero, i decreti succedutisi dal 1993 al 2001, in attuazione delle leggi - delega sulla riforma del settore, contemplano una disciplina generale del conferimento di mansioni superiori valida per tutte le Amministrazioni pubbliche.
Tale normativa, la cui entrata in vigore è stata più volte rinviata dallo stesso legislatore per esigenze connesse alle problematiche organizzative interne degli Enti, regolamenta all’art. 52, del D. Lvo n. 165/01 (per la prima volta in un testo normativo di portata generale per il pubblico impiego) l’istituto dell’attribuzione temporanea di funzioni superiori. La norma prevede che al lavoratore spetta, in siffatti casi, la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore anche nel caso d'assegnazione nulla per violazione delle condizioni ivi previste (art. 52 c. V, decreto citato).
La prefata disposizione, invero, è stata introdotta nel testo normativo originario del 1993 (n. 29) con l’art. 15, del D.L.vo n. 387/98: successivamente, il suo contenuto è stato riprodotto nell’attuale testo unico sul pubblico impiego – art. 52, c. V, citato - (in parte-qua, ricognitivo).
Ebbene, il riconoscimento legislativo del diritto di che trattasi possiede un evidente carattere innovativo per la sua apertura nei confronti del “mansionismo”; pertanto, va attribuito, con carattere di generalità, soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. vo n. 387, del 1998 (cfr. A.p. n. 10, del 2000) mentre nella vicenda che occupa i fatti si sono tutti esauriti in epoca antecedente.
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre nulla si dispone in ordine alle spese processuali per mancata costituzione in giudizio della intimata amministrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
[...]
estratto da: http://www.diritto.it/docs/30747-mansioni-superiori-nel-pubblico-impiego?page=1
Nel pubblico impiego la domanda volta ad ottenere le differenze retributive per il periodo in cui il lavoratore affermi di aver svolto mansioni superiori non può essere basata sull’art. 36 della Costituzione che, per consolidata giurisprudenza, concorre con altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione.
L’esercizio di mansioni superiori nel pubblico impiego, a ben vedere, contrasta rispetto alla qualifica rivestita di diritto con il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione stessa, nonché con gli artt. 51 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell’indisponibilità da parte dei funzionari amministrativi dell’assegnazione di mansioni.
Peraltro, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori è stato riconosciuto, sempre nel pubblico impiego, solo a partire dall’entrata in vigore dell’art. 15 del D.Lgs. 29.10.1998, n. 387.
N. 06980/2010 REG.SEN.
N. 04863/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4863 del 2005, proposto da:
Colucci Maria Antonietta, rappresentata e difesa dagli avv. Roberta Finati, Vito Vincenzo Zaccagnino, con domicilio eletto presso l’avv.Roberta Finati in Roma, via Francesco Grimaldi
140;
contro
Azienda Sanitaria Locale U.S.L N. 2 di Potenza., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Bianchini, con domicilio eletto presso l’avv.Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA n. 00219/2004, resa tra le parti, concernente REVOCA E RETTIFICA INQUADRAMENTO NELLA VII QUALIFICA FUNZIONALE
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale USL n. 2 di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il cons. Francesca Quadri e udito l’avvocato Patarnello, su delega dell' avv. Bianchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente appella la sentenza del Tar Basilicata con cui è stata respinta l’impugnazione del provvedimento della ASL n.2 di Potenza di annullamento del suo inquadramento come ostetrica – operatore professionale coordinatore e di conseguente rettifica del posto come operatore professionale collaboratore- ostetrica con decorrenza dall’inizio del servizio, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 207 del 1985.
Premesso di avere svolto fin dal 1983 mansioni di ostetrica coordinatrice in regime di convenzione e di essere stata nominata in ruolo, a domanda, in base all’art. 3 L. 207/1985 sul posto di ostetrica -operatore professionale coordinatore , la ricorrente riferisce di aver chiesto nel 1997 all’amministrazione la propria regolarizzazione economica con la corresponsione delle differenze economiche tra il livello di mansioni svolte (7°) e quello di retribuzione percepita (6°) e di essersi invece vista annullare il superiore inquadramento con il provvedimento impugnato.
Per la riforma della sentenza del Tar che ha riconosciuto la legittimità dell’operato della AUSL in base ad una stretta interpretazione dell’art. 3 L.207/1985 ed ha respinto la richiesta di riconoscimento di mansioni superiori, l’interessata propone appello affidandolo ai seguenti motivi:
- errores in iudicando, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed irrazionalità: correttamente l’Ausl n. 2 di Potenza aveva provveduto alla sua immissione in ruolo in relazione alle mansioni svolte in regime di convenzione e dei requisiti previsti dalla legge n. 207/1985. A distanza di dodici anni, la Ausl avrebbe difettato del potere di annullamento senza una adeguata valutazione degli interessi in gioco , omettendo ogni motivazione e dimostrazione del mancato svolgimento delle mansioni di (prima 6° e poi) 7° livello. Né a diverse valutazioni si poteva pervenire in base al livello retributivo percepito dall’interessata (VI) corrispondente
al livello originariamente proprio del posto di coordinatrice , successivamente trasformato in 7° con conseguente necessità di adeguamento del trattamento economico;
- errores in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della Costituzione, difetto di motivazione ed istruttoria, errore nei presupposti di fatto: avrebbe errato il Tar nel riconoscere al provvedimento la finalità di correzione di un errore a suo tempo compiuto attraverso l’inquadramento, avendo dovuto l’amministrazione dimostrare il mancato svolgimento delle mansioni riconosciute; erroneamente sarebbe stata considerato applicabile alla fattispecie l’art. 3 in luogo dell’art. 1 della L. n. 207/1985. In presenza di regolare atto formale e di svolgimento di mansioni di ostetrica coordinatore regolarmente espletate, le sarebbero spettate, quantomeno, le differenze stipendiali oltre a rivalutazione ed interessi in base all’art. 29 del D.P.R. n. 761/1999.
Si è costituita l’azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza per resistere all’appello.
All’udienza del 22 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Il primo motivo è infondato.
2.L’immissione in ruolo dell’appellante è stata disposta nel 1985 in applicazione dell’art. 3 della L.20 maggio 1995, n. 207, che prevede l’inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato, quale quello dell’interessata. Del tutto impropriamente viene quindi richiamato nell’atto di appello l’art. 1 della medesima legge ,che attiene alla diversa fattispecie di inquadramento straordinario di personale incaricato, ricoprente alla data del 30 giugno 1984 un posto di organico vacante.
3.L’art. 3 prevede l’inquadramento a domanda , previo accertamento dei titoli, “nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale” del personale in regime convenzionato alla data del 31 dicembre 1983.
4.La giurisprudenza ha chiarito (ex multis, Cons. St.Sez. V, 15.3.1993, n. 372, 20.12.1993, n. 1329; 8.1.2007, n.3) che la trasformazione in pubblico impiego di un rapporto di tipo convenzionale , in deroga alla regola dell’assunzione tramite pubblico concorso, può ammettersi solo a condizione di escludere ogni riconoscimento di anzianità e che non sussiste alcuna discrezionalità in capo all’amministrazione in ordine alla posizione funzionale di inquadramento che deve necessariamente essere quella iniziale.
5.Sulla base del chiaro disposto dell’art. 3, correttamente il Tar ha considerato fondato il ragionamento posto a base dell’annullamento dell’inquadramento iniziale, avvenuto non già sulla posizione funzionale iniziale di ostetrica- operatore professionale collaboratore (quale risultante dal d.P.R. n. 761/1979) bensì su quella superiore di operatore professionale coordinatore.
6.Né può accedersi alla tesi dell’appellante secondo cui un annullamento disposto dopo dodici anni dall’adozione dell’atto annullato avrebbe richiesto una più approfondita ponderazione
degli interessi coinvolti ed una più attenta valutazione delle effettive mansioni effettivamente svolte dall’interessata .
7.Va ,infatti ,osservato che per giurisprudenza consolidata ( di recente, Cons. St. Sez. V, 22.3.2010 n. 1672; 11.7.2008, n.3472), l’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione di un illegittimo inquadramento è dimostrata dalla idoneità dell’atto a spiegare continuativamente i propri effetti negativi sull’organizzazione dell’ente , con la conseguenza di impedire al mero decorso del tempo di consolidare la posizione del dipendente interessato. Nè è richiesta a riguardo una diffusa motivazione dell’interesse pubblico posto a base dell’annullamento in via di autotutela, essendo questo in re ipsa a causa delle conseguenze permanenti (anche dopo il collocamento in quiescenza) dell’illegittimo inquadramento.
8.Anche il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive a causa dello svolgimento di mansioni superiori, è infondato.
La domanda volta ad ottenere le differenze retributive per il periodo in cui l’appellante afferma di aver svolto mansioni superiori non può essere basata sull’art. 36 della Costituzione che, per consolidata giurisprudenza (Cons. St. A.P. 18.11.1999, n. 22, Sez. VI 19.9.2000 n. 4871) , concorre con altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione, contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita di diritto con il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché con gli artt. 51 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell’indisponibilità da parte dei funzionari amministrativi dell’assegnazione di mansioni , nella specie diverse da quelle espressamente previste dalla legge che ha disciplinato l’immissione in ruolo.
Peraltro, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori è stato – come è noto - riconosciuto solo a partire dall’entrata in vigore dell’art. 15 del D.Lgs. 29.10.1998, n. 387 (Cons. St. A.P. n. 11 /2000) e ,quindi, da un periodo posteriore a quello cui attiene l’oggetto del ricorso.
9.In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado .
Spese compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
[...]
Informativa Privacy e Privacy Policy
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice che trovi alla pagina: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
Se desideri che ShinyStat™ non raccolga alcun dato statistico relativo alla tua navigazione, clicca sul pulsante OPT-OUT.
AVVERTENZA: l'OPT-OUT avviene installando un cookie (nome cookie ShinyStat di opt-out: OPTOUT) se cancelli i cookies, sarà necessario ripetere l'opt-out in quanto cancellarei anche il cookie di opt-out
ALTALEX NEWS

giovedì 22 settembre 2011
Abuso del titolo di legittimazione all'accesso ad un sistema informatico: alle SS.UU. la configurabilità del delitto di cui all'art.615 ter c.p.
Abuso del titolo di legittimazione all'accesso ad un sistema informatico: alle SS.UU. la questione della configurabilità del delitto di cui all'art. 615 ter c.p.
A proposito di Cass. pen., sez. V, ord. 11.2.2011 (dep. 23.3.2011), n. 11714, Pres. Calabrese, Est. Scalera, ric. Casani
[Alberto Scirè]
Si è già avuto occasione di dare notizia, in questa Rivista, della rimessione alle Sezioni Unite, da parte della quinta Sezione della Cassazione, della questione relativa all'integrazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) nel caso in cui l'agente sfrutti le proprie credenziali per scopi e finalità diverse da quelle in ragione delle quali le ha ricevute.
Dal pronunciamento delle Sezioni Unite - atteso a breve - dipendono, in specie, le sorti di un maresciallo dei Carabinieri, il quale aveva fornito ad un conoscente dati riguardanti una terza persona tramite l'accesso al sistema informatico dell'Arma (denominato S.I.D., Sistema di Indagine), allo scopo di favorire un'operazione di dossieraggio.
Ciò premesso, pare interessante svolgere qualche breve considerazione, quanto alle prospettive che aprirebbe un'interpretazione più o meno ampia, da parte delle Sezioni Unite, dei concetti di “abusività dell'accesso” e di “mantenimento” di un soggetto entro un determinato sistema informatico.
1. L'ordinanza della Quinta Sezione
La Corte individua il perno delle motivazioni di ricorso presentate dai legali del Carabiniere (e riportate nell'ordinanza di rimessione, a pagina 2) nel carattere “abusivo” (o meno) della condotta posta in essere dall'agente, nel momento in cui egli, utilizzando le credenziali di accesso di cui era detentore autorizzato, trae dal sistema elementi non attinenti alle ragioni per cui esse gli sono state consegnate. La questione verte infatti sul dubbio se il legislatore, individuando un elemento del fatto tipico con l'espressione “accesso abusivo”:
- intendesse fare uso dello strumento penale al fine di proteggere informazioni riservate verso l'accesso da parte di chi non sia stato in precedenza identificato e abilitato,
ovvero, in modo più ampio,
- volesse individuare quale illecito (anche) ogni utilizzo delle credenziali non conforme alle prescrizioni previste dall'ente emittente.
Da tale alternativa discendono alcune conseguenze di non scarsa rilevanza.
La prima, e più evidente, è la possibilità (o meno) di configurare il reato di cui all'art. 615 ter a carico di soggetti legittimamente in possesso di password d'accesso, le quali siano loro fornite solo con un preciso scopo, allorché essi le utilizzino (come nel caso di specie) con modalità o per finalità diverse e ulteriori rispetto alla volontà del gestore dei dati.
Ulteriore e più importante conseguenza della decisione demandata alle SS.UU. in tema di abusività dell'accesso è, però, la reale protezione che l'ordinamento intende riservare ai sistemi informatici, fortemente esposti ad accessi incontrollati, poiché per loro natura “immateriali” e facilmente consultabili da un ampio numero di soggetti.
Si tratta insomma di decidere se un accesso sia intrinsecamente abusivo, e quindi rilevante ai sensi dell’art. 615 ter, ogniqualvolta l'attività dell'agente sia diretta ad una finalità diversa da quella prevista dall'ente emittente, ovvero se tale condotta integri, se del caso, un diverso profilo d'illiceità, non appartenente al gruppo dei “reati informatici”.
Su tale questione sono intervenute alcune importanti sentenze della stessa Corte di Cassazione (richiamate dall'ordinanza annotata), che prendono posizione a favore di una lettura “ampia” della norma, tale per cui si considera abusivo ogni accesso eccedente le finalità per cui le credenziali di autorizzazione sono fornite. Tale lettura individua, pertanto, il bene giuridico tutelato dalla norma in parola nella riservatezza dei dati contenuti nei sistemi informatici, e non nel mero “domicilio informatico” (così, ad esempio, si veda infra Cass. pen., n. 1727/2008, Romano).
2. La giurisprudenza di legittimità sull'art. 615 ter
L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite offre numerosi spunti di riflessione che traggono linfa dall'ampia casistica giurisprudenziale riportata: sono infatti menzionate sia sentenze che, in adesione all’orientamento estensivo, riconoscono la sussistenza del reato anche se il possesso delle password era di per sé legittimo (punto 3), sia sentenze in cui la Suprema Corte ha, invece, aderito all'interpretazione restrittiva della norma (punto 3a).
La Quinta Sezione, dal canto suo, sembra riservare un maggior favore all'orientamento estensivo, il quale consentirebbe di qualificare senz’altro come “abusiva” la condotta dell'agente dell'Arma dei Carabinieri, che ha sfruttato il sistema informativo interno per scopi assolutamente estranei ai suoi doveri d'ufficio.
I dubbi interpretativi qui discussi originano da una formulazione letterale poco precisa dell’art. 615 ter, laddove si parla di “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”.
La scelta di impiegare l'avverbio “abusivamente”, anziché altre formule meno ambigue (come, ad esempio, “accesso non autorizzato”) risulta, peraltro, in contrasto con la “Raccomandazione sulla criminalità informatica”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 13 settembre 1989, la quale ha dato impulso all’emanazione, da parte del nostro legislatore, della legge n. 547 del 23 dicembre 1993, introduttiva di alcuni reati c.d. informatici (tra cui quello previsto all’art. 615 bis)[1]. Tale raccomandazione, citata spesso nelle sentenze che prediligono una lettura restrittiva dell'art. 615 ter c.p.[2], invita infatti gli Stati contraenti a punire il solo “accesso non autorizzato a sistemi informatici”, vale a dire l'accesso illegittimo, avvenuto in mancanza di credenziali autentiche.
Questa formula parrebbe invitare i singoli Stati a punire tutti (e solo) quei comportamenti che consistono nell'accedere ad un sistema senza esserne validamente autorizzati da chi detiene il c.d. “ius excludendi”: in altre parole, se non ho ricevuto la password e me la procuro in modo illecito, non posso (e non devo) entrare nel sistema, pena la sanzione; se, invece, l'ho ricevuta, posso utilizzare il sistema liberamente.
Questa seconda ipotesi (accesso autorizzato avvenuto, tuttavia, per finalitá diverse rispetto a quelle per cui l’autorizzazione era stata concessa), pur non integrando un “accesso abusivo”, potrebbero, tuttavia, essere punita in forza di altre norme incriminatrici (a seconda delle circostanze di specie, frode informatica, illecita diffusione di dati personali, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, ecc.).
Questi argomenti usati dai sostenitori della interpretazione restrittiva dell’art. 615 ter non tengono, tuttavia, conto – come rilevato da altra e contrastante giurisprudenza di legittimità[3] –, delle concrete modalità e motivazioni in base alle quali determinate credenziali d'accesso sono fornite ai più diversi soggetti, sia nel settore privato che in quello delle Amministrazioni pubbliche, e in particolare delle Forze Armate.
La sentenza Zara del 2000, che aderisce all’orientamento estensivo, afferma che l’analogia con la violazione di domicilio “deve indurre a concludere che integri la fattispecie criminosa (prevista dall'art. 615 ter c.p.) anche chi, autorizzato all'accesso per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato l'accesso. Infatti, se l'accesso richiede un'autorizzazione e questa è destinata a un determinato scopo, l'utilizzazione dell'autorizzazione per uno scopo diverso non può non considerarsi abusiva.”.
La sentenza Romano del 2008, invero, va oltre: nel decidere in merito ad un'ordinanza cautelare relativa a numerosi reati, commessi da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, la Corte pare estendere alla formulazione per così dire “generica” del primo comma dell'art. 615 ter alcune considerazioni riferibili invece al secondo comma, ove si sanziona più gravemente la condotta del pubblico ufficiale che abbia commesso l'accesso al sistema informatico "con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio".
Questa sentenza critica la precedente sentenza Scimia per non aver considerato la norma nel suo complesso, trascurando quindi di comprendere a fondo quali siano tutte le diverse previsioni in merito al fatto tipico alla base dell'irrogazione della sanzione.
3. Le possibili “vie d'uscita” dal contrasto interpretativo
Dalla lettura delle numerose pronunce in tema, un dato pare comunque emergere con forza: lo strumento informatico, sempre più diffuso non solo nella vita dei privati cittadini ma anche delle amministrazioni pubbliche, non può essere lasciato sprovvisto di tutela penale da parte dell'ordinamento, soprattutto per quanto concerne la gestione e la circolazione dei dati riconducibili a ciascuno di noi.
Sono numerose, invero, le norme che puntano alla tutela delle informazioni, telematiche e non, nonché alla protezione dei sistemi da abusi e violazioni: esempi possono esserne l'art. 167 del c.d. Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) il quale punisce la diffusione senza titolo di dati personali, con pene di una certa gravità, così come l'art. 640 ter c.p. in tema di frodi informatiche (spesso richiamato quale norma a portata più ampia di quella in discorso, che anzi sarebbe ivi ricompresa).
Ma le concrete modalità con le quali le norme di diritto penale devono intervenire, nella loro attuale formulazione, sui c.d. “crimini informatici”, sono fortemente dibattute.
La norma (anche solo considerata nella sua formulazione letterale) pare infatti voler punire sia chi si introduca in un sistema senza averne la “chiave”, sia chi – una volta entrato – si trattenga al suo interno per ragioni diverse che, se portate a conoscenza del soggetto che ha il diritto di escluderlo, ne provocherebbero, appunto, l'esclusione.
Se l'espressione “abusivamente si introduce” non può che significare l'acquisizione senza autorizzazione di credenziali d'accesso, con modalità di più o meno sofisticato hackeraggio dei sistemi informatici, la successiva “vi si mantiene (nei sistemi) contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo” parrebbe invece voler individuare come fatto tipico rilevante ogni utilizzo contrario alla volontà del fornitore di password.
Nel caso di specie, relativo all'Arma dei Carabinieri si potrebbe quindi provare ad ipotizzare che (a) il giuramento militare, (b) i doveri d'ufficio, nonché (c) eventuali regolamenti interni disciplinino in modo “chiaro” l'accesso al S.I.D. ed il suo utilizzo, nei termini e con le modalità che potrebbero – almeno in via tacita – prefigurare una “volontà di escludere” il militare che violi tali regole, facendo un uso personale (ancor più se pure fraudolento) delle proprie credenziali.
Una tale interpretazione dell'art. 615 ter non pare in contrasto col dato letterale: una lettura integrale della disposizione dovrebbe infatti estender l'applicazione della norma anche ai comportamenti eccedenti rispetto alle finalità dell'autorizzazione di accesso ad un determinato sistema. In questo senso, si potrebbe tentare un'analogia con il caso – invero noto alla giurisprudenza in tema di violazione di domicilio - della “domestica” che si trattenga entro l'abitazione del proprio datore di lavoro ed ivi compia atti ulteriori rispetto al proprio compito: in entrambi i casi, infatti, la volontà contraria (presunta o tacita) di chi ha autorizzato l'accesso diverrebbe, a tutti gli effetti, elemento costitutivo del fatto tipico.
Non dovrebbe valere in senso contrario, secondo chi scrive, il (pur corretto) richiamo alle sopraccitate considerazioni del Consiglio d'Europa in materia di cybercrimes: se anche là s'invitavano gli Stati contraenti a punire il solo “accesso non autorizzato”, bisognerebbe ammettere che, in base al tenore letterale che pare emergere dalla norma, il legislatore italiano – consapevolmente o meno – abbia deciso di oltrepassare tale posizione, nell'ottica di fornire una tutela piú ampia ai sistemi informatici[4].
In tal caso, sarebbe poi interessante discutere anche se l'espressione “mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo” intenda o meno considerare un requisito di natura temporale, o invece la concreta finalità dell'accesso.
Nel primo caso, sarebbe punibile il solo agente che, intimato (esplicitamente o non) a lasciare un sistema informatico, vi permanga con le proprie (valide) credenziali. Ciò potrebbe però prospettare, a parere di chi scrive, un conflitto con il principio di offensività, laddove il sistema “violato” non contenga dati degni di tutela, ovvero l'attività posta in essere dall'agente non fosse concretamente lesiva (appunto, l'esempio della domestica di cui sopra).
Nel secondo caso, invece, sarebbe necessario trovare un ancoraggio chiaro e conforme ai principi costituzionali di legalità e tassatività: se la condotta è punibile in base ad una volontà di un soggetto “terzo” rispetto all'agente, come può l'agente rendersi conto di stare commettendo il reato de quo?
Una parziale soluzione, prospettata recentemente dal Tribunale di Brescia (sentenza del 3-30 marzo 2011 n. 293, GUP Dott. Benini, in Corr. merito, 2011, p. 833, con annotazione di Gatta), pare escludere dal novero delle condotte punibili – con un'interpretazione potenzialmente “additiva” – l'attività di un soggetto che, per mera curiosità, si sia trattenuto entro un sistema informatico per cui possedeva le credenziali d'accesso. Il discrimine, in tale caso, sarebbe inerente alle finalità – non illecite – dell'imputato: sarebbe quindi richiesto, per l'attribuzione di un fatto ex art. 615-ter c.p., di un quid pluris (ad esempio, una finalità illecita) che si aggiunga all'elemento materiale del reato.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] I reati introdotti dalla l. 547/1993 sono stati successivamente integrati e modificati dalla legge n. 48 del 2008.
[2] V., inter alia, Cass. Pen. n. 39290/2008, “Peparaio” (erroneamente indicata in ordinanza come n. 3290) in merito a finalità estranee a quelle d'ufficio, e Cass. Pen. n. 26797/2008, “Scimia”, in merito – addirittura – a finalità dichiaratamente illecite.
[3] Su tutte, la – diffusamente citata nell'ordinanza – Cass. Pen. n. 1727/2008, “Romano”, nonché la – risalente, ma cara alla Quinta Sezione – Cass. Pen. n. 12732/2000, “Zara”.
[4] Si tenga altresì conto, in tale contesto, che la già citata “lista minima” prevedeva ad esempio, quali condotte da sanzionare, anche l'intercettazione di dati non autorizzata e la riproduzione non autorizzata di programmi protetti: potrebbe allora supporsi che anche tali comportamenti siano stati – almeno nelle intenzioni del Legislatore del 1993 – ricompresi proprio nella norma in esame.
estratto da: http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/19-/-/866-abuso_del_titolo_di_legittimazione_all__accesso_ad_un_sistema_informatico__alle_ss_uu__la_questione_della_configurabilit___del_delitto_di_cui_all__art__615_ter_c_p/
A proposito di Cass. pen., sez. V, ord. 11.2.2011 (dep. 23.3.2011), n. 11714, Pres. Calabrese, Est. Scalera, ric. Casani
[Alberto Scirè]
Si è già avuto occasione di dare notizia, in questa Rivista, della rimessione alle Sezioni Unite, da parte della quinta Sezione della Cassazione, della questione relativa all'integrazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) nel caso in cui l'agente sfrutti le proprie credenziali per scopi e finalità diverse da quelle in ragione delle quali le ha ricevute.
Dal pronunciamento delle Sezioni Unite - atteso a breve - dipendono, in specie, le sorti di un maresciallo dei Carabinieri, il quale aveva fornito ad un conoscente dati riguardanti una terza persona tramite l'accesso al sistema informatico dell'Arma (denominato S.I.D., Sistema di Indagine), allo scopo di favorire un'operazione di dossieraggio.
Ciò premesso, pare interessante svolgere qualche breve considerazione, quanto alle prospettive che aprirebbe un'interpretazione più o meno ampia, da parte delle Sezioni Unite, dei concetti di “abusività dell'accesso” e di “mantenimento” di un soggetto entro un determinato sistema informatico.
1. L'ordinanza della Quinta Sezione
La Corte individua il perno delle motivazioni di ricorso presentate dai legali del Carabiniere (e riportate nell'ordinanza di rimessione, a pagina 2) nel carattere “abusivo” (o meno) della condotta posta in essere dall'agente, nel momento in cui egli, utilizzando le credenziali di accesso di cui era detentore autorizzato, trae dal sistema elementi non attinenti alle ragioni per cui esse gli sono state consegnate. La questione verte infatti sul dubbio se il legislatore, individuando un elemento del fatto tipico con l'espressione “accesso abusivo”:
- intendesse fare uso dello strumento penale al fine di proteggere informazioni riservate verso l'accesso da parte di chi non sia stato in precedenza identificato e abilitato,
ovvero, in modo più ampio,
- volesse individuare quale illecito (anche) ogni utilizzo delle credenziali non conforme alle prescrizioni previste dall'ente emittente.
Da tale alternativa discendono alcune conseguenze di non scarsa rilevanza.
La prima, e più evidente, è la possibilità (o meno) di configurare il reato di cui all'art. 615 ter a carico di soggetti legittimamente in possesso di password d'accesso, le quali siano loro fornite solo con un preciso scopo, allorché essi le utilizzino (come nel caso di specie) con modalità o per finalità diverse e ulteriori rispetto alla volontà del gestore dei dati.
Ulteriore e più importante conseguenza della decisione demandata alle SS.UU. in tema di abusività dell'accesso è, però, la reale protezione che l'ordinamento intende riservare ai sistemi informatici, fortemente esposti ad accessi incontrollati, poiché per loro natura “immateriali” e facilmente consultabili da un ampio numero di soggetti.
Si tratta insomma di decidere se un accesso sia intrinsecamente abusivo, e quindi rilevante ai sensi dell’art. 615 ter, ogniqualvolta l'attività dell'agente sia diretta ad una finalità diversa da quella prevista dall'ente emittente, ovvero se tale condotta integri, se del caso, un diverso profilo d'illiceità, non appartenente al gruppo dei “reati informatici”.
Su tale questione sono intervenute alcune importanti sentenze della stessa Corte di Cassazione (richiamate dall'ordinanza annotata), che prendono posizione a favore di una lettura “ampia” della norma, tale per cui si considera abusivo ogni accesso eccedente le finalità per cui le credenziali di autorizzazione sono fornite. Tale lettura individua, pertanto, il bene giuridico tutelato dalla norma in parola nella riservatezza dei dati contenuti nei sistemi informatici, e non nel mero “domicilio informatico” (così, ad esempio, si veda infra Cass. pen., n. 1727/2008, Romano).
2. La giurisprudenza di legittimità sull'art. 615 ter
L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite offre numerosi spunti di riflessione che traggono linfa dall'ampia casistica giurisprudenziale riportata: sono infatti menzionate sia sentenze che, in adesione all’orientamento estensivo, riconoscono la sussistenza del reato anche se il possesso delle password era di per sé legittimo (punto 3), sia sentenze in cui la Suprema Corte ha, invece, aderito all'interpretazione restrittiva della norma (punto 3a).
La Quinta Sezione, dal canto suo, sembra riservare un maggior favore all'orientamento estensivo, il quale consentirebbe di qualificare senz’altro come “abusiva” la condotta dell'agente dell'Arma dei Carabinieri, che ha sfruttato il sistema informativo interno per scopi assolutamente estranei ai suoi doveri d'ufficio.
I dubbi interpretativi qui discussi originano da una formulazione letterale poco precisa dell’art. 615 ter, laddove si parla di “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”.
La scelta di impiegare l'avverbio “abusivamente”, anziché altre formule meno ambigue (come, ad esempio, “accesso non autorizzato”) risulta, peraltro, in contrasto con la “Raccomandazione sulla criminalità informatica”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 13 settembre 1989, la quale ha dato impulso all’emanazione, da parte del nostro legislatore, della legge n. 547 del 23 dicembre 1993, introduttiva di alcuni reati c.d. informatici (tra cui quello previsto all’art. 615 bis)[1]. Tale raccomandazione, citata spesso nelle sentenze che prediligono una lettura restrittiva dell'art. 615 ter c.p.[2], invita infatti gli Stati contraenti a punire il solo “accesso non autorizzato a sistemi informatici”, vale a dire l'accesso illegittimo, avvenuto in mancanza di credenziali autentiche.
Questa formula parrebbe invitare i singoli Stati a punire tutti (e solo) quei comportamenti che consistono nell'accedere ad un sistema senza esserne validamente autorizzati da chi detiene il c.d. “ius excludendi”: in altre parole, se non ho ricevuto la password e me la procuro in modo illecito, non posso (e non devo) entrare nel sistema, pena la sanzione; se, invece, l'ho ricevuta, posso utilizzare il sistema liberamente.
Questa seconda ipotesi (accesso autorizzato avvenuto, tuttavia, per finalitá diverse rispetto a quelle per cui l’autorizzazione era stata concessa), pur non integrando un “accesso abusivo”, potrebbero, tuttavia, essere punita in forza di altre norme incriminatrici (a seconda delle circostanze di specie, frode informatica, illecita diffusione di dati personali, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, ecc.).
Questi argomenti usati dai sostenitori della interpretazione restrittiva dell’art. 615 ter non tengono, tuttavia, conto – come rilevato da altra e contrastante giurisprudenza di legittimità[3] –, delle concrete modalità e motivazioni in base alle quali determinate credenziali d'accesso sono fornite ai più diversi soggetti, sia nel settore privato che in quello delle Amministrazioni pubbliche, e in particolare delle Forze Armate.
La sentenza Zara del 2000, che aderisce all’orientamento estensivo, afferma che l’analogia con la violazione di domicilio “deve indurre a concludere che integri la fattispecie criminosa (prevista dall'art. 615 ter c.p.) anche chi, autorizzato all'accesso per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato l'accesso. Infatti, se l'accesso richiede un'autorizzazione e questa è destinata a un determinato scopo, l'utilizzazione dell'autorizzazione per uno scopo diverso non può non considerarsi abusiva.”.
La sentenza Romano del 2008, invero, va oltre: nel decidere in merito ad un'ordinanza cautelare relativa a numerosi reati, commessi da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, la Corte pare estendere alla formulazione per così dire “generica” del primo comma dell'art. 615 ter alcune considerazioni riferibili invece al secondo comma, ove si sanziona più gravemente la condotta del pubblico ufficiale che abbia commesso l'accesso al sistema informatico "con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio".
Questa sentenza critica la precedente sentenza Scimia per non aver considerato la norma nel suo complesso, trascurando quindi di comprendere a fondo quali siano tutte le diverse previsioni in merito al fatto tipico alla base dell'irrogazione della sanzione.
3. Le possibili “vie d'uscita” dal contrasto interpretativo
Dalla lettura delle numerose pronunce in tema, un dato pare comunque emergere con forza: lo strumento informatico, sempre più diffuso non solo nella vita dei privati cittadini ma anche delle amministrazioni pubbliche, non può essere lasciato sprovvisto di tutela penale da parte dell'ordinamento, soprattutto per quanto concerne la gestione e la circolazione dei dati riconducibili a ciascuno di noi.
Sono numerose, invero, le norme che puntano alla tutela delle informazioni, telematiche e non, nonché alla protezione dei sistemi da abusi e violazioni: esempi possono esserne l'art. 167 del c.d. Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) il quale punisce la diffusione senza titolo di dati personali, con pene di una certa gravità, così come l'art. 640 ter c.p. in tema di frodi informatiche (spesso richiamato quale norma a portata più ampia di quella in discorso, che anzi sarebbe ivi ricompresa).
Ma le concrete modalità con le quali le norme di diritto penale devono intervenire, nella loro attuale formulazione, sui c.d. “crimini informatici”, sono fortemente dibattute.
La norma (anche solo considerata nella sua formulazione letterale) pare infatti voler punire sia chi si introduca in un sistema senza averne la “chiave”, sia chi – una volta entrato – si trattenga al suo interno per ragioni diverse che, se portate a conoscenza del soggetto che ha il diritto di escluderlo, ne provocherebbero, appunto, l'esclusione.
Se l'espressione “abusivamente si introduce” non può che significare l'acquisizione senza autorizzazione di credenziali d'accesso, con modalità di più o meno sofisticato hackeraggio dei sistemi informatici, la successiva “vi si mantiene (nei sistemi) contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo” parrebbe invece voler individuare come fatto tipico rilevante ogni utilizzo contrario alla volontà del fornitore di password.
Nel caso di specie, relativo all'Arma dei Carabinieri si potrebbe quindi provare ad ipotizzare che (a) il giuramento militare, (b) i doveri d'ufficio, nonché (c) eventuali regolamenti interni disciplinino in modo “chiaro” l'accesso al S.I.D. ed il suo utilizzo, nei termini e con le modalità che potrebbero – almeno in via tacita – prefigurare una “volontà di escludere” il militare che violi tali regole, facendo un uso personale (ancor più se pure fraudolento) delle proprie credenziali.
Una tale interpretazione dell'art. 615 ter non pare in contrasto col dato letterale: una lettura integrale della disposizione dovrebbe infatti estender l'applicazione della norma anche ai comportamenti eccedenti rispetto alle finalità dell'autorizzazione di accesso ad un determinato sistema. In questo senso, si potrebbe tentare un'analogia con il caso – invero noto alla giurisprudenza in tema di violazione di domicilio - della “domestica” che si trattenga entro l'abitazione del proprio datore di lavoro ed ivi compia atti ulteriori rispetto al proprio compito: in entrambi i casi, infatti, la volontà contraria (presunta o tacita) di chi ha autorizzato l'accesso diverrebbe, a tutti gli effetti, elemento costitutivo del fatto tipico.
Non dovrebbe valere in senso contrario, secondo chi scrive, il (pur corretto) richiamo alle sopraccitate considerazioni del Consiglio d'Europa in materia di cybercrimes: se anche là s'invitavano gli Stati contraenti a punire il solo “accesso non autorizzato”, bisognerebbe ammettere che, in base al tenore letterale che pare emergere dalla norma, il legislatore italiano – consapevolmente o meno – abbia deciso di oltrepassare tale posizione, nell'ottica di fornire una tutela piú ampia ai sistemi informatici[4].
In tal caso, sarebbe poi interessante discutere anche se l'espressione “mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo” intenda o meno considerare un requisito di natura temporale, o invece la concreta finalità dell'accesso.
Nel primo caso, sarebbe punibile il solo agente che, intimato (esplicitamente o non) a lasciare un sistema informatico, vi permanga con le proprie (valide) credenziali. Ciò potrebbe però prospettare, a parere di chi scrive, un conflitto con il principio di offensività, laddove il sistema “violato” non contenga dati degni di tutela, ovvero l'attività posta in essere dall'agente non fosse concretamente lesiva (appunto, l'esempio della domestica di cui sopra).
Nel secondo caso, invece, sarebbe necessario trovare un ancoraggio chiaro e conforme ai principi costituzionali di legalità e tassatività: se la condotta è punibile in base ad una volontà di un soggetto “terzo” rispetto all'agente, come può l'agente rendersi conto di stare commettendo il reato de quo?
Una parziale soluzione, prospettata recentemente dal Tribunale di Brescia (sentenza del 3-30 marzo 2011 n. 293, GUP Dott. Benini, in Corr. merito, 2011, p. 833, con annotazione di Gatta), pare escludere dal novero delle condotte punibili – con un'interpretazione potenzialmente “additiva” – l'attività di un soggetto che, per mera curiosità, si sia trattenuto entro un sistema informatico per cui possedeva le credenziali d'accesso. Il discrimine, in tale caso, sarebbe inerente alle finalità – non illecite – dell'imputato: sarebbe quindi richiesto, per l'attribuzione di un fatto ex art. 615-ter c.p., di un quid pluris (ad esempio, una finalità illecita) che si aggiunga all'elemento materiale del reato.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] I reati introdotti dalla l. 547/1993 sono stati successivamente integrati e modificati dalla legge n. 48 del 2008.
[2] V., inter alia, Cass. Pen. n. 39290/2008, “Peparaio” (erroneamente indicata in ordinanza come n. 3290) in merito a finalità estranee a quelle d'ufficio, e Cass. Pen. n. 26797/2008, “Scimia”, in merito – addirittura – a finalità dichiaratamente illecite.
[3] Su tutte, la – diffusamente citata nell'ordinanza – Cass. Pen. n. 1727/2008, “Romano”, nonché la – risalente, ma cara alla Quinta Sezione – Cass. Pen. n. 12732/2000, “Zara”.
[4] Si tenga altresì conto, in tale contesto, che la già citata “lista minima” prevedeva ad esempio, quali condotte da sanzionare, anche l'intercettazione di dati non autorizzata e la riproduzione non autorizzata di programmi protetti: potrebbe allora supporsi che anche tali comportamenti siano stati – almeno nelle intenzioni del Legislatore del 1993 – ricompresi proprio nella norma in esame.
estratto da: http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/19-/-/866-abuso_del_titolo_di_legittimazione_all__accesso_ad_un_sistema_informatico__alle_ss_uu__la_questione_della_configurabilit___del_delitto_di_cui_all__art__615_ter_c_p/
D.I.A., D.I.A. ad effetto immediato e tutela dei terzi
D.I.A., D.I.A. ad effetto immediato e tutela dei terzi
di Antonio Macolino
La denuncia di inizio attività rappresenta uno degli istituti giuridici sui quali non si è ancora raggiunta, da parte della dottrina e della giurisprudenza amministrative, una visione comune.
L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico della denuncia di inizio attività (che d’ora in poi definiremo d.i.a.) risale al 1990, specificatamente alla entrata in vigore della ormai nota legge n. 241 sul procedimento amministrativo. L’art. 19 della citata legge prevede, infatti, la possibilità di intraprendere l’esercizio di alcune attività, soggette fino ad allora al rilascio di provvedimenti amministrativi di assentimento, in virtù del mero decorso di un termine dalla presentazione della relativa dichiarazione d’intento, accompagnata dai documenti prescritti.
Tale possibilità viene limitata ai casi in cui l’esercizio di un’attività dipenda semplicemente dalla sussistenza di requisiti e presupposti predeterminati dalla legge, mentre non è richiesta alcuna valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione. Sono inoltre esclusi, dalla sfera di applicazione della d.i.a., alcuni settori per i quali risulta sempre necessario un preventivo intervento di assenso da parte dell’autorità pubblica, quali la difesa nazionale, l’immigrazione, la sicurezza e la salute pubblica, l’amministrazione della giustizia e delle finanze.
Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla d.i.a. è sorto, ed è a tutt’oggi in corso, per la difficoltà di incasellare questo istituto nei tradizionali schemi provvedimentali, tanto soprattutto in relazione all’esigenza di individuare forme di tutela per i terzi le cui posizioni giuridiche vengano coinvolte nelle attività denunciate. Ad alimentare tale dibattito hanno certamente contribuito le modifiche apportate, alla disciplina normativa citata, dalla legge n. 80 del 2005 e, da ultimo, dalla legge n. 69 del 2009.
Le tesi principali sulla natura della d.i.a. e sugli strumenti di tutela dei terzi sono due, entrambe sostenute anche di recente dai giudici amministrativi.
La prima di queste tesi, rinvenibile in alcune pronunzie della quarta (n. 5811/2008) e sesta sezione del Consiglio di Stato (decisione 1550/2007), individua nella d.i.a. un istituto peculiare, assimilabile ad un’istanza autorizzatoria che, col decorso del termine di legge, provoca la formazione di un provvedimento di tacito assenso all’esercizio di una certa attività. Secondo questa impostazione la d.i.a. non è uno strumento di liberalizzazione di alcune attività, ma rappresenta un meccanismo che consente al privato di conseguire, grazie al silenzio assenso della pubblica amministrazione, un pur sempre necessario titolo abilitativo.
A sostegno di questa prima tesi vengono invocati vari argomenti, primo tra tutti l’espressa previsione legislativa della facoltà, per l’amministrazione competente, di assumere provvedimenti in via di autotutela anche dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della d.i.a.. L’autotutela rappresenta, infatti, un’attività amministrativa di secondo grado che presuppone sempre, secondo i fautori della tesi in esame, un provvedimento precedente sul quale incidere.
Un altro argomento a favore della natura provvedimentale del silenzio sulla d.i.a. è offerto, in materia edilizia, dal testo unico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 che estende alla d.i.a. edilizia sia i poteri sanzionatori del Comune previsti in caso di annullamento del permesso di costruire, sia il potere della Regione di annullare il permesso di costruire assentito dal Comune.
La seconda tesi sulla natura giuridica della d.i.a., che si rinviene in una recente pronunzia del Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza 717/2009), qualifica la denuncia di inizio attività come un mero atto di un privato, che non ha alcun valore provvedimentale né produce alcun implicito assentimento da parte della pubblica amministrazione. Secondo questa tesi si può parlare di liberalizzazione per le attività di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 solo se viene meno la necessità di un provvedimento autorizzatorio, espresso o tacito che sia, da parte della amministrazione competente. Solo in quest’ottica si può distinguere, infatti, la disciplina della denuncia di cui all’art. 19 da quella del silenzio assenso di cui all’art. 20 della citata legge. Il silenzio assenso comporta, quello si, la formazione di un provvedimento amministrativo implicito di autorizzazione, in seguito alla presentazione di un’istanza ed al decorso di un certo tempo in assenza di obiezioni da parte dell’amministrazione destinataria dell’istanza.
Alle due contrapposte tesi corrispondono, evidentemente, distinti strumenti di tutela del terzo che ritenga di aver subito lesioni delle proprie posizioni giuridiche.
I sostenitori della prima delle sopra esposte tesi ritengono, infatti, che il terzo possa impugnare, dinanzi all’Autorità giurisdizionale amministrativa, il provvedimento formatosi implicitamente col decorso del tempo dopo la presentazione della d.i.a.. Secondo i fautori della seconda tesi, invece, il terzo può esperire un’azione di accertamento autonomo onde far dichiarare l’insussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di cui alla d.i.a..
In passato alcuni studiosi hanno sostenuto, poi, la necessità per il terzo di sollecitare - decorso inutilmente il termine dalla presentazione della d.i.a. - l’intervento in via di autotutela da parte dell’amministrazione competente e, in caso di ulteriore inerzia, di impugnare il silenzio-rifiuto.
Dei tre orientamenti ora richiamati appare, invero, poco convincente quest’ultimo, che imporrebbe al terzo l’onere di presentare, prima di agire in giudizio, un’istanza sollecitatoria alla pubblica amministrazione la quale, peraltro, nell’esercizio dell’autotutela è dotata di un potere ampiamente discrezionale. Nella decisione in merito all’annullamento di un precedente provvedimento, infatti, l’ente pubblico è tenuto a valutare non solo la sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività de qua, ma anche l’affidamento eventualmente generato in capo a chi ha confidato nella legittimità del provvedimento.
La prima delle tesi in esame consente, senza dubbio, di semplificare il regime della tutela dei terzi, perché permette di individuare un provvedimento sia pur implicito da impugnare. Un colpo mortale a questa tesi è stato però inferto, recentemente, dalla entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 che ha riscritto l’art. 19 della legge n. 241, apportando importanti modifiche al regime della d.i.a.. Per alcuni settori - relativi ad impianti di produzione di beni e servizi ed a prestazioni di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - la riforma prevede, infatti, che la data di inizio dell’attività coincida con quella di presentazione della d.i.a..
L’introduzione nel nostro ordinamento della d.i.a. ad effetto immediato - è questa l’espressione con cui si suole definire tale istituto - impone un ripensamento della tesi sulla natura provvedimentale della d.i.a., non potendosi ipotizzare la formazione di un provvedimento implicito di assentimento in mancanza di un sia pur breve intervallo temporale tra la presentazione della denuncia e l’inizio dell’attività. Più aderente al dettato normativo, specie alla previsione di cui all’art. 9 della legge n. 69/2009 sulla d.i.a. ad effetto immediato, appare pertanto la tesi che individua nella denuncia di inizio attività l’atto di un soggetto privato, da cui la legge fa scaturire il legittimo esercizio di alcune attività.
Anche quest’ultima tesi suscita, però, perplessità in merito ai rimedi giurisdizionali che offre ai terzi. In assenza di un provvedimento da impugnare, infatti, il terzo che si ritenga leso dall’attività denunciata dovrebbe chiedere al giudice amministrativo – entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell’attività – di accertare l’insussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività medesima. In caso di sentenza favorevole spetterebbe, poi, all’amministrazione competente vietare la prosecuzione dell’attività ed ordinare la rimozione di quanto eventualmente già eseguito. L’iter processuale appena descritto confligge, in realtà, con la mancata espressa previsione – nel nostro ordinamento processuale amministrativo – dell’azione di accertamento, che inoltre vedrebbe sottoposta al vaglio del giudice amministrativo non un provvedimento né un comportamento di un’autorità amministrativa, bensì il comportamento di un privato cui la legge attribuisce determinati effetti.
Alla peculiarità dell’istituto in esame dovrebbe corrispondere de iure condendo, a parere di chi scrive, una peculiare e più ampia disciplina sia sul piano sostanziale che su quello processuale.
Sarebbe necessario, in primo luogo, chiarire espressamente che nei settori per i quali è prevista la possibilità di presentazione della d.i.a. è sempre possibile seguire la strada tradizionale dell’istanza volta a conseguire un provvedimento autorizzatorio, specificando che chi intenda avvalersi della via più celere non può poi reclamare alcun affidamento generato dal silenzio della pubblica amministrazione. L’assenza di un intervento inibitorio dell’ente pubblico entro i termini previsti dalla legge, infatti, non può essere equiparato alla emissione di un provvedimento amministrativo autorizzatorio. Anche la tutela dell’affidamento, di conseguenza, può essere correttamente invocata solo in presenza di un vero e proprio provvedimento – qualora lo stesso venga successivamente annullato in via di autotutela - e non in caso di mera inerzia dell’amministrazione in seguito alla presentazione di una d.i.a.. In caso contrario gli effetti del - ahi noi frequente - intempestivo intervento pubblico sarebbero catastrofici, dovendo ogni volta il giudice bilanciare, anche in caso di palese violazione della legge, l’interesse pubblico alla cessazione dell’attività illegittima con quello dell’interessato alla prosecuzione della stessa.
Il ricorso al giudice amministrativo, al quale la norma di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 si limita ad attribuire la giurisdizione esclusiva in materia di d.i.a., dovrebbe essere a sua volta oggetto di una disciplina specifica, che contempli: a) i casi in cui sussista l’interesse a ricorrere, prevedendolo per tutti coloro che dall’attività denunciata subiscano svantaggi; b) l’oggetto dell’impugnativa, specificando che eccezionalmente va impugnato l’atto del privato (d.i.a.) piuttosto che un provvedimento pubblico espresso o tacito; c) il petitum, che a nostro parere dovrebbe consistere nella declaratoria della illegittimità dell’attività di cui alla d.i.a., con espresso ordine all’amministrazione competente di inibirne la prosecuzione; d) il termine per la proposizione del ricorso, che andrebbe individuato in quello di sessanta giorni dalla cognizione della denuncia de qua.
Grazie alla disciplina puntuale – che qual “debol parere” abbiamo sopra esposto - sugli effetti della d.i.a. ed i rimedi esperibili dai terzi si potrebbero, probabilmente, scoraggiare gli abusi di uno strumento che, specie dopo la riforma del 2009, può incidere in modo notevole nell’organizzazione dei settori di produzione dei beni e servizi
estratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=11334
di Antonio Macolino
La denuncia di inizio attività rappresenta uno degli istituti giuridici sui quali non si è ancora raggiunta, da parte della dottrina e della giurisprudenza amministrative, una visione comune.
L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico della denuncia di inizio attività (che d’ora in poi definiremo d.i.a.) risale al 1990, specificatamente alla entrata in vigore della ormai nota legge n. 241 sul procedimento amministrativo. L’art. 19 della citata legge prevede, infatti, la possibilità di intraprendere l’esercizio di alcune attività, soggette fino ad allora al rilascio di provvedimenti amministrativi di assentimento, in virtù del mero decorso di un termine dalla presentazione della relativa dichiarazione d’intento, accompagnata dai documenti prescritti.
Tale possibilità viene limitata ai casi in cui l’esercizio di un’attività dipenda semplicemente dalla sussistenza di requisiti e presupposti predeterminati dalla legge, mentre non è richiesta alcuna valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione. Sono inoltre esclusi, dalla sfera di applicazione della d.i.a., alcuni settori per i quali risulta sempre necessario un preventivo intervento di assenso da parte dell’autorità pubblica, quali la difesa nazionale, l’immigrazione, la sicurezza e la salute pubblica, l’amministrazione della giustizia e delle finanze.
Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla d.i.a. è sorto, ed è a tutt’oggi in corso, per la difficoltà di incasellare questo istituto nei tradizionali schemi provvedimentali, tanto soprattutto in relazione all’esigenza di individuare forme di tutela per i terzi le cui posizioni giuridiche vengano coinvolte nelle attività denunciate. Ad alimentare tale dibattito hanno certamente contribuito le modifiche apportate, alla disciplina normativa citata, dalla legge n. 80 del 2005 e, da ultimo, dalla legge n. 69 del 2009.
Le tesi principali sulla natura della d.i.a. e sugli strumenti di tutela dei terzi sono due, entrambe sostenute anche di recente dai giudici amministrativi.
La prima di queste tesi, rinvenibile in alcune pronunzie della quarta (n. 5811/2008) e sesta sezione del Consiglio di Stato (decisione 1550/2007), individua nella d.i.a. un istituto peculiare, assimilabile ad un’istanza autorizzatoria che, col decorso del termine di legge, provoca la formazione di un provvedimento di tacito assenso all’esercizio di una certa attività. Secondo questa impostazione la d.i.a. non è uno strumento di liberalizzazione di alcune attività, ma rappresenta un meccanismo che consente al privato di conseguire, grazie al silenzio assenso della pubblica amministrazione, un pur sempre necessario titolo abilitativo.
A sostegno di questa prima tesi vengono invocati vari argomenti, primo tra tutti l’espressa previsione legislativa della facoltà, per l’amministrazione competente, di assumere provvedimenti in via di autotutela anche dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della d.i.a.. L’autotutela rappresenta, infatti, un’attività amministrativa di secondo grado che presuppone sempre, secondo i fautori della tesi in esame, un provvedimento precedente sul quale incidere.
Un altro argomento a favore della natura provvedimentale del silenzio sulla d.i.a. è offerto, in materia edilizia, dal testo unico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 che estende alla d.i.a. edilizia sia i poteri sanzionatori del Comune previsti in caso di annullamento del permesso di costruire, sia il potere della Regione di annullare il permesso di costruire assentito dal Comune.
La seconda tesi sulla natura giuridica della d.i.a., che si rinviene in una recente pronunzia del Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza 717/2009), qualifica la denuncia di inizio attività come un mero atto di un privato, che non ha alcun valore provvedimentale né produce alcun implicito assentimento da parte della pubblica amministrazione. Secondo questa tesi si può parlare di liberalizzazione per le attività di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 solo se viene meno la necessità di un provvedimento autorizzatorio, espresso o tacito che sia, da parte della amministrazione competente. Solo in quest’ottica si può distinguere, infatti, la disciplina della denuncia di cui all’art. 19 da quella del silenzio assenso di cui all’art. 20 della citata legge. Il silenzio assenso comporta, quello si, la formazione di un provvedimento amministrativo implicito di autorizzazione, in seguito alla presentazione di un’istanza ed al decorso di un certo tempo in assenza di obiezioni da parte dell’amministrazione destinataria dell’istanza.
Alle due contrapposte tesi corrispondono, evidentemente, distinti strumenti di tutela del terzo che ritenga di aver subito lesioni delle proprie posizioni giuridiche.
I sostenitori della prima delle sopra esposte tesi ritengono, infatti, che il terzo possa impugnare, dinanzi all’Autorità giurisdizionale amministrativa, il provvedimento formatosi implicitamente col decorso del tempo dopo la presentazione della d.i.a.. Secondo i fautori della seconda tesi, invece, il terzo può esperire un’azione di accertamento autonomo onde far dichiarare l’insussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di cui alla d.i.a..
In passato alcuni studiosi hanno sostenuto, poi, la necessità per il terzo di sollecitare - decorso inutilmente il termine dalla presentazione della d.i.a. - l’intervento in via di autotutela da parte dell’amministrazione competente e, in caso di ulteriore inerzia, di impugnare il silenzio-rifiuto.
Dei tre orientamenti ora richiamati appare, invero, poco convincente quest’ultimo, che imporrebbe al terzo l’onere di presentare, prima di agire in giudizio, un’istanza sollecitatoria alla pubblica amministrazione la quale, peraltro, nell’esercizio dell’autotutela è dotata di un potere ampiamente discrezionale. Nella decisione in merito all’annullamento di un precedente provvedimento, infatti, l’ente pubblico è tenuto a valutare non solo la sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività de qua, ma anche l’affidamento eventualmente generato in capo a chi ha confidato nella legittimità del provvedimento.
La prima delle tesi in esame consente, senza dubbio, di semplificare il regime della tutela dei terzi, perché permette di individuare un provvedimento sia pur implicito da impugnare. Un colpo mortale a questa tesi è stato però inferto, recentemente, dalla entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 che ha riscritto l’art. 19 della legge n. 241, apportando importanti modifiche al regime della d.i.a.. Per alcuni settori - relativi ad impianti di produzione di beni e servizi ed a prestazioni di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - la riforma prevede, infatti, che la data di inizio dell’attività coincida con quella di presentazione della d.i.a..
L’introduzione nel nostro ordinamento della d.i.a. ad effetto immediato - è questa l’espressione con cui si suole definire tale istituto - impone un ripensamento della tesi sulla natura provvedimentale della d.i.a., non potendosi ipotizzare la formazione di un provvedimento implicito di assentimento in mancanza di un sia pur breve intervallo temporale tra la presentazione della denuncia e l’inizio dell’attività. Più aderente al dettato normativo, specie alla previsione di cui all’art. 9 della legge n. 69/2009 sulla d.i.a. ad effetto immediato, appare pertanto la tesi che individua nella denuncia di inizio attività l’atto di un soggetto privato, da cui la legge fa scaturire il legittimo esercizio di alcune attività.
Anche quest’ultima tesi suscita, però, perplessità in merito ai rimedi giurisdizionali che offre ai terzi. In assenza di un provvedimento da impugnare, infatti, il terzo che si ritenga leso dall’attività denunciata dovrebbe chiedere al giudice amministrativo – entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell’attività – di accertare l’insussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività medesima. In caso di sentenza favorevole spetterebbe, poi, all’amministrazione competente vietare la prosecuzione dell’attività ed ordinare la rimozione di quanto eventualmente già eseguito. L’iter processuale appena descritto confligge, in realtà, con la mancata espressa previsione – nel nostro ordinamento processuale amministrativo – dell’azione di accertamento, che inoltre vedrebbe sottoposta al vaglio del giudice amministrativo non un provvedimento né un comportamento di un’autorità amministrativa, bensì il comportamento di un privato cui la legge attribuisce determinati effetti.
Alla peculiarità dell’istituto in esame dovrebbe corrispondere de iure condendo, a parere di chi scrive, una peculiare e più ampia disciplina sia sul piano sostanziale che su quello processuale.
Sarebbe necessario, in primo luogo, chiarire espressamente che nei settori per i quali è prevista la possibilità di presentazione della d.i.a. è sempre possibile seguire la strada tradizionale dell’istanza volta a conseguire un provvedimento autorizzatorio, specificando che chi intenda avvalersi della via più celere non può poi reclamare alcun affidamento generato dal silenzio della pubblica amministrazione. L’assenza di un intervento inibitorio dell’ente pubblico entro i termini previsti dalla legge, infatti, non può essere equiparato alla emissione di un provvedimento amministrativo autorizzatorio. Anche la tutela dell’affidamento, di conseguenza, può essere correttamente invocata solo in presenza di un vero e proprio provvedimento – qualora lo stesso venga successivamente annullato in via di autotutela - e non in caso di mera inerzia dell’amministrazione in seguito alla presentazione di una d.i.a.. In caso contrario gli effetti del - ahi noi frequente - intempestivo intervento pubblico sarebbero catastrofici, dovendo ogni volta il giudice bilanciare, anche in caso di palese violazione della legge, l’interesse pubblico alla cessazione dell’attività illegittima con quello dell’interessato alla prosecuzione della stessa.
Il ricorso al giudice amministrativo, al quale la norma di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 si limita ad attribuire la giurisdizione esclusiva in materia di d.i.a., dovrebbe essere a sua volta oggetto di una disciplina specifica, che contempli: a) i casi in cui sussista l’interesse a ricorrere, prevedendolo per tutti coloro che dall’attività denunciata subiscano svantaggi; b) l’oggetto dell’impugnativa, specificando che eccezionalmente va impugnato l’atto del privato (d.i.a.) piuttosto che un provvedimento pubblico espresso o tacito; c) il petitum, che a nostro parere dovrebbe consistere nella declaratoria della illegittimità dell’attività di cui alla d.i.a., con espresso ordine all’amministrazione competente di inibirne la prosecuzione; d) il termine per la proposizione del ricorso, che andrebbe individuato in quello di sessanta giorni dalla cognizione della denuncia de qua.
Grazie alla disciplina puntuale – che qual “debol parere” abbiamo sopra esposto - sugli effetti della d.i.a. ed i rimedi esperibili dai terzi si potrebbero, probabilmente, scoraggiare gli abusi di uno strumento che, specie dopo la riforma del 2009, può incidere in modo notevole nell’organizzazione dei settori di produzione dei beni e servizi
estratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=11334
Le morfologia del cervello può essere studiata ai fini della sussistenza - o meno - di un vizio di mente.
Tribunale di Como, Agosto 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Le neuroscienze entrano in Tribunale! Sentenza storica!
--------------------------------------------------------------------------------
Le morfologia del cervello può essere studiata ai fini della sussistenza - o meno - di un vizio di mente.
L'imaging cerebrale
Lo studio in aula si è spostato dalla psiche alla morfologia del cervello dell’imputata. E questa volta i risultati delle “imaging cerebrale” e della genetica molecolare sono stati giudicati coerenti con i comportamenti criminali della donna. In particolare è stata riscontrata un’alterazione nella morfologia dei lobi frontali che hanno il “compito”, tra le altre cose, di controllare il comportamento e l’inibizione degli impulsi, il giudizio critico, il senso morale e la discriminazione tra il bene e il male.
Il passo successivo è stato il confronto tra i risultati dati dagli stessi esami fatti su un gruppo di persone “sane”, equiparabili per età e per sesso. Una comparazione che ha evidenziato delle differenze per quanto riguarda la densità della sostanza grigia in alcune zone fondamentali per inibire il comportamento automatico con un altro, come per regolare la menzogna e per i processi di suggestionabilità o autosuggestionalità nel regolare le azioni aggressive.
FONTE: Sole24Ore
Vedi anche QUI.
31.8.2011, diritto-in-rete.com
--------------------------------------------
Uccise la sorella: per il tribunale è colpa dei geni alterati
Sentenza storica del tribunale di Como: la donna che uccise e bruciò la sorella e tentò di fare lo stesso con la madre agì così a causa di alcune alterazioni a livello cerebrale. Per lei una condanna di soli 20 anni di reclusione
Una sentenza che farà storia, quella emanata dal giudice di Como Luisa Lo Gatto. Perché per la prima volta in Italia – e qualcuno ipotizza al mondo – a carico dell’accusata, la 28enne Stefania Albertani, è stato riconosciuto un vizio parziale di mente a causa di alcune alterazioni in una zona del cervello che ha la funzione di regolare le azioni aggressive.
Andiamo con ordine. La Albertani nel 2009 aveva ucciso la sorella 40enne dandole fuoco. Il corpo carbonizzato della donna era stato ritrovato solo dopo due mesi. Subito i sospetti si concentrarono sulla sorella minore, che fu subito indagata a piede libero. Fu proprio in quel periodo, mentre era sotto controllo delle forze dell’ordine, che la donna cercò di strangolare la madre e di darle fuoco.
Una situazione mentale "disturbata", questo lo si capì subito. Ma che non impedì alla Albertani di essere accusata di omicidio e tentato omicidio. Un’accusa che è sfociata nella decisione storica del gup comasco. Tenendo conto della richiesta dell’avvocato della difesa, la donna è stata sottoposta ad attenti studi sulla morfologia del suo cervello e sul suo patrimonio genetico.
Studi che hanno portato a una conclusione: la Albertani ha dei geni "fuori posto", ha dei fattori, come recita la sentenza, "significativamente associati a un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento". Una forma mentale che ha portato la donna ad avere un vizio parziale di mente che, tradotto in freddi numeri, le ha permesso di ottenere una condanna meno pesante, corrispondente a soli 20 anni di reclusione, da scontare in un istituto in cui possa essere curata.
estratto da: http://como.virgilio.it/primopiano/uccide-sorella-colpa-geni-alterati.html
--------------------------------------------------------------------------------
Le neuroscienze entrano in Tribunale! Sentenza storica!
--------------------------------------------------------------------------------
Le morfologia del cervello può essere studiata ai fini della sussistenza - o meno - di un vizio di mente.
L'imaging cerebrale
Lo studio in aula si è spostato dalla psiche alla morfologia del cervello dell’imputata. E questa volta i risultati delle “imaging cerebrale” e della genetica molecolare sono stati giudicati coerenti con i comportamenti criminali della donna. In particolare è stata riscontrata un’alterazione nella morfologia dei lobi frontali che hanno il “compito”, tra le altre cose, di controllare il comportamento e l’inibizione degli impulsi, il giudizio critico, il senso morale e la discriminazione tra il bene e il male.
Il passo successivo è stato il confronto tra i risultati dati dagli stessi esami fatti su un gruppo di persone “sane”, equiparabili per età e per sesso. Una comparazione che ha evidenziato delle differenze per quanto riguarda la densità della sostanza grigia in alcune zone fondamentali per inibire il comportamento automatico con un altro, come per regolare la menzogna e per i processi di suggestionabilità o autosuggestionalità nel regolare le azioni aggressive.
FONTE: Sole24Ore
Vedi anche QUI.
31.8.2011, diritto-in-rete.com
--------------------------------------------
Uccise la sorella: per il tribunale è colpa dei geni alterati
Sentenza storica del tribunale di Como: la donna che uccise e bruciò la sorella e tentò di fare lo stesso con la madre agì così a causa di alcune alterazioni a livello cerebrale. Per lei una condanna di soli 20 anni di reclusione
Una sentenza che farà storia, quella emanata dal giudice di Como Luisa Lo Gatto. Perché per la prima volta in Italia – e qualcuno ipotizza al mondo – a carico dell’accusata, la 28enne Stefania Albertani, è stato riconosciuto un vizio parziale di mente a causa di alcune alterazioni in una zona del cervello che ha la funzione di regolare le azioni aggressive.
Andiamo con ordine. La Albertani nel 2009 aveva ucciso la sorella 40enne dandole fuoco. Il corpo carbonizzato della donna era stato ritrovato solo dopo due mesi. Subito i sospetti si concentrarono sulla sorella minore, che fu subito indagata a piede libero. Fu proprio in quel periodo, mentre era sotto controllo delle forze dell’ordine, che la donna cercò di strangolare la madre e di darle fuoco.
Una situazione mentale "disturbata", questo lo si capì subito. Ma che non impedì alla Albertani di essere accusata di omicidio e tentato omicidio. Un’accusa che è sfociata nella decisione storica del gup comasco. Tenendo conto della richiesta dell’avvocato della difesa, la donna è stata sottoposta ad attenti studi sulla morfologia del suo cervello e sul suo patrimonio genetico.
Studi che hanno portato a una conclusione: la Albertani ha dei geni "fuori posto", ha dei fattori, come recita la sentenza, "significativamente associati a un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento". Una forma mentale che ha portato la donna ad avere un vizio parziale di mente che, tradotto in freddi numeri, le ha permesso di ottenere una condanna meno pesante, corrispondente a soli 20 anni di reclusione, da scontare in un istituto in cui possa essere curata.
estratto da: http://como.virgilio.it/primopiano/uccide-sorella-colpa-geni-alterati.html
Cassazione penale 17305/2011 Disturbi della personalità e capacità di intendere e volere.
Cassazione penale 17305/2011
--------------------------------------------------------------------------------
Disturbi della personalità e capacità di intendere e volere.
--------------------------------------------------------------------------------
I disturbi della personalità (nevrosi e psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli artt. 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità, globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito e cioè:
a) consistenza e intensità, intese come valore concreto e forte;
b) rilevanza e gravità pesate come dimensione importante del disagio stabilizzato;
c) rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico - emotiva rispetto al fatto illecito.
14.5.2011, diritto-in-rete.com
-------------------------------------------
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 5.5.2011, n. 17305
Ritenuto in fatto
N..A. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 8 aprile 2009 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, ha ridotto la pena a mesi 10 di reclusione per i reati ex art. 337 e 582 c.p., deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
1.) le conformi sentenze dei giudici di merito in punto di colpevolezza.
Con sentenza del 9 gennaio 2007, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Livorno ha affermato la responsabilità di A.N. in ordine ai delitti di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, a lui ascritti al capo A) della rubrica, nonché di danneggiamento aggravato, di cui al capo B) e, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ed applicata la diminuente dei rito, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione, interamente condonata a sensi della legge 241/2006.
La Corte di appello di Firenze con sentenza 8 aprile 2009 accertati i fatti, ha escluso la circostanza che l’imputato fosse affetto da una permanente alterazione dei processi intellettivi, assimilabile alla malattia mentale ex art. 89 c.p., essendo solo desumibile dagli atti, con evidenza, che il suo comportamento violento fu determinato da un contingente stato di agitazione da crisi di astinenza, in assenza di "psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti".
La corte distrettuale peraltro, avuto riguardo ai complessivi criteri di valutazione di cui all’art. 133 c.p., ha ritenuto eccessiva la sanzione inflitta, pur considerando la non trascurabile gravità dei fatti ascritti, avuto riguardo: al particolare stato emotivo del soggetto al momento dei fatti e l’incidenza dello stato di agitazione determinato dalla crisi di astinenza sulle sue condizioni intellettive e volitive in quella situazione; all’omessa valutazione delle attenuanti generiche non essendo stata contestata, relativamente al più grave delitto di cui all’art. 337 c.p., alcuna aggravante.
Considerato in diritto
1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di rigetto della Corte di legittimità.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della mancata applicazione nella specie del disposto dell’art. 89 c.p. ed avuto riguardo alla pronuncia delle S.U. in tema di disturbi gravi di personalità.
Il motivo è infondato attesa la corretta motivazione del giudice del gravame.
Come già detto, la corte distrettuale - in punto di invocata seminfermità di mente dell’imputato - ha ritenuto che nella specie, non vi sia prova che l’imputato fosse affetto da una permanente alterazione dei processi intellettivi, assimilabile alla malattia mentale e rilevante ex art. 89 c.p., essendo solo desumibile dagli atti, con evidenza, che il suo comportamento violento fu determinato da un contingente stato di agitazione da crisi di astinenza, in assenza di "psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti".
Premesso che per "crisi di astinenza", si intende usualmente quello stato di sofferenza psicofisica (idoneo a causare anche reazioni organiche) che colpisce la persona la quale sospende oppure riduce bruscamente il consumo abituale di sostanze (quali alcool, farmaci o droga), idoneo a creare stati di dipendenza, il tenore del gravame impone una breve rassegna delle regole rilevanti sul tema ed avuto riguardo alle pronunce della Corte di legittimità la quale ha più volte ribadito:
a) che non tutti gli stati di tossicomania, la quale è una dipendenza meramente psichica alla droga, o di tossicodipendenza, che è una assuefazione cronica alla stessa, producono di per sé alterazione mentale o disagio psichico rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p., ma solo quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che sono in grado di determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico dell’imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest’ultimo (Cass. pen. sez. 6, 6357/1996 Rv. 205097);
b) che la situazione di tossicodipendenza, in grado di influire sulla capacità di intendere e di volere, è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie e consistenti disagi che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione A strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica. (Cass. pen. sez. 3, 35872/2007 Rv. 237284);
c) che per escludere (o diminuire) l’imputabilità, l’intossicazione da sostanze stupefacenti non solo deve essere cronica (cioè stabile), ma deve produrre un’alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie e disagi che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti; lo stato di tossicodipendenza non costituisce, pertanto, di per sé, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica (Cass. pen. sez. 6,7885/1999 Rv. 214757);
d) che, in ogni caso, in tema di intossicazione acuta dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, per la sussistenza del vizio di mente (totale o parziale) non è sufficiente che il giudice di merito riconduca l’azione dell’imputato ad un modello di infermità apoditticamente affermata, ma, proprio ai fini della corretta qualificazione del vizio, è necessario che indichi e valuti motivatamente i dati anamnestici, clinici, comportamentali, evincibili dalle stesse modalità del fatto, ragionevolmente rivelatori dell’asserito quadro morboso, agli effetti della sua "graduabilità" rispetto all’imputabilità. Cass. pen. sez. 6, 31483/2004 Rv. 229793 );
Orbene, nella specie, la Corte di appello con un giudizio di merito - rispettoso delle regole sub a), b) e c) - in questa sede insindacabile, ha ritenuto che la crisi di astinenza, nei termini rilevati nella condotta dell’accusato, sia stata inidonea a realizzare quella grave compromissione dei processi di intelligenza e volontà richiesta dal legislatore, il quale ha dato all’interprete un grado di misura espresso con l’inequivoca espressione "scemare grandemente".
Nella vicenda comunque, provata l’esistenza di una crisi di astinenza, difetta invece la diversa prova di una realtà di cronica intossicazione o comunque di un disagio psichico capace di indurre una infermità di mente grandemente efficace sulla funzionalità dell’intendere e/o di volere.
Conclusione questa che non può essere invalidata dalla richiamata decisione delle S.U. 9163 del 25 gennaio 2005.
In termini va subito premesso che, secondo la più accreditata e sensibile dottrina psichiatrico - forense e medico legale, nonché per le scienze del comportamento in genere, è ormai pacifico che le nozioni di "capacità di intendere e di volere" e quella di "vizio di mente" non corrispondono a categorie scientifico-naturalistiche. Esse altro non sono che convenzioni giuridiche, nate in un periodo storico dominato dall’ideologia positivista ed ancorato a una psichiatria biologica che non è conforme alle moderne correnti psicodinamiche e fenomenologiche: esse peraltro hanno un contenuto sostanziale che la dottrina e la prassi giurisprudenziale necessariamente si sforzano di adeguare ai tempi, come avvenuto in tema di disturbi gravi di personalità.
Su tale tema infatti un punto nodale di riferimento è notoriamente dato dalla sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005 delle Sezioni Unite, la quale ha stabilito che anche i "disturbi della personalità", come quelli da nevrosi e da psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa.
Peraltro la portata dell’affermazione è stata dalla stessa Corte tarata e ridimensionata con le ulteriori precisazioni che sono state date dalle regole-corollario secondo cui non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali" o gli "stati emotivi e passionali", i quali non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente. È inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal primo.
Per riassumere: i disturbi della personalità (nevrosi e psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli artt. 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità, globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito e cioè:
a) consistenza e intensità, intese come valore concreto e forte;
b) rilevanza e gravità pesate come dimensione importante del disagio stabilizzato;
c) rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico - emotiva rispetto al fatto illecito.
Orbene, venendo al caso di specie, l’affermata mera condizione di un generico stato di agitazione da crisi da astinenza, in capo all’autore della condotta illecita (di resistenza violenta, di lesioni e di danneggiamento), non accompagnata da altre provate indicazioni in termini di grande e grave disassamento, da infermità, delle funzioni noetiche e volitive dell’agente, non integra lo schema dogmatico dell’art. 89 c.p., dato che essa realizza una mera condizione di stato emotivo e passionale, non incidente ex art. 90 c.p. sugli ambiti dell’intendere e del volere, anche se utilizzabile, come avvenuto nella gravata sentenza in termini di graduazione del trattamento sanzionatorio.
Il motivo va quindi rigettato.
Con un secondo motivo si lamenta la mancata applicazione nel massimo delle ritenute e riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Il motivo per come formulato è inammissibile: i giudici di merito, con argomentazione non censurabile in questa sede, hanno applicato le circostanze attenuanti generiche per il reato più grave in misura diversa da quella massima, avuto riguardo ai reati satelliti e ai pesanti precedenti penali dell’imputato.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
estratto da http://www.diritto-in-rete.com/sentenza.asp?id=1058
--------------------------------------------------------------------------------
Disturbi della personalità e capacità di intendere e volere.
--------------------------------------------------------------------------------
I disturbi della personalità (nevrosi e psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli artt. 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità, globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito e cioè:
a) consistenza e intensità, intese come valore concreto e forte;
b) rilevanza e gravità pesate come dimensione importante del disagio stabilizzato;
c) rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico - emotiva rispetto al fatto illecito.
14.5.2011, diritto-in-rete.com
-------------------------------------------
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 5.5.2011, n. 17305
Ritenuto in fatto
N..A. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 8 aprile 2009 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, ha ridotto la pena a mesi 10 di reclusione per i reati ex art. 337 e 582 c.p., deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
1.) le conformi sentenze dei giudici di merito in punto di colpevolezza.
Con sentenza del 9 gennaio 2007, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Livorno ha affermato la responsabilità di A.N. in ordine ai delitti di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, a lui ascritti al capo A) della rubrica, nonché di danneggiamento aggravato, di cui al capo B) e, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ed applicata la diminuente dei rito, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione, interamente condonata a sensi della legge 241/2006.
La Corte di appello di Firenze con sentenza 8 aprile 2009 accertati i fatti, ha escluso la circostanza che l’imputato fosse affetto da una permanente alterazione dei processi intellettivi, assimilabile alla malattia mentale ex art. 89 c.p., essendo solo desumibile dagli atti, con evidenza, che il suo comportamento violento fu determinato da un contingente stato di agitazione da crisi di astinenza, in assenza di "psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti".
La corte distrettuale peraltro, avuto riguardo ai complessivi criteri di valutazione di cui all’art. 133 c.p., ha ritenuto eccessiva la sanzione inflitta, pur considerando la non trascurabile gravità dei fatti ascritti, avuto riguardo: al particolare stato emotivo del soggetto al momento dei fatti e l’incidenza dello stato di agitazione determinato dalla crisi di astinenza sulle sue condizioni intellettive e volitive in quella situazione; all’omessa valutazione delle attenuanti generiche non essendo stata contestata, relativamente al più grave delitto di cui all’art. 337 c.p., alcuna aggravante.
Considerato in diritto
1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di rigetto della Corte di legittimità.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della mancata applicazione nella specie del disposto dell’art. 89 c.p. ed avuto riguardo alla pronuncia delle S.U. in tema di disturbi gravi di personalità.
Il motivo è infondato attesa la corretta motivazione del giudice del gravame.
Come già detto, la corte distrettuale - in punto di invocata seminfermità di mente dell’imputato - ha ritenuto che nella specie, non vi sia prova che l’imputato fosse affetto da una permanente alterazione dei processi intellettivi, assimilabile alla malattia mentale e rilevante ex art. 89 c.p., essendo solo desumibile dagli atti, con evidenza, che il suo comportamento violento fu determinato da un contingente stato di agitazione da crisi di astinenza, in assenza di "psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti".
Premesso che per "crisi di astinenza", si intende usualmente quello stato di sofferenza psicofisica (idoneo a causare anche reazioni organiche) che colpisce la persona la quale sospende oppure riduce bruscamente il consumo abituale di sostanze (quali alcool, farmaci o droga), idoneo a creare stati di dipendenza, il tenore del gravame impone una breve rassegna delle regole rilevanti sul tema ed avuto riguardo alle pronunce della Corte di legittimità la quale ha più volte ribadito:
a) che non tutti gli stati di tossicomania, la quale è una dipendenza meramente psichica alla droga, o di tossicodipendenza, che è una assuefazione cronica alla stessa, producono di per sé alterazione mentale o disagio psichico rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p., ma solo quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che sono in grado di determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico dell’imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest’ultimo (Cass. pen. sez. 6, 6357/1996 Rv. 205097);
b) che la situazione di tossicodipendenza, in grado di influire sulla capacità di intendere e di volere, è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie e consistenti disagi che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione A strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica. (Cass. pen. sez. 3, 35872/2007 Rv. 237284);
c) che per escludere (o diminuire) l’imputabilità, l’intossicazione da sostanze stupefacenti non solo deve essere cronica (cioè stabile), ma deve produrre un’alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie e disagi che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti; lo stato di tossicodipendenza non costituisce, pertanto, di per sé, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica (Cass. pen. sez. 6,7885/1999 Rv. 214757);
d) che, in ogni caso, in tema di intossicazione acuta dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, per la sussistenza del vizio di mente (totale o parziale) non è sufficiente che il giudice di merito riconduca l’azione dell’imputato ad un modello di infermità apoditticamente affermata, ma, proprio ai fini della corretta qualificazione del vizio, è necessario che indichi e valuti motivatamente i dati anamnestici, clinici, comportamentali, evincibili dalle stesse modalità del fatto, ragionevolmente rivelatori dell’asserito quadro morboso, agli effetti della sua "graduabilità" rispetto all’imputabilità. Cass. pen. sez. 6, 31483/2004 Rv. 229793 );
Orbene, nella specie, la Corte di appello con un giudizio di merito - rispettoso delle regole sub a), b) e c) - in questa sede insindacabile, ha ritenuto che la crisi di astinenza, nei termini rilevati nella condotta dell’accusato, sia stata inidonea a realizzare quella grave compromissione dei processi di intelligenza e volontà richiesta dal legislatore, il quale ha dato all’interprete un grado di misura espresso con l’inequivoca espressione "scemare grandemente".
Nella vicenda comunque, provata l’esistenza di una crisi di astinenza, difetta invece la diversa prova di una realtà di cronica intossicazione o comunque di un disagio psichico capace di indurre una infermità di mente grandemente efficace sulla funzionalità dell’intendere e/o di volere.
Conclusione questa che non può essere invalidata dalla richiamata decisione delle S.U. 9163 del 25 gennaio 2005.
In termini va subito premesso che, secondo la più accreditata e sensibile dottrina psichiatrico - forense e medico legale, nonché per le scienze del comportamento in genere, è ormai pacifico che le nozioni di "capacità di intendere e di volere" e quella di "vizio di mente" non corrispondono a categorie scientifico-naturalistiche. Esse altro non sono che convenzioni giuridiche, nate in un periodo storico dominato dall’ideologia positivista ed ancorato a una psichiatria biologica che non è conforme alle moderne correnti psicodinamiche e fenomenologiche: esse peraltro hanno un contenuto sostanziale che la dottrina e la prassi giurisprudenziale necessariamente si sforzano di adeguare ai tempi, come avvenuto in tema di disturbi gravi di personalità.
Su tale tema infatti un punto nodale di riferimento è notoriamente dato dalla sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005 delle Sezioni Unite, la quale ha stabilito che anche i "disturbi della personalità", come quelli da nevrosi e da psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa.
Peraltro la portata dell’affermazione è stata dalla stessa Corte tarata e ridimensionata con le ulteriori precisazioni che sono state date dalle regole-corollario secondo cui non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali" o gli "stati emotivi e passionali", i quali non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente. È inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal primo.
Per riassumere: i disturbi della personalità (nevrosi e psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli artt. 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità, globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito e cioè:
a) consistenza e intensità, intese come valore concreto e forte;
b) rilevanza e gravità pesate come dimensione importante del disagio stabilizzato;
c) rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico - emotiva rispetto al fatto illecito.
Orbene, venendo al caso di specie, l’affermata mera condizione di un generico stato di agitazione da crisi da astinenza, in capo all’autore della condotta illecita (di resistenza violenta, di lesioni e di danneggiamento), non accompagnata da altre provate indicazioni in termini di grande e grave disassamento, da infermità, delle funzioni noetiche e volitive dell’agente, non integra lo schema dogmatico dell’art. 89 c.p., dato che essa realizza una mera condizione di stato emotivo e passionale, non incidente ex art. 90 c.p. sugli ambiti dell’intendere e del volere, anche se utilizzabile, come avvenuto nella gravata sentenza in termini di graduazione del trattamento sanzionatorio.
Il motivo va quindi rigettato.
Con un secondo motivo si lamenta la mancata applicazione nel massimo delle ritenute e riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Il motivo per come formulato è inammissibile: i giudici di merito, con argomentazione non censurabile in questa sede, hanno applicato le circostanze attenuanti generiche per il reato più grave in misura diversa da quella massima, avuto riguardo ai reati satelliti e ai pesanti precedenti penali dell’imputato.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
estratto da http://www.diritto-in-rete.com/sentenza.asp?id=1058
Iscriviti a:
Post (Atom)
Debito pubblico pro-capite
Contatore del debito pubblico italiano
Amore e Psiche

Maddalena - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!