La nuova disciplina dei licenziamenti: una legge malfatta
Articolo 11.07.2012 (Mario Meucci)
Sommario
1. Premessa
2. La reintegrazione quale sanzione del licenziamento illegittimo: ieri e oggi
3. Le conseguenze per il licenziamento discriminatorio
4. Le conseguenze per il licenziamento illegittimo disciplinare (disposto per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa)
5. Le conseguenze per il licenziamento illegittimo disposto per giustificato motivo oggettivo (cd. economico)
6. Le inconsistenti conseguenze del licenziamento inefficace
7. Le modifiche di favore alla parte datoriale apportate alla disciplina dei licenziamenti collettivi
1. Premessa
 L’etichettatura di “legge malfatta” che una parte della dottrina giuslavoristica degli anni ‘70 assegnò allo Statuto dei lavoratori (che non la meritava) va, invece, - indiscutibilmente e più pertinentemente - utilizzata per la cd. “riforma del mercato del lavoro” pubblicata sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 - S.O. n.136, come Legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, con entrata in vigore al 18 luglio 2012.
L’etichettatura di “legge malfatta” che una parte della dottrina giuslavoristica degli anni ‘70 assegnò allo Statuto dei lavoratori (che non la meritava) va, invece, - indiscutibilmente e più pertinentemente - utilizzata per la cd. “riforma del mercato del lavoro” pubblicata sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 - S.O. n.136, come Legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, con entrata in vigore al 18 luglio 2012.
Ciò per effetto del riscontro dei numerosi difetti tecnici che la caratterizzano e che ne rendono ostica la comprensione anche agli stessi addetti ai lavori.
Conviene subito evidenziare che tali difetti non sono stati rilevati solo da noi – che taluno potrebbe ascrivere alla nostra non condivisione delle linee guida del provvedimento che hanno ispirato il neo legislatore – in quanto nel rilievo siamo in (buona) compagnia di numerosi giuristi oltreché con gli estensori del Parere della Commissione per la legislazione – trasmesso alla Camera dal Presidente del Senato il 1 giugno 2012 - relativo al disegno di legge, destinato a divenire la nuova legge n. 92/2012.
Al riguardo il Parere segnala, tra gli altri, che «taluni difetti di coordinamento con la normativa vigente si riscontrano, più in generale, tra le disposizioni introdotte dal disegno di legge in oggetto e la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 300 del 1970, da un lato, e il decreto legislativo n. 276 del 2003, dall’altro, nonché con le disposizioni contenute nel codice di procedura civile agli articoli 409 e seguenti, nella parte in cui si disciplina il rito del lavoro»; che «in termini ancor più generali, inoltre, il provvedimento, talvolta, innova l’ordinamento previgente senza tuttavia coordinarsi con esso in modo compiuto ma ad esso sovrapponendosi». Ed ancora, «il disegno di legge si rapporta inoltre alla normativa vigente procedendo perlopiù mediante richiami effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio», e, «infine, il disegno di legge si caratterizza per l’introduzione, in relazione alla disciplina di numerosi istituti, di discipline a regime, cui si affiancano disposizioni aventi carattere transitorio; peraltro, le suddette discipline non sempre risultano coordinate e appaiono, talvolta, dislocate nell’ambito di partizioni del testo anche parecchio distanziate tra loro, rendendo così ardua per l’interprete la ricostruzione della disciplina in concreto applicabile». Tanto per esemplificare!
Anche la maggioranza dei giuslavoristi riuniti nell’A.I.D.La.SS. (Associazione Italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) – che ha tenuto il XVII Congresso nazionale a Pisa in data 7-9 giugno 2012 - ha espresso una valutazione decisamente critica sul disegno di legge ora trasformato in legge, incentrata essenzialmente – come è stato detto - sulla non condivisione a tacer d’altro: a) dell’introdotta articolazione in più livelli dell’apparato sanzionatorio del licenziamento illegittimo, finalizzato a ridurre la tutela reale (reintegra) a favore della tutela indennitaria (monetizzazione); b) delle complesse alchimie che scompongono e ricompongono i presupposti che legittimano i licenziamenti; c) della predisposizione di un procedimento giurisdizionale ad hoc per il contenzioso sui licenziamenti.
I relatori e gli interventori hanno espresso – in maggioranza - l’intendimento, di non assecondare supinamente l’obbiettivo del neo legislatore di diminuire le tutele del licenziamento, sulla base della scelta di porre al centro del sistema non più la “tutela reintegratoria piena”, bensì le “tutele minori” introdotte dal testo di riforma (”tutela reintegratoria attenuata” e “tutela indennitaria forte”, di cui diremo in prosieguo) e di accingersi, quali giuslavoristi, a orientare l’interpretazione della nuova legge secondo un’ottica mirata a ridurre al minimo gli effetti della scelta perseguita dal nuovo legislatore, in coerenza con le manifestate valutazioni critiche del disegno di legge ora sfociato nel provvedimento legislativo. Il che appare decisamente significativo!
Per completezza informativa va segnalato che questo dichiarato intendimento si è attirato l’addebito di far apparire all’opinione pubblica la comunità dei giuslavoristi, più come un “partito” che come una “comunità scientifica”; addebito, peraltro, respinto adducendo e rivendicando il legittimo diritto di critica delle non condivise soluzioni governative, al fine di orientare quelle future in una direzione più equilibrata e meno sbilanciata a danno della parte debole del rapporto di lavoro; anche per garantire ai lavoratori colpiti da illegittimi licenziamenti l’integrale risarcimento del danno subito con la privazione del posto di lavoro, per niente assicurato dai “tetti” apposti agli indennizzi monetari articolatamente introdotti e con i quali la cd. riforma ha traguardato l’obbiettivo del ridimensionamento della tutela reale a vantaggio di quella obbligatoria monetizzante. Ridimensionamento motivato, dai sostenitori della legge in commento, con l’esigenza di un allineamento del nostro Paese agli assetti standard dei paesi comunitari, che si asserisce essere caratterizzati da una prevalenza della tutela obbligatoria (che consente la monetizzazione del danno da licenziamento) su quella reale ripristinatoria del rapporto, mediante reintegra nel posto precedentemente occupato.
La riforma ha scontentato tutti, osservandosi, dai sostenitori degli interessi della parte datoriale - che nutriva l’aspettativa di una ben più incisiva rivisitazione dell’art. 18 Stat. lav. - che la situazione è stata invece, se possibile, peggiorata per quanto riguarda la “flessibilità in uscita”. Infatti, in luogo di una disciplina che – a loro avviso - pur con i suoi innegabili difetti, poteva tutto sommato dirsi “certa”, la riforma – sempre a loro avviso - impone una rivisitazione che fa della discrezionalità (e dunque opinabilità) del Giudice l’unico punto fermo, ampliando conseguentemente l’imponderabilità, per i datori, dei rischi connessi ad un licenziamento ingiustificato.
Quanto alle linee guida della nuova legge, innanzi appena menzionate, va detto che esse risiedono nella volontà del neo legislatore di effettuare una profonda revisione delle conseguenze sanzionatorie del licenziamento illegittimo – finora ragionevolmente delineate dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ed ora innovate attraverso una riscrittura dell’art. 18 medesimo – tramite l’introduzione di una contorta articolazione delle cd. “sanzioni – conseguenza” dell’accertato licenziamento illegittimo.
Sanzioni che spaziano da una “reintegrazione”, circoscritta eminentemente al licenziamento discriminatorio e ritorsivo, fino a prevalenti “monetizzazioni” del licenziamento illegittimo riconducibile al giustificato motivo oggettivo di natura economica (riposante su “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”), attraverso le quali il legislatore indennizza - con legittimazione giudiziale alla risoluzione del rapporto quale proprio obbiettivo raggiunto - anche la fattispecie del licenziamento illegittimo (cd. “speculativo”) adottato dall’impresa che abbia riscontrato in bilancio un calo di profitti o intenda incrementarne gli attuali, oltreché razionalizzare e riorganizzare il proprio assetto tecnologico, produttivo e distributivo.
2. La reintegrazione quale sanzione del licenziamento illegittimo: ieri e oggi
Sul diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, la riforma ha inteso intervenire partendo dal falso presupposto che un’eccessiva rigidità in uscita risulta di ostacolo all’incremento occupazionale, in quanto il superamento delle soglie numeriche previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (più di 15 dipendenti in ambito comunale o di sede, filiale, stabilimento o unità produttiva, oppure 60 dipendenti a livello nazionale) - comportando l’applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro in presenza di un licenziamento illegittimo - scoraggerebbe altresì gli investimenti stranieri nel Paese, giacché preclusiva dei “desiderata” datoriali di risolvere discrezionalmente i rapporti di lavoro.
Per effetto dell’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, fino a prima dell’entrata in vigore dell’innovata disciplina, un licenziamento illegittimo, nullo o inefficace – sia disposto per giusta causa sia per giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all’organizzazione dell’impresa), sia per giustificato motivo soggettivo (per notevole inadempimento agli obblighi contrattuali) - era tutelato con la reintegrazione nel posto di lavoro, la quale assicurava congiuntamente il diritto del dipendente: a) al ripristino del rapporto di lavoro, con effetti dal giorno della sua interruzione; b) a percepire le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, detratto il cd. aliunde perceptum, cioè l’eventuale reddito realizzato per lo svolgimento, medio tempore, di un’altra attività lavorativa, subordinata o autonoma; c) all’accreditamento contributivo, mediante il versamento - ad integrale carico del datore - della dovuta contribuzione previdenziale sia per la quota datoriale che per quella del lavoratore (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 4 aprile 2008, n. 8800).
Inoltre la sanzione della reintegrazione era operativa al riscontro di un licenziamento illegittimo per qualsiasi violazione formale nella quale fosse incorso il datore di lavoro nella formulazione o formalizzazione del licenziamento, contravvenendo cioè sia alle prescrizioni dell’art. 2, l. n. 604/1966 (obbligo di comunicazione scritta del provvedimento e delle ragioni poste a fondamento del recesso per giustificato motivo), sia alla procedura individuata dall’art. 7 Stat. lav., afferente al procedimento disciplinare.
Per effetto, poi, della disposizione dell’art. 3, l. n. 108/1990, l’obbligo della reintegrazione trovava sempre applicazione - indipendentemente dall’assetto dimensionale del datore di lavoro (sia al disotto sia al disopra dei 15 dipendenti) - qualora il licenziamento fosse stato disposto per motivi discriminatori o ritorsivi (es., per aver il lavoratore effettuato un ricorso alla magistratura per la rivendicazione di propri diritti violati o crediti retributivi maturati).
Con la nuova disciplina, appare in tutta evidenza che il neo legislatore ha focalizzato la propria attenzione sull’art. 18 dello Stat. lav., in un’ottica di depotenziamento della tutela reale-reintegratoria, misura a suo tempo approntata dal legislatore statutario in quanto la sola riconosciuta idonea a rendere effettiva la riaffermazione dei diritti violati. Al realizzato depotenziamento si è accompagnato, contestualmente, un deliberato e perseguito arretramento sul versante del rispetto della dignità e della libertà dei lavoratori, atteso che la sanzione della reintegra costituiva un baluardo difensivo dei suddetti valori, nonché, al tempo stesso, un deterrente alla loro negazione nella concreta vita aziendale, da parte datoriale. L’art.18, infatti – come è stato rilevato - innescava un circolo virtuoso, perché mentre tutelava l’estinzione del rapporto, rendeva più democratica la gestione del medesimo nel corso del suo svolgimento; «consentendo al lavoratore di dire qualche no e garantendo nei fatti il godimento dei diritti civili e sindacali in azienda» - come è stato incisivamente osservato dal giudice del lavoro R. Riverso – secondo cui «la norma aveva favorito la democratizzazione di tutta la società italiana, sottraendo milioni di persone al ricatto della perdita del posto e consentendo l'effettiva esplicazione dei diritti del lavoro. Il principio della stabilità reale era, infatti, un imprescindibile presidio di contrasto agli abusi dell’imprenditore e la sola condizione che rendeva possibile l’esercizio dei diritti sindacali e delle azioni giudiziarie da parte dei lavoratori nel corso del rapporto di lavoro».
Acuti commentatori della cd. “riforma del mercato del lavoro” (in senso regressivo, secondo noi), non hanno mancato di sottolineare come «fin dai primi annunci in ordine al progetto di intervento sulla flessibilità in uscita è apparso chiaro che l’obiettivo di riforma si sarebbe focalizzato essenzialmente sull’art. 18 dello Statuto, a torto o a ragione considerato il nodo cruciale in materia; e non a caso ne è stata modificata la rubrica, non più limitata alla “Reintegrazione nel posto di lavoro”, ma, in prospettiva ben più ampia, coinvolgente la “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”, dove peraltro la maggiore ampiezza si riferisce agli ambiti e non certo allo spessore della tutela» [1].
Altri fini giuslavoristi hanno rilevato che se l’intento della riforma era la prevedibilità e la riduzione dei costi per il datore di lavoro, connessi e conseguenti alle lungaggini giudiziarie per giungere a sentenza – obbiettivo che il neo legislatore ha ipotizzato essere conseguibile tramite l’introduzione di un rito processuale speciale ed accelerato per il contenzioso sui licenziamenti - «in verità, con la sua impostazione, (…) ci fa capire che in gioco non c’è solo un problema di costi, ma anche un problema di potere. Infatti, la sanzione meramente risarcitoria, alla quale si lascerebbero ampi spazi a detrimento di quella ripristinatoria, consentirebbe di rimettere nelle mani del datore di lavoro la facoltà di produrre comunque l’effetto estintivo del rapporto di lavoro»[2]. Ed ancora si era auspicato, nel commentare il disegno di legge, poi convertito nell’odierna legge, che: «vi dovrebbe essere consapevolezza che l’attuale turbolento contesto richiede da parte del legislatore la promozione di una cultura concertativa tra le parti sociali, a tutti i livelli. Il disegno del governo non valorizza questa cultura, valorizza la decisione solitaria del datore di lavoro»[3].
Ancor più incisivamente, da altri è stato affermato che «la riforma del mercato del lavoro (…) in aperto e preoccupante contrasto con le ingannevoli affermazioni dei suoi promotori, esprime una concezione essenzialmente filo imprenditoriale delle relazioni industriali, una conseguente marginalizzazione della dignità del lavoro, una larga accettazione della frammentazione delle tipologie contrattuali a carattere prevalentemente precario, uno svuotamento delle garanzie per i casi di licenziamento ed una visione del welfare insensibile e comunque del tutto inadeguata alle esigenze essenziali dei cittadini»[4].
A questo preciso scopo la cd. riforma del mercato del lavoro frantuma l’assetto del vecchio articolo 18 Stat. lav., introducendo una complessa ed articolata pluralità di diversificate sanzioni al riscontro del licenziamento illegittimo, tese a circoscrivere la reintegrazione alla (pressoché sola) fattispecie del licenziamento discriminatorio o ritorsivo e a sostituirvi, per le altre fattispecie di licenziamento illegittimo, la risoluzione del rapporto di lavoro accompagnata da una monetizzazione risarcitoria di più o meno varia e inadeguata entità (di cui diremo in prosieguo).
Per la precisione, la vecchia tutela reintegratoria di cui all’art. 18 Stat. lav., è stata scomposta in 4 livelli o misure sanzionatorie del licenziamento illegittimo correlate, in diretta dipendenza, alle ragioni o causali del licenziamento illegittimo. Misure riassumibili[5] nella “reintegrazione ad effetti risarcitori pieni” (art. 18, commi 1°, 2° e 3°); nella “reintegrazione ad effetti risarcitori limitati” a 12 mensilità per il “periodo intermedio” (art. 18, comma 4°); nella “tutela obbligatoria forte” caratterizzata da un risarcimento meramente indennitario, sostitutivo del posto di lavoro, compreso tra 12 e 24 mensilità (art. 18, comma 5°); nella “tutela obbligatoria debole”, esclusivamente indennitaria, con risarcimento compreso tra 6 e 12 mensilità, sostitutivo della perdita del posto di lavoro (art. 18, comma 6°).
3. Le conseguenze per il licenziamento discriminatorio
In termini generali va sottolineato che il criterio della reintegrazione nel posto di lavoro - che rappresentò la vera novità dell’art.18 e che costituiva la regola in tutte le ipotesi in cui il licenziamento veniva riscontrato nullo, inefficace o comunque invalido - viene dalla cd. “riforma del mercato del lavoro” ad essere degradato a mera eccezione, tranne che nei licenziamenti discriminatori, in cui resta sostanzialmente fermo l’impianto normativo preesistente.
Per l’individuazione del licenziamento discriminatorio, il nuovo legislatore rinvia per relationem alle specificazioni di cui all’art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (la quale rinvia alle previsioni dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300), ove in quest’ultime è dato registrare il divieto di discriminazione in relazione al solo «credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato e alla partecipazione ad attività sindacali»; si registra, quindi, una pretermissione da parte del neo legislatore delle più esaustive ipotesi codificate nell’art. 2 del d.lgs. n. 216/2003, secondo cui la nozione di discriminazione si estende alla diversificazione di trattamento «a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale», consentendo così al lettore di fare un assaggio di quelle omissioni, imprecisioni e deficienze che sono abbastanza usuali nel testo della nuova legge. Alle menzionate ipotesi discriminatorie, il neo legislatore addiziona, poi, correttamente, il licenziamento intimato in concomitanza col matrimonio (ai sensi dell’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del T. U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni).
Alle surriferite fattispecie di licenziamento discriminatorio, il comma 1 del nuovo art. 18 accorda e assicura la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato, reintegrazione che - sempre il comma 1 in questione - conferisce altresì al licenziamento parimenti illegittimo perché riconducibile ad «altri casi di nullità previsti dalla legge o perché determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile», entrambi caratterizzati da assoluta difficoltà di individuazione da parte dell’interprete giudiziario. Alla reintegrazione il legislatore accompagna - tramite il comma 2 e dietro ordine giudiziale - la corresponsione risarcitoria a carico del datore di lavoro di una indennità compresa tra le 5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (cd. aliunde perceptum), nonché l’onere datoriale della relativa contribuzione previdenziale.
Stavolta meritoriamente, il neo legislatore precisa, poi, nell’ultimo disposto del comma 1, che la sanzione della reintegrazione - accompagnata dall’indennità risarcitoria compresa tra le 5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto e dedotto l’aliunde perceptum - si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, così risolvendo un contrastante contenzioso e precludendone la reiterazione in futuro.
Viene poi confermato che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, dell’art. 1 - al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (reiterando, così, la previgente disciplina al riguardo) la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale (recependo così il consolidato orientamento giurisprudenziale: cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 7 marzo 2003, n. 3487). La richiesta dell’indennità sostitutiva della reintegrazione deve essere effettuata dal lavoratore entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Dispone, il comma 4 dell’art. 1, che: «Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (cioè dedotto, in tal caso, sia l’aliunde perceptum che l’aliunde percipiendum, ndr). In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione (…). A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma (c.d. 15 mensilità, ndr)».
Relativamente alla deduzione dell’aliunde perceptum, resta naturalmente fermo l’orientamento giurisprudenziale[6] che sostiene che spetta al datore di lavoro dimostrare sia l’esistenza una nuova occupazione del lavoratore che il reddito conseguente[7].
Niente si precisa da parte del legislatore – in ordine al procedimento di sottrazione dell’aliund percipiendum dall’indennità risarcitoria – ai fini di chiarire se l’obbligo della diligente ricerca occupazionale gravi sul lavoratore solo in relazione ad occupazioni in mansioni equivalenti alle precedenti – come finora giurisprudenzialmente riconosciuto – ovvero in relazione a qualsiasi altra occupazione anche dequalificata, giustificatamente rifiutabile.
Segue il comma 5, recitando che: «Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento (della sola, ndr) indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo».
Il punto centrale del combinato disposto del comma 4 e del comma 5, risiede tutto nell’individuazione di quale sia la fattispecie di licenziamento ingiustificato che, per gravità e spessore, porta all’applicazione di una tutela ancora reale e quali le “altre ipotesi” cui, ai sensi del comma 5, è ora riservata la sola tutela indennitaria.
La reintegrazione è ancora assicurata, anzitutto, allorché il licenziamento sia ingiustificato «per insussistenza del fatto contestato».
A parte la difficoltà di individuare quando ricorre la fattispecie del “fatto contestato” giacché – come è stato notato – i fatti hanno molte sfaccettature e, in concreto, ci si può imbattere in una contestazione disciplinare di più fatti (con la difficoltà di sapere se sia sufficiente a caducare l’addebito plurimo, la sola insussistenza di uno, quello prevalente, rispetto alla sussistenza degli eventuali altri), riteniamo condivisibile l’ opinione dottrinale, secondo cui: «il comma 4 e la reintegrazione si applicano quando la procedura disciplinare risulti imbastita sul nulla, o su grossi equivoci, più o meno imputabili al datore di lavoro ma in ogni caso non troppo difficilmente accertabili; detta sotto il profilo qualitativo, in situazioni nelle quali il licenziamento disciplinare illegittimo abbia finito col ledere l’onorabilità della persona del lavoratore, in linea con la convinzione che la reintegrazione debba essere riservata, come nel primo comma, a garanzia dei diritti assoluti del lavoratore (…)»[8].
La seconda ipotesi codificata nel disposto «perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili» individua, senza difficoltà, il caso - piuttosto infrequente - in cui il datore di lavoro abbia commesso lo sbaglio di applicare la sanzione espulsiva laddove le diverse fonti contrattuali o disciplinari del regolamento aziendale prevedano una sanzione solo conservativa.
Ma il testo della legge, al comma 5 del nuovo art. 18, afferma che vi sono anche “altre ipotesi” in cui il Giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, ipotesi nelle quali l’illegittimità del licenziamento dovrebbe essere da lui sanzionata con il risarcimento. Al riguardo, in dottrina, è stata tratta la seguente condivisibile considerazione: «Questo allora vuol dire che l’estensore del testo ha voluto usare una formula ellittica per esprimere l’intenzione di evitare la reintegrazione ogniqualvolta il giudice si trovi a giudicare di comportamenti astrattamente rientranti in casi previsti dai contratti collettivi come legittimanti il licenziamento, ma da lui valutati come inidonei a rivestire il grado di gravità richiesto dalla fattispecie legale (si pensi ad esempio al furto, previsto da contratti collettivi come legittimante il licenziamento, ma talvolta dalla giurisprudenza valutato non sufficiente a giustificare il licenziamento quando riguardi beni di modico valore)»[9]. Pertanto in tutte queste “altre ipotesi” per le quali il Giudice ritenga sproporzionata ex art. 2106 c.c. la sanzione espulsiva e sarebbe stato indotto, nel vecchio assetto, a disporre la reintegrazione con conversione della sanzione espulsiva in altra di natura conservativa, ora – con tutta probabilità, stante allo stato le controverse opinioni dottrinali al riguardo - dovrebbe disporre la risoluzione del rapporto accompagnata da un indennizzo risarcitorio, peraltro limitato ad un importo compreso tra 12 e 24 mensilità della retribuzione, quale che sia stato l’arco di tempo intercorso tra il recesso e la sentenza che ne dichiari l’illegittimità, «implicitamente affermandosi così il principio, contrario ad una radicata tradizione civilistica, secondo cui la durata del processo giuocherebbe in danno del lavoratore anche quando la domanda da lui proposta abbia trovato pieno accoglimento»[10].
Conclusivamente può affermarsi – come è stato osservato - che: «si applicherà il comma 4 nelle ipotesi non frequenti nelle quali venga disattesa la tipizzazione (disciplinare, ndr) mentre si applicherà il comma 5 nelle “altre ipotesi”, cioè, con frequenza ben maggiore, tutte le volte in cui la tipizzazione (disciplinare, ndr) sia stata rispettata, ma il licenziamento sia giudicato illegittimo per altre ragioni, legate alle contingenze concrete, come lo stato psicologico del lavoratore e il suo grado di colpevolezza, la posizione ricoperta in azienda, il livello di professionalità, la rilevanza delle conseguenze dannose del comportamento ecc. L’ambito di applicazione della reintegrazione risulterà perciò alquanto ristretto (…)»[11]. Emerge, quindi, confermativamente, la netta prevalenza accordata dal neo legislatore – nonostante la “mediazione” correttiva a livello politico, più che sindacale – alla tutela indennitaria rispetto a quella reintegratoria[12].
Venendo all’individuazione dell’astratta fattispecie suscettibile di strutturare le c.d. “altre ipotesi” menzionate nel primo alinea del comma 5 del “nuovo” art. 18 - e rispetto alla quale il Giudice disporrà, in caso di illegittimo recesso, l’applicazione della sola tutela risarcitoria - sembra possa affermarsi che è quella per la quale risultino accertati, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) che la condotta censurabile contestata al lavoratore risulti essere stata effettivamente tenuta; b) che la condotta non rientra in una delle fattispecie rispetto alle quali il contratto collettivo o il codice disciplinare applicabile prevede una sanzione conservativa, ma una sanzione espulsiva ovvero che non è stata affatto tipizzata nel codice disciplinare; c) che il Giudice ritiene che quella condotta censurabile non sia idonea ad incidere sull’affidamento fiduciario riposto nel lavoratore e, quindi, non ritiene che possa costituire il presupposto per la risoluzione del rapporto di lavoro; conseguentemente, qualora la condotta sia tipizzata con sanzione espulsiva ne effettua la cd. “derubricazione” – atteso che le tipizzazioni disciplinari non sono vincolanti per il Giudice - sulla base del criterio legale, ex art. 2106 c.c., di proporzionalità della sanzione all’infrazione e, qualora non sia per niente stata tipizzata nel codice disciplinare, ricorrerà ad una sua valutazione discrezionale.
Relativamente al principio di proporzionalità della sanzione all’infrazione ex art. 2106 c.c., va, pertanto, eliminata la convinzione/aspettativa – nutrita eminentemente da parte datoriale - che esso sia divenuto inoperante a seguito della riforma in oggetto. Come è stato felicemente detto, il principio in parola permane integro, «perché non costituisce il mero e semplice contenuto di un articolo del codice che, peraltro, non è stato abrogato esplicitamente o implicitamente; ma l’elemento caratterizzante dello stesso esercizio del potere disciplinare, che come tale lo connatura e lo condiziona nel suo stesso esistere»[13].
Non si possono sottacere le evidenti difficoltà per l’interprete derivanti dall’esame dei casi concreti, soprattutto nelle ipotesi, frequenti, nelle quali i contratti collettivi contengono una elencazione espressamente definita “non esaustiva” delle condotte disciplinarmente rilevanti e punite con la sanzione disciplinare conservativa, oppure nelle ipotesi in cui il codice disciplinare contenuto nel contratto appaia totalmente carente. E’ stato, quindi, affermato che: «in queste ipotesi, (…) la semplice omessa menzione, nel codice disciplinare, della condotta contestata al lavoratore licenziato, seppure assimilabile, come gravità, ad un'altra per la quale è applicata la sanzione conservativa, dovrebbe portare il giudicante ad affermare la legittimità del recesso, a causa dell’inesistenza di una previsione che riconduca alla condotta in contestazione una diversa sanzione di tipo conservativo»[14].
La drastica e preoccupante conclusione di cui sopra non è accettabile, perché il Giudice detiene pur sempre – come già detto - il potere-dovere legale di azionare il principio di proporzionalità della sanzione all’infrazione, e se, azionando quel criterio, raggiungerà la convinzione che quel comportamento censurabile era meritevole di una sanzione solamente di tipo conservativo, disporrà legittimamente la reintegra del lavoratore, come per le ipotesi di infrazione tipizzate nel codice disciplinare,
Ragionando diversamente ed accogliendo – per mera ipotesi dialettica - la tesi della sanzione della risoluzione del rapporto con indennizzo, si dovrebbe giungere alla conclusione che l’omissione di una tipizzazione nel codice disciplinare di un comportamento censurabile – cioè una negligenza degli agenti contrattuali nell’elencazione delle infrazioni o dello stesso datore, nel caso di un codice disciplinare unilateralmente approntato – verrebbe fatta ricadere ingiustificatamente a danno del lavoratore. Il che non deve essere.
La disciplina sanzionatoria del licenziamento disciplinare si accompagna ad una nuova regola, concernente la decorrenza degli effetti del licenziamento, introdotta con il comma 41 nel testo del nuovo art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge medesima.
La modifica consiste nel fatto che il licenziamento, intimato in esito al procedimento disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto, «produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato».
La carente menzione della malattia - tra le causali sospensive del licenziamento - è del tutto deliberata e intesa al fine di precludere la prassi di non pochi lavoratori di “cadere” in malattia una volta avuto sentore che il datore sta spiccando un provvedimento disciplinare espulsivo; in tal modo mostrando il neo legislatore di condividere la diffusa opinione dell’irregolarità (se non della falsità delle relative certificazioni) - invero con presunzione non assolutamente fondata - e favorendone l’accreditamento nell’opinione pubblica.
5. Le conseguenze per il licenziamento illegittimo disposto per giustificato motivo oggettivo (cd. economico)
Analoghe perplessità suscita la formulazione legislativa relativa alla cd. tutela spettante nel caso del licenziamento illegittimo basato su un giustificato motivo oggettivo e, quindi, su ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva.
In questa ipotesi, la tutela reintegratoria viene dal legislatore contemplata e affidata alla statuizione del Giudice, qualora il licenziamento - sprovvisto dei suoi presupposti di legittimità - sia dal datore di lavoro stato intimato a fronte di un presunto quanto infondato g.m.o., basato sull’inidoneità fisica o psichica (da intendersi sopravvenuta) del lavoratore, oppure quando il recesso sia stato dettato da un presunto (e parimenti infondato) superamento del periodo di comporto, cioè del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia o infortunio.
Si tratta di fattispecie per le quali sarebbe stato semplicemente “scandaloso” – come è stato scritto da P.G. Alleva – che una volta dichiarati illegittimi questi licenziamenti da parte del Giudice, si potesse escludere per essi la soluzione della reintegra e nei quali, peraltro, il danno risarcibile è limitato tra le 5 e le 12 mensilità.
Ancora, la medesima tutela spetta nelle ipotesi in cui il fatto posto a base del licenziamento si riveli manifestamente insussistente, cioè affetto da manifesta infondatezza. Ricorre la manifesta infondatezza del fatto che costituisce presupposto del licenziamento per g.m.o., nel caso - a titolo esemplificativo - in cui il datore di lavoro giustifichi il licenziamento a causa della chiusura di un reparto dell’azienda che risulti essere, invece, attivo ovvero adduca una riorganizzazione priva di oggettivo riscontro.
In mancanza di un’espressa precisazione – è stato notato - «sembrerebbero sottrarsi alla disciplina del reintegro quelle situazioni, frequenti nella prassi giudiziaria, nelle quali sia stata dimostrata l’esigenza di sopprimere un posto di lavoro, ma non anche l’impossibilità di reimpiegare il dipendente ad esso addetto in altre mansioni; ovvero, nell’individuazione del lavoratore da licenziare, non siano stati osservati i criteri di scelta di cui alla l. n. 223 del 1991, che la giurisprudenza ha ritenuto applicabili anche ai licenziamenti individuali»[15]. L’obbligo - di fonte prevalentemente giurisprudenziale, poi tracimato in taluni disposti normativi - di subordinare il licenziamento per g.m.o. al cd. “repêchage”, sebbene permanga a carico del datore di lavoro, non implicherebbe la conseguenza che la sua violazione sia idonea ad invalidare il licenziamento, che, pertanto, il Giudice potrà confermare, disponendo il solo relativo indennizzo economico per il lavoratore.
Il comma 6 del nuovo art. 18 dello Stat. lav. prosegue conferendo al Giudice il potere e l’obbligo di applicare la disciplina di cui al comma 5 – nelle “altre ipotesi” (diverse da quelle in precedenza esaminate) - in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo. Al riguardo, disponendo che: «In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo».
Relativamente al conferimento al Giudice del potere-dovere di individuare e disporre quella più adeguata tra il novero delle tipologie di sanzioni introdotte ex novo, non si è mancato di far rilevare– ancora da P.G. Alleva nello stesso saggio citato in nota 4 – che «è altrettanto palese la pericolosità di un affidamento al giudice del potere di disporre o meno il reintegro (…) una volta che non sono indicati, neppure in termini generici, i criteri ai quali egli dovrebbe attenersi nell’esercizio di tale facoltà. Se ne può arguire che ha proprio ragione il presidente Monti ad affermare, in una nota intervista rilasciata ad un quotidiano americano l’8 aprile scorso, che il reintegro è riferito “a fattispecie estreme e improbabili”. Anche in questo genere di licenziamenti la conseguenza prevista per i casi ordinari è, invero, di carattere meramente patrimoniale e consiste nel pagamento di un numero di mensilità retributive compreso tra 12 e 24; una conseguenza che consentirebbe ai datori di lavoro di sbarazzarsi di elementi ad essi “sgraditi” affrontando il rischio di un mero esborso inseribile tra i costi d’impresa».
Va ancora precisato che la legge di riforma ha previsto per il licenziamento per g.m.o. (cd. economico o per motivi economici) un nuovo strumento conciliativo di natura obbligatoria, nell’ottica di deflazionare il contenzioso giudiziario.
L’art. 1, comma 40, della legge di riforma introduce, infatti, attraverso la riscrittura dell'art. 7 della l. n. 604/1966, una procedura di conciliazione – sulla quale evitiamo di dilungarci per ragioni di economia del presente scritto, rinviando alla piana lettura del comma 40 citato - davanti alla Commissione provinciale di conciliazione costituita presso la Direzione territoriale del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dal nuovo articolo 18, comma 8, della legge n. 300 del 1970, deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ossia il licenziamento determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”), la quale si configura, quindi, come condizione di procedibilità. È previsto che nel corso della procedura le parti possano farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro.
Conviene solo segnalare - in questa sede - che viene disposto che il progetto (o intendimento) del datore di lavoro di licenziare debba essere preceduto da una comunicazione, effettuata a cura dello stesso, alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e, necessariamente, trasmessa per conoscenza al lavoratore.
Viene fatta (o ripristinata), poi, la scelta di considerare esperita la procedura anche nell'ipotesi in cui la Direzione territoriale del lavoro non abbia proceduto ad inoltrare alle parti la convocazione nel termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal datore di lavoro. Reiterando, pertanto, un infelice precedente – con analoghi risultati insoddisfacenti e meramente formalistici – che si attualizzò in passato tramite l'istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione, vigente sino all'emanazione della l. n. 183/2010, il quale se, da un lato, costituiva condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dall'altro si considerava validamente esperito anche se, trascorsi 60 giorni dalla proposizione della richiesta, la Direzione territoriale del lavoro (allora denominata Direzione provinciale del lavoro) non avesse nel frattempo proceduto alla convocazione delle parti. La carente convocazione nei termini da parte della Direzione provinciale del lavoro era divenuta, all’epoca, la regola – e non si vede come non possa essere ripetuta per l’odierna - con l’effetto singolare, quanto irragionevole, del doversi considerare esperita ugualmente la procedura senza che le parti coinvolte avessero dato corso ad un effettivo incontro conciliativo.
Qualora il tentativo di conciliazione dovesse avere esito positivo e portare alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore fruirà del trattamento economico assicurato dalle disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e, in sede di accordo, le parti potranno prevedere - al fine di favorire la ricollocazione professionale del lavoratore (cd. outplacement) - il suo affidamento ad un’agenzia di lavoro somministrato.
La procedura conciliativa obbligatoria implica e prevede - in un ottica di coercizione indiretta, impositiva o di astreinte – che: a) la sua violazione comporta l'inefficacia del licenziamento, la cui conseguenza è rappresentata dalla tutela risarcitoria ridotta; b) il comportamento tenuto dalle parti nel corso del procedimento venga valutato dal Giudice ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria prevista per l'ipotesi dell'illegittimità del licenziamento intimato per g.m.o., ove non dovesse essere pronunciata la reintegrazione nel posto di lavoro; c) il medesimo comportamento rileva ai fini della determinazione delle spese di giustizia.
6. Le inconsistenti conseguenze del licenziamento inefficace
Per licenziamento inefficace deve intendersi: a) quello «intimato in forma orale» oppure, b) in «violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
Entrambi i casi danno luogo ad un licenziamento “inefficace”, ma con un ben diverso rilievo del termine, perché per quello sub a), il comma 1 del nuovo art. 18 Stat. lav. prescrive – come abbiamo già detto - la stessa sanzione prevista in tema di licenziamento per motivo discriminatorio, cioè la tutela reale assicurata dalla “reintegra”; mentre per quello sub b), il comma 6 prescrive la sanzione introdotta dal precedente comma 5 relativamente alle ipotesi “minori” di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (“disciplinare”), garantite con la sola tutela obbligatoria costituita da una “indennità” ridotta del 50%, cioè compresa solamente tra le 6 e le 12 mensilità.
Al riguardo è stato detto, in dottrina, che: «Qualora non fosse stata esperita la previa procedura prevista dall’art. 7, l. n. 300/1970 per il licenziamento “disciplinare”, elevata dal Giudice delle leggi a garante del principio del contradditorio, ne sarebbe dovuta seguire la reintegra. E’ vero, però, che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in casu, valga la stessa sanzione applicabile per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo subbiettivo, quindi reintegra o indennità, in ragione della dimensione occupazionale dell’unità produttiva o dell’azienda. Solo che, qui, la legge di riforma per un licenziamento disciplinare ingiustificato ha previsto la reintegra o l’indennità fra le 12 e le 24 mensilità a seconda della causale; sicché, sarebbe sembrato coerente che alla prevista “inefficacia” si fosse applicata la sanzione più grave, cioè la reintegra e, comunque, non certo quella meno grave ridimensionata, cioè un’indennità ridotta della metà (fra le 6 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, ndr). A sua volta, qualora, invece, non fosse stata svolta la previa procedura contemplata dal novellato art. 7, l. n. 604/1966 per il licenziamento “economico”, secondo la logica generale condivisa dalla stessa legge, ne sarebbe dovuta derivare una improcedibilità (dell’azione in giudizio, ndr). Niente di tutto questo, ma come si è detto, tale inefficacia comporta la condanna ad “un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”. Tale indennità risulta addirittura dimezzata rispetto a quella prevista per le “altre ipotesi” di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (“disciplinare”) protette con la sola tutela obbligatoria, ai sensi del precedente comma 5; oltreché priva di qualsiasi contestuale elenco di criteri per la sua determinazione, se pur sempre accompagnata dalla necessità di una motivazione, con esclusione quindi di ogni liquidazione equitativa»[16].
Non v’è chi non veda come il legislatore abbia consentito al datore di lavoro di trovare un «modo per liberarsi di un lavoratore pagando solo un modesto dazio: effettuare un licenziamento “inefficace”, non dire e non fare niente in giudizio, corrispondere di buon grado l’indennità ridotta»[17].
Ove il citato dazio o costo è suscettibile di incrementarsi solo in presenza della domanda del lavoratore al Giudice di riscontrare se alle violazioni formali si accompagni un vizio di giustificazione del licenziamento. Ipotesi che il legislatore espressamente contempla all’ultimo periodo del comma 6 del nuovo art. 18 dello Stat. lav. (quale riscritto dall’art. 1, comma 42, della legge in commento) tramite la dizione «a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma (sei, ndr), le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo» (notoriamente più onerose per il datore, rispettivamente costituite dalla reintegra indennizzata con un massimo di 12 mensilità; dalla risoluzione del rapporto indennizzata fra le 12 e le 24 mensilità; ovvero dalla reintegra indennizzata con un massimo di 12 mensilità per il caso in cui il difetto di giustificazione attenga all’addotta incapacità psico-fisica del licenziato o al presunto superamento del comporto di malattia o infortunio, mentre - per il difetto di giustificazione nelle “altre ipotesi” più marginali - ricorre la risoluzione del rapporto indennizzata fra le 12 e le 24 mensilità).
7. Le modifiche di favore alla parte datoriale apportate alla disciplina dei licenziamenti collettivi
Il realizzato progetto di ridimensionare la tutela reale e di allargare quella obbligatoria, dall’area dei licenziamenti individuali si è esteso a quella dei licenziamenti collettivi. Infatti tramite l’art. 1, commi da 44 a 46, la legge di riforma va a modificare talune norme della legge n. 223 del 1991.
Stabilisce, in primo luogo, che gli eventuali vizi delle comunicazioni e informazioni inerenti l’avvio delle procedure di mobilità – che, in base all’art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 223 del 1991, vanno rivolte alle strutture sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria - possano essere sanate da un successivo accordo sindacale, più propriamente «nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura sindacale di licenziamento collettivo».
Relativamente alla sanatoria - contemplata tuttavia per via consensuale con organismi sindacali, che all’accordo non possono essere forzatamente costretti - è stato osservato condivisibilmente che essa «rischia di realizzare un drastico affievolimento dei diritti dei singoli lavoratori (eminentemente dei non iscritti ai sindacati, ndr) che attraverso quelle comunicazioni possono oggi esercitare un potere di controllo circa la regolarità delle procedure, denunziarne eventualmente l’illegittimità e, se posti in mobilità, agire in giudizio al fine di essere reintegrati nei loro posti di lavoro. In secondo luogo, ed a prescindere da ogni accordo con i sindacati, l’istituto della reintegra resta fermo solo nel caso, davvero improbabile, in cui il licenziamento collettivo sia privo della forma scritta, ed in quello in cui siano stati violati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, con esclusione, pertanto, di ogni altra inosservanza dell’articolata procedura prescritta dalla legge sopra indicata»[18].
A favore del datore, poi, l’art. 1, comma 44, della legge di riforma elimina la contestualità tra la comunicazione del licenziamento e la comunicazione ai vari soggetti (indicati nel comma 9 dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991) di una serie di dati informativi concernenti i licenziati - fra i quali spicca la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta -, concedendo al datore di lavoro un termine di 7 giorni per fare la seconda comunicazione. In tal modo viene lasciata al datore, dopo la comunicazione dei licenziamenti, la tutt’altro che teorica possibilità – in precedenza preclusa – di un adattamento dei criteri a copertura o correzione di soluzioni già prese.
Sempre con orientamento a favore degli interessi dell’impresa, il comma 10 del nuovo art. 18 introduce, per la prima volta nell’ordinamento positivo, una specifica disciplina della revoca del licenziamento. Al riguardo si dispone che la revoca – la quale notoriamente viene attivata dal datore quando nutre il (quasi certo) sospetto di aver disposto un licenziamento suscettibile di essere invalidato per vizi interni o errori compiuti – va effettuata entro i 15 giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta impugnazione giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore.
In merito è stato detto che: «Si consente, pertanto, tramite l’introdotta disciplina della revoca del licenziamento, al datore di lavoro, il quale - tutte le volte in cui abbia intimato un licenziamento del tutto illegittimo e arbitrario - ove abbia fondate ragioni per pensare che il lavoratore non sia disposto alla reintegrazione, di raggiungere il proprio obiettivo anche a buon mercato»[19], atteso che la retribuzione che dovrà pagare al lavoratore per averlo estromesso, quale sanzione indiretta, non eccederà l’importo relativo a 75 giorni (tenuto conto del termine massimo dei 60 giorni, per l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, cui si vanno ad aggiungere 15 giorni, al massimo, per disporre la revoca da parte del datore).
La revoca è legislativamente configurata quale iniziativa datoriale di “ravvedimento” (o “ripensamento”), alla quale il lavoratore deve sottostare e che è costretto a subire. Chiaramente – in ragione del brocardo “nemo ad facere cogi potest ”- egli è libero di non accettare la revoca[20], ma, essendo stato ora previsto dal comma 10 del nuovo art. 18 dello Stat. lav. che, per effetto della revoca datoriale, «il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo», il neo legislatore ha risolto, in negativo per il lavoratore, la problematica della eventuale spettanza dell’indennità sostitutiva della reintegrazione (ipotizzabile quale “sanzione” alternativa) che lo stesso avrebbe potuto richiedere in sostituzione della sanzione della reintegra a carico del datore, al riscontro da parte del Giudice dell’illegittimità del licenziamento.
Problematica, che nel precedente assetto di carenza di disciplina, era stata affrontata e risolta, invece, in positivo per il lavoratore, al quale la giurisprudenza ne aveva riconosciuto la spettanza (anche in assenza di sentenza costitutiva e dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento), sulla base delle seguenti motivazioni:«L’indennità prevista nell’art. 18, quinto comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall’art. 1, l. 11 maggio 1990, n. 108, è configurata come prestazione che si inserisce, in connessione con il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, in un rapporto obbligatorio avente la struttura di un’obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore. Ne deriva che la facoltà del prestatore non può essere arbitrariamente vanificata dal datore di lavoro revocando il licenziamento in corso di giudizio allo scopo di impedire la pronuncia giudiziale di condanna alla reintegra; onde l’invito a riprendere il lavoro, non seguito da una ricostituzione di fatto del rapporto (per effetto del rifiuto del lavoratore, ndr), non è sufficiente a far venir meno l’attualità dell’obbligo di reintegrazione e a sottrarre il diritto di opzione, il cui esercizio verrebbe altrimenti rimesso di fatto al datore di lavoro» (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 12 giugno 2000, n. 8015).
L’introdotta regolamentazione sottrae la revoca alla situazione di fatto in cui versava in precedenza e, tramite il riconoscimento del (solo) diritto del lavoratore «alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca», con espressa esclusione, per la fattispecie del licenziamento revocato, dell’applicabilità dei «regimi sanzionatori previsti dal presente articolo» - tra i quali può essere ricondotta, anche, l’indennità sostitutiva della reintegrazione (c.d. 15 mensilità, nelle aziende con più di 15 dipendenti) – al lavoratore indisponibile ad aderire alla revoca non resta altro che rassegnare le proprie dimissioni.
La legittimazione giurisprudenziale al rifiuto della “revoca” da parte dell’estromesso a seguito di licenziamento, risiede – come correttamente la precedente giurisprudenza ha evidenziato - nel riconoscimento della natura “bidirezionale” del rapporto fiduciario, cosicché come al datore é consentito di liberarsi, licenziandolo per giusta causa, del dipendente sul quale non nutre, dietro fondati riscontri, più alcuna fiducia, così al lavoratore licenziato é stato riconosciuto il pieno diritto di rifiutare sia l’invito datoriale al ripristino del rapporto a seguito di sentenza sia la revoca del licenziamento nel corso del giudizio, in considerazione della crisi di fiducia subita, di una perdita di stima nel datore di lavoro, di una prospettiva di riammissione in un ambiente ostile ed in una realtà aziendale immutata, del timore di ritorsioni successive, ecc.
Nel vecchio assetto, il rifiuto del lavoratore alla richiesta/invito datoriale di reinserimento in azienda era – dall’orientamento giurisprudenziale di favor per il lavoratore - indennizzato con l’indennità sostitutiva della reintegra, d’ora in poi non più!
Il carattere imperativo della disciplina regolante la revoca – provvedimento unilaterale cui il lavoratore viene assoggettato per effetto di una “comoda” e non onerosa iniziativa datoriale - sembra precludere anche un eventuale richiesta di risarcimento di danno.
E’ stato altresì disposto, tramite l’art. 1, comma 38, della legge di riforma in commento, che il termine di 270 gg. – introdotto a pena di decadenza dall’art. 32 della l. n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) per il deposito del ricorso giudiziale dopo l’impugnativa del licenziamento (e rivendicazioni assimilate) effettuata entro i 60 gg. dall’irrogazione – sia abbassato a 180 gg., precisando al comma 39 del non doversi applicare, il nuovo termine ridotto, retroattivamente ma solo «in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge». Disposizione che è stata letta[21] costituire la prosecuzione di una politica di favor in materia verso le imprese, anticipata con il precedente governo che aveva – tramite la l. n. 183/2010 citata – introdotto l’obbligo di deposito del ricorso del lavoratore entro gli oramai superati 270 giorni.
(Altalex, 11 luglio 2012. Articolo di Mario Meucci)
_______________
[1] Così C. Cester, Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: prime riflessioni, p.2.
[2] Così F. Liso, Le norme in materia di flessibilità in uscita nel disegno di legge Fornero, p. 2.
[3] Ancora F. Liso, in op. cit., p. 2.
[4] Così P.G. Alleva, La riforma del mercato del lavoro: un “piano” (inclinato) per la riduzione delle tutele dei lavoratori, in dirittisocialiecittadinanza, p. 2.
[5] In senso conforme, M. Marazza, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavoratori, p. 2 e ss.
[6] Cfr., tra le tante, Cass, sez. VI civ., 26 ottobre 2010, n. 21919 per cui: «Ai fini della sottrazione dell'"aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto», nonché Cass, sez. lav., 17 novembre 2010, n. 23226, secondo cui: «(…) grava esclusivamente sul datore di lavoro l’onere di provare, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, l’aliunde perceptum o l’aliunde percipiendum, allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno (vedi Cass. 19 gennaio 2006, n. 945; 5 aprile 2004, n. 6668; 8 giugno 1999, n. 5662)».
[7] Così anche G. Zilio Grandi, La riforma dei licenziamenti: opportunità perse e risultati ottenibili… la parola al Giudice, in Lavoro: una riforma a metà del guado, a cura di P. Rausei e M. Tiraboschi, p. 167.
[8] Così C. Cester, in op. cit., p. 21.
[9] Così F. Liso, in op. cit., p. 3.
[10] Così P.G. Alleva, in op. cit., p. 20.
[11] Così C. Cester, in op. cit., p. 24.
[12] Conforme C. Cester, op. cit., p. 23; contra: G. Zilio Grandi, in op. cit.,168; M. Papaleoni, Prime considerazioni critiche sul progetto di riforma del mercato del lavoro: "Mons tremuit, et mus parietur", p. 6, che riscontra, all’opposto, una presunta «generalizzazione ideale della tutela reintegratoria, relegando quella economica in un ruolo invero ipotetico e residuale».
[13] Così F. Carinci, Complimenti, dottor Frankenstein: Il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, p. 21.
[14] Così, F. Alvaro, Riforma del lavoro Fornero: prime considerazioni.
[15] Così P.G. Alleva, in op. cit., p. 5.
[16] Così F. Carinci, in op.cit., p. 20.
[17] Così F. Carinci, in op. cit., p. 20.
[18] Così P.G. Alleva, in op.cit., p. 7.
[19] Così C. Cester, in op. cit., p. 36.
[20] Nel senso che la revoca del licenziamento deve essere accettata dal lavoratore per esentare il datore di lavoro dal pagamento del risarcimento e dell’indennizzo sostitutivo della reintegrazione, v. anche Cass. 4 ottobre 1995, n. 10408, in RIDL, 1996, II, p. 636, con nota di V. Marino, Revoca del licenziamento e art. 18 Stat. lav.; Cass. 18 novembre 1997, n. 11467, ivi 1998, II, p. 346, con nota di A. Avio, Appunti sulla revoca del licenziamento; Cass. 12 giugno 2000, n. 8015, ivi 2001, II, 358, con nota di F. Notaro, Revoca del licenziamento e opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva della reintegrazione; nonché più recentemente Cass. 13 giugno 2002, n. 8493, in NGL 2003, p. 85.
[21] Così G. Zilio Grandi, in op.cit., p. 169.
estratto da http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=18878
1. Premessa
2. La reintegrazione quale sanzione del licenziamento illegittimo: ieri e oggi
3. Le conseguenze per il licenziamento discriminatorio
4. Le conseguenze per il licenziamento illegittimo disciplinare (disposto per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa)
5. Le conseguenze per il licenziamento illegittimo disposto per giustificato motivo oggettivo (cd. economico)
6. Le inconsistenti conseguenze del licenziamento inefficace
7. Le modifiche di favore alla parte datoriale apportate alla disciplina dei licenziamenti collettivi
1. Premessa
 L’etichettatura di “legge malfatta” che una parte della dottrina giuslavoristica degli anni ‘70 assegnò allo Statuto dei lavoratori (che non la meritava) va, invece, - indiscutibilmente e più pertinentemente - utilizzata per la cd. “riforma del mercato del lavoro” pubblicata sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 - S.O. n.136, come Legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, con entrata in vigore al 18 luglio 2012.
L’etichettatura di “legge malfatta” che una parte della dottrina giuslavoristica degli anni ‘70 assegnò allo Statuto dei lavoratori (che non la meritava) va, invece, - indiscutibilmente e più pertinentemente - utilizzata per la cd. “riforma del mercato del lavoro” pubblicata sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 - S.O. n.136, come Legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, con entrata in vigore al 18 luglio 2012.Ciò per effetto del riscontro dei numerosi difetti tecnici che la caratterizzano e che ne rendono ostica la comprensione anche agli stessi addetti ai lavori.
Conviene subito evidenziare che tali difetti non sono stati rilevati solo da noi – che taluno potrebbe ascrivere alla nostra non condivisione delle linee guida del provvedimento che hanno ispirato il neo legislatore – in quanto nel rilievo siamo in (buona) compagnia di numerosi giuristi oltreché con gli estensori del Parere della Commissione per la legislazione – trasmesso alla Camera dal Presidente del Senato il 1 giugno 2012 - relativo al disegno di legge, destinato a divenire la nuova legge n. 92/2012.
Al riguardo il Parere segnala, tra gli altri, che «taluni difetti di coordinamento con la normativa vigente si riscontrano, più in generale, tra le disposizioni introdotte dal disegno di legge in oggetto e la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 300 del 1970, da un lato, e il decreto legislativo n. 276 del 2003, dall’altro, nonché con le disposizioni contenute nel codice di procedura civile agli articoli 409 e seguenti, nella parte in cui si disciplina il rito del lavoro»; che «in termini ancor più generali, inoltre, il provvedimento, talvolta, innova l’ordinamento previgente senza tuttavia coordinarsi con esso in modo compiuto ma ad esso sovrapponendosi». Ed ancora, «il disegno di legge si rapporta inoltre alla normativa vigente procedendo perlopiù mediante richiami effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio», e, «infine, il disegno di legge si caratterizza per l’introduzione, in relazione alla disciplina di numerosi istituti, di discipline a regime, cui si affiancano disposizioni aventi carattere transitorio; peraltro, le suddette discipline non sempre risultano coordinate e appaiono, talvolta, dislocate nell’ambito di partizioni del testo anche parecchio distanziate tra loro, rendendo così ardua per l’interprete la ricostruzione della disciplina in concreto applicabile». Tanto per esemplificare!
Anche la maggioranza dei giuslavoristi riuniti nell’A.I.D.La.SS. (Associazione Italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) – che ha tenuto il XVII Congresso nazionale a Pisa in data 7-9 giugno 2012 - ha espresso una valutazione decisamente critica sul disegno di legge ora trasformato in legge, incentrata essenzialmente – come è stato detto - sulla non condivisione a tacer d’altro: a) dell’introdotta articolazione in più livelli dell’apparato sanzionatorio del licenziamento illegittimo, finalizzato a ridurre la tutela reale (reintegra) a favore della tutela indennitaria (monetizzazione); b) delle complesse alchimie che scompongono e ricompongono i presupposti che legittimano i licenziamenti; c) della predisposizione di un procedimento giurisdizionale ad hoc per il contenzioso sui licenziamenti.
I relatori e gli interventori hanno espresso – in maggioranza - l’intendimento, di non assecondare supinamente l’obbiettivo del neo legislatore di diminuire le tutele del licenziamento, sulla base della scelta di porre al centro del sistema non più la “tutela reintegratoria piena”, bensì le “tutele minori” introdotte dal testo di riforma (”tutela reintegratoria attenuata” e “tutela indennitaria forte”, di cui diremo in prosieguo) e di accingersi, quali giuslavoristi, a orientare l’interpretazione della nuova legge secondo un’ottica mirata a ridurre al minimo gli effetti della scelta perseguita dal nuovo legislatore, in coerenza con le manifestate valutazioni critiche del disegno di legge ora sfociato nel provvedimento legislativo. Il che appare decisamente significativo!
Per completezza informativa va segnalato che questo dichiarato intendimento si è attirato l’addebito di far apparire all’opinione pubblica la comunità dei giuslavoristi, più come un “partito” che come una “comunità scientifica”; addebito, peraltro, respinto adducendo e rivendicando il legittimo diritto di critica delle non condivise soluzioni governative, al fine di orientare quelle future in una direzione più equilibrata e meno sbilanciata a danno della parte debole del rapporto di lavoro; anche per garantire ai lavoratori colpiti da illegittimi licenziamenti l’integrale risarcimento del danno subito con la privazione del posto di lavoro, per niente assicurato dai “tetti” apposti agli indennizzi monetari articolatamente introdotti e con i quali la cd. riforma ha traguardato l’obbiettivo del ridimensionamento della tutela reale a vantaggio di quella obbligatoria monetizzante. Ridimensionamento motivato, dai sostenitori della legge in commento, con l’esigenza di un allineamento del nostro Paese agli assetti standard dei paesi comunitari, che si asserisce essere caratterizzati da una prevalenza della tutela obbligatoria (che consente la monetizzazione del danno da licenziamento) su quella reale ripristinatoria del rapporto, mediante reintegra nel posto precedentemente occupato.
La riforma ha scontentato tutti, osservandosi, dai sostenitori degli interessi della parte datoriale - che nutriva l’aspettativa di una ben più incisiva rivisitazione dell’art. 18 Stat. lav. - che la situazione è stata invece, se possibile, peggiorata per quanto riguarda la “flessibilità in uscita”. Infatti, in luogo di una disciplina che – a loro avviso - pur con i suoi innegabili difetti, poteva tutto sommato dirsi “certa”, la riforma – sempre a loro avviso - impone una rivisitazione che fa della discrezionalità (e dunque opinabilità) del Giudice l’unico punto fermo, ampliando conseguentemente l’imponderabilità, per i datori, dei rischi connessi ad un licenziamento ingiustificato.
Quanto alle linee guida della nuova legge, innanzi appena menzionate, va detto che esse risiedono nella volontà del neo legislatore di effettuare una profonda revisione delle conseguenze sanzionatorie del licenziamento illegittimo – finora ragionevolmente delineate dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ed ora innovate attraverso una riscrittura dell’art. 18 medesimo – tramite l’introduzione di una contorta articolazione delle cd. “sanzioni – conseguenza” dell’accertato licenziamento illegittimo.
Sanzioni che spaziano da una “reintegrazione”, circoscritta eminentemente al licenziamento discriminatorio e ritorsivo, fino a prevalenti “monetizzazioni” del licenziamento illegittimo riconducibile al giustificato motivo oggettivo di natura economica (riposante su “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”), attraverso le quali il legislatore indennizza - con legittimazione giudiziale alla risoluzione del rapporto quale proprio obbiettivo raggiunto - anche la fattispecie del licenziamento illegittimo (cd. “speculativo”) adottato dall’impresa che abbia riscontrato in bilancio un calo di profitti o intenda incrementarne gli attuali, oltreché razionalizzare e riorganizzare il proprio assetto tecnologico, produttivo e distributivo.
2. La reintegrazione quale sanzione del licenziamento illegittimo: ieri e oggi
Sul diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, la riforma ha inteso intervenire partendo dal falso presupposto che un’eccessiva rigidità in uscita risulta di ostacolo all’incremento occupazionale, in quanto il superamento delle soglie numeriche previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (più di 15 dipendenti in ambito comunale o di sede, filiale, stabilimento o unità produttiva, oppure 60 dipendenti a livello nazionale) - comportando l’applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro in presenza di un licenziamento illegittimo - scoraggerebbe altresì gli investimenti stranieri nel Paese, giacché preclusiva dei “desiderata” datoriali di risolvere discrezionalmente i rapporti di lavoro.
Per effetto dell’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, fino a prima dell’entrata in vigore dell’innovata disciplina, un licenziamento illegittimo, nullo o inefficace – sia disposto per giusta causa sia per giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all’organizzazione dell’impresa), sia per giustificato motivo soggettivo (per notevole inadempimento agli obblighi contrattuali) - era tutelato con la reintegrazione nel posto di lavoro, la quale assicurava congiuntamente il diritto del dipendente: a) al ripristino del rapporto di lavoro, con effetti dal giorno della sua interruzione; b) a percepire le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, detratto il cd. aliunde perceptum, cioè l’eventuale reddito realizzato per lo svolgimento, medio tempore, di un’altra attività lavorativa, subordinata o autonoma; c) all’accreditamento contributivo, mediante il versamento - ad integrale carico del datore - della dovuta contribuzione previdenziale sia per la quota datoriale che per quella del lavoratore (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 4 aprile 2008, n. 8800).
Inoltre la sanzione della reintegrazione era operativa al riscontro di un licenziamento illegittimo per qualsiasi violazione formale nella quale fosse incorso il datore di lavoro nella formulazione o formalizzazione del licenziamento, contravvenendo cioè sia alle prescrizioni dell’art. 2, l. n. 604/1966 (obbligo di comunicazione scritta del provvedimento e delle ragioni poste a fondamento del recesso per giustificato motivo), sia alla procedura individuata dall’art. 7 Stat. lav., afferente al procedimento disciplinare.
Per effetto, poi, della disposizione dell’art. 3, l. n. 108/1990, l’obbligo della reintegrazione trovava sempre applicazione - indipendentemente dall’assetto dimensionale del datore di lavoro (sia al disotto sia al disopra dei 15 dipendenti) - qualora il licenziamento fosse stato disposto per motivi discriminatori o ritorsivi (es., per aver il lavoratore effettuato un ricorso alla magistratura per la rivendicazione di propri diritti violati o crediti retributivi maturati).
Con la nuova disciplina, appare in tutta evidenza che il neo legislatore ha focalizzato la propria attenzione sull’art. 18 dello Stat. lav., in un’ottica di depotenziamento della tutela reale-reintegratoria, misura a suo tempo approntata dal legislatore statutario in quanto la sola riconosciuta idonea a rendere effettiva la riaffermazione dei diritti violati. Al realizzato depotenziamento si è accompagnato, contestualmente, un deliberato e perseguito arretramento sul versante del rispetto della dignità e della libertà dei lavoratori, atteso che la sanzione della reintegra costituiva un baluardo difensivo dei suddetti valori, nonché, al tempo stesso, un deterrente alla loro negazione nella concreta vita aziendale, da parte datoriale. L’art.18, infatti – come è stato rilevato - innescava un circolo virtuoso, perché mentre tutelava l’estinzione del rapporto, rendeva più democratica la gestione del medesimo nel corso del suo svolgimento; «consentendo al lavoratore di dire qualche no e garantendo nei fatti il godimento dei diritti civili e sindacali in azienda» - come è stato incisivamente osservato dal giudice del lavoro R. Riverso – secondo cui «la norma aveva favorito la democratizzazione di tutta la società italiana, sottraendo milioni di persone al ricatto della perdita del posto e consentendo l'effettiva esplicazione dei diritti del lavoro. Il principio della stabilità reale era, infatti, un imprescindibile presidio di contrasto agli abusi dell’imprenditore e la sola condizione che rendeva possibile l’esercizio dei diritti sindacali e delle azioni giudiziarie da parte dei lavoratori nel corso del rapporto di lavoro».
Acuti commentatori della cd. “riforma del mercato del lavoro” (in senso regressivo, secondo noi), non hanno mancato di sottolineare come «fin dai primi annunci in ordine al progetto di intervento sulla flessibilità in uscita è apparso chiaro che l’obiettivo di riforma si sarebbe focalizzato essenzialmente sull’art. 18 dello Statuto, a torto o a ragione considerato il nodo cruciale in materia; e non a caso ne è stata modificata la rubrica, non più limitata alla “Reintegrazione nel posto di lavoro”, ma, in prospettiva ben più ampia, coinvolgente la “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”, dove peraltro la maggiore ampiezza si riferisce agli ambiti e non certo allo spessore della tutela» [1].
Altri fini giuslavoristi hanno rilevato che se l’intento della riforma era la prevedibilità e la riduzione dei costi per il datore di lavoro, connessi e conseguenti alle lungaggini giudiziarie per giungere a sentenza – obbiettivo che il neo legislatore ha ipotizzato essere conseguibile tramite l’introduzione di un rito processuale speciale ed accelerato per il contenzioso sui licenziamenti - «in verità, con la sua impostazione, (…) ci fa capire che in gioco non c’è solo un problema di costi, ma anche un problema di potere. Infatti, la sanzione meramente risarcitoria, alla quale si lascerebbero ampi spazi a detrimento di quella ripristinatoria, consentirebbe di rimettere nelle mani del datore di lavoro la facoltà di produrre comunque l’effetto estintivo del rapporto di lavoro»[2]. Ed ancora si era auspicato, nel commentare il disegno di legge, poi convertito nell’odierna legge, che: «vi dovrebbe essere consapevolezza che l’attuale turbolento contesto richiede da parte del legislatore la promozione di una cultura concertativa tra le parti sociali, a tutti i livelli. Il disegno del governo non valorizza questa cultura, valorizza la decisione solitaria del datore di lavoro»[3].
Ancor più incisivamente, da altri è stato affermato che «la riforma del mercato del lavoro (…) in aperto e preoccupante contrasto con le ingannevoli affermazioni dei suoi promotori, esprime una concezione essenzialmente filo imprenditoriale delle relazioni industriali, una conseguente marginalizzazione della dignità del lavoro, una larga accettazione della frammentazione delle tipologie contrattuali a carattere prevalentemente precario, uno svuotamento delle garanzie per i casi di licenziamento ed una visione del welfare insensibile e comunque del tutto inadeguata alle esigenze essenziali dei cittadini»[4].
A questo preciso scopo la cd. riforma del mercato del lavoro frantuma l’assetto del vecchio articolo 18 Stat. lav., introducendo una complessa ed articolata pluralità di diversificate sanzioni al riscontro del licenziamento illegittimo, tese a circoscrivere la reintegrazione alla (pressoché sola) fattispecie del licenziamento discriminatorio o ritorsivo e a sostituirvi, per le altre fattispecie di licenziamento illegittimo, la risoluzione del rapporto di lavoro accompagnata da una monetizzazione risarcitoria di più o meno varia e inadeguata entità (di cui diremo in prosieguo).
Per la precisione, la vecchia tutela reintegratoria di cui all’art. 18 Stat. lav., è stata scomposta in 4 livelli o misure sanzionatorie del licenziamento illegittimo correlate, in diretta dipendenza, alle ragioni o causali del licenziamento illegittimo. Misure riassumibili[5] nella “reintegrazione ad effetti risarcitori pieni” (art. 18, commi 1°, 2° e 3°); nella “reintegrazione ad effetti risarcitori limitati” a 12 mensilità per il “periodo intermedio” (art. 18, comma 4°); nella “tutela obbligatoria forte” caratterizzata da un risarcimento meramente indennitario, sostitutivo del posto di lavoro, compreso tra 12 e 24 mensilità (art. 18, comma 5°); nella “tutela obbligatoria debole”, esclusivamente indennitaria, con risarcimento compreso tra 6 e 12 mensilità, sostitutivo della perdita del posto di lavoro (art. 18, comma 6°).
3. Le conseguenze per il licenziamento discriminatorio
In termini generali va sottolineato che il criterio della reintegrazione nel posto di lavoro - che rappresentò la vera novità dell’art.18 e che costituiva la regola in tutte le ipotesi in cui il licenziamento veniva riscontrato nullo, inefficace o comunque invalido - viene dalla cd. “riforma del mercato del lavoro” ad essere degradato a mera eccezione, tranne che nei licenziamenti discriminatori, in cui resta sostanzialmente fermo l’impianto normativo preesistente.
Per l’individuazione del licenziamento discriminatorio, il nuovo legislatore rinvia per relationem alle specificazioni di cui all’art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (la quale rinvia alle previsioni dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300), ove in quest’ultime è dato registrare il divieto di discriminazione in relazione al solo «credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato e alla partecipazione ad attività sindacali»; si registra, quindi, una pretermissione da parte del neo legislatore delle più esaustive ipotesi codificate nell’art. 2 del d.lgs. n. 216/2003, secondo cui la nozione di discriminazione si estende alla diversificazione di trattamento «a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale», consentendo così al lettore di fare un assaggio di quelle omissioni, imprecisioni e deficienze che sono abbastanza usuali nel testo della nuova legge. Alle menzionate ipotesi discriminatorie, il neo legislatore addiziona, poi, correttamente, il licenziamento intimato in concomitanza col matrimonio (ai sensi dell’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del T. U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni).
Alle surriferite fattispecie di licenziamento discriminatorio, il comma 1 del nuovo art. 18 accorda e assicura la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato, reintegrazione che - sempre il comma 1 in questione - conferisce altresì al licenziamento parimenti illegittimo perché riconducibile ad «altri casi di nullità previsti dalla legge o perché determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile», entrambi caratterizzati da assoluta difficoltà di individuazione da parte dell’interprete giudiziario. Alla reintegrazione il legislatore accompagna - tramite il comma 2 e dietro ordine giudiziale - la corresponsione risarcitoria a carico del datore di lavoro di una indennità compresa tra le 5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (cd. aliunde perceptum), nonché l’onere datoriale della relativa contribuzione previdenziale.
Stavolta meritoriamente, il neo legislatore precisa, poi, nell’ultimo disposto del comma 1, che la sanzione della reintegrazione - accompagnata dall’indennità risarcitoria compresa tra le 5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto e dedotto l’aliunde perceptum - si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, così risolvendo un contrastante contenzioso e precludendone la reiterazione in futuro.
Viene poi confermato che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, dell’art. 1 - al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (reiterando, così, la previgente disciplina al riguardo) la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale (recependo così il consolidato orientamento giurisprudenziale: cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 7 marzo 2003, n. 3487). La richiesta dell’indennità sostitutiva della reintegrazione deve essere effettuata dal lavoratore entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. Le conseguenze per il licenziamento illegittimo disciplinare (disposto per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa)
Nelle ipotesi di licenziamento intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo - la cui qualificazione ontologicamente disciplinare, sebbene inespressa nei commi 4 e 5 dell’art. 1 del nuovo articolo 18, può essere tranquillamente desunta dal successivo comma 7, ove si fa riferimento all’eventuale ricorrere di «ragioni discriminatorie o disciplinari» – viene prevista un’alternativa sanzionatoria che spazia fra “tutela reale” e “tutela obbligatoria”, senza che per orientare l’interprete sia stata approntata un’opportuna quanto necessaria elencazione delle ipotesi o fattispecie idonee a consentire la chiara ed inequivoca individuazione del ricorso all’una o all’altra “sanzione” (che il neo legislatore qualifica impudentemente “tutela”) in quanto, nel concreto, una tale individuazione è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice.Dispone, il comma 4 dell’art. 1, che: «Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (cioè dedotto, in tal caso, sia l’aliunde perceptum che l’aliunde percipiendum, ndr). In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione (…). A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma (c.d. 15 mensilità, ndr)».
Relativamente alla deduzione dell’aliunde perceptum, resta naturalmente fermo l’orientamento giurisprudenziale[6] che sostiene che spetta al datore di lavoro dimostrare sia l’esistenza una nuova occupazione del lavoratore che il reddito conseguente[7].
Niente si precisa da parte del legislatore – in ordine al procedimento di sottrazione dell’aliund percipiendum dall’indennità risarcitoria – ai fini di chiarire se l’obbligo della diligente ricerca occupazionale gravi sul lavoratore solo in relazione ad occupazioni in mansioni equivalenti alle precedenti – come finora giurisprudenzialmente riconosciuto – ovvero in relazione a qualsiasi altra occupazione anche dequalificata, giustificatamente rifiutabile.
Segue il comma 5, recitando che: «Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento (della sola, ndr) indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo».
Il punto centrale del combinato disposto del comma 4 e del comma 5, risiede tutto nell’individuazione di quale sia la fattispecie di licenziamento ingiustificato che, per gravità e spessore, porta all’applicazione di una tutela ancora reale e quali le “altre ipotesi” cui, ai sensi del comma 5, è ora riservata la sola tutela indennitaria.
La reintegrazione è ancora assicurata, anzitutto, allorché il licenziamento sia ingiustificato «per insussistenza del fatto contestato».
A parte la difficoltà di individuare quando ricorre la fattispecie del “fatto contestato” giacché – come è stato notato – i fatti hanno molte sfaccettature e, in concreto, ci si può imbattere in una contestazione disciplinare di più fatti (con la difficoltà di sapere se sia sufficiente a caducare l’addebito plurimo, la sola insussistenza di uno, quello prevalente, rispetto alla sussistenza degli eventuali altri), riteniamo condivisibile l’ opinione dottrinale, secondo cui: «il comma 4 e la reintegrazione si applicano quando la procedura disciplinare risulti imbastita sul nulla, o su grossi equivoci, più o meno imputabili al datore di lavoro ma in ogni caso non troppo difficilmente accertabili; detta sotto il profilo qualitativo, in situazioni nelle quali il licenziamento disciplinare illegittimo abbia finito col ledere l’onorabilità della persona del lavoratore, in linea con la convinzione che la reintegrazione debba essere riservata, come nel primo comma, a garanzia dei diritti assoluti del lavoratore (…)»[8].
La seconda ipotesi codificata nel disposto «perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili» individua, senza difficoltà, il caso - piuttosto infrequente - in cui il datore di lavoro abbia commesso lo sbaglio di applicare la sanzione espulsiva laddove le diverse fonti contrattuali o disciplinari del regolamento aziendale prevedano una sanzione solo conservativa.
Ma il testo della legge, al comma 5 del nuovo art. 18, afferma che vi sono anche “altre ipotesi” in cui il Giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, ipotesi nelle quali l’illegittimità del licenziamento dovrebbe essere da lui sanzionata con il risarcimento. Al riguardo, in dottrina, è stata tratta la seguente condivisibile considerazione: «Questo allora vuol dire che l’estensore del testo ha voluto usare una formula ellittica per esprimere l’intenzione di evitare la reintegrazione ogniqualvolta il giudice si trovi a giudicare di comportamenti astrattamente rientranti in casi previsti dai contratti collettivi come legittimanti il licenziamento, ma da lui valutati come inidonei a rivestire il grado di gravità richiesto dalla fattispecie legale (si pensi ad esempio al furto, previsto da contratti collettivi come legittimante il licenziamento, ma talvolta dalla giurisprudenza valutato non sufficiente a giustificare il licenziamento quando riguardi beni di modico valore)»[9]. Pertanto in tutte queste “altre ipotesi” per le quali il Giudice ritenga sproporzionata ex art. 2106 c.c. la sanzione espulsiva e sarebbe stato indotto, nel vecchio assetto, a disporre la reintegrazione con conversione della sanzione espulsiva in altra di natura conservativa, ora – con tutta probabilità, stante allo stato le controverse opinioni dottrinali al riguardo - dovrebbe disporre la risoluzione del rapporto accompagnata da un indennizzo risarcitorio, peraltro limitato ad un importo compreso tra 12 e 24 mensilità della retribuzione, quale che sia stato l’arco di tempo intercorso tra il recesso e la sentenza che ne dichiari l’illegittimità, «implicitamente affermandosi così il principio, contrario ad una radicata tradizione civilistica, secondo cui la durata del processo giuocherebbe in danno del lavoratore anche quando la domanda da lui proposta abbia trovato pieno accoglimento»[10].
Conclusivamente può affermarsi – come è stato osservato - che: «si applicherà il comma 4 nelle ipotesi non frequenti nelle quali venga disattesa la tipizzazione (disciplinare, ndr) mentre si applicherà il comma 5 nelle “altre ipotesi”, cioè, con frequenza ben maggiore, tutte le volte in cui la tipizzazione (disciplinare, ndr) sia stata rispettata, ma il licenziamento sia giudicato illegittimo per altre ragioni, legate alle contingenze concrete, come lo stato psicologico del lavoratore e il suo grado di colpevolezza, la posizione ricoperta in azienda, il livello di professionalità, la rilevanza delle conseguenze dannose del comportamento ecc. L’ambito di applicazione della reintegrazione risulterà perciò alquanto ristretto (…)»[11]. Emerge, quindi, confermativamente, la netta prevalenza accordata dal neo legislatore – nonostante la “mediazione” correttiva a livello politico, più che sindacale – alla tutela indennitaria rispetto a quella reintegratoria[12].
Venendo all’individuazione dell’astratta fattispecie suscettibile di strutturare le c.d. “altre ipotesi” menzionate nel primo alinea del comma 5 del “nuovo” art. 18 - e rispetto alla quale il Giudice disporrà, in caso di illegittimo recesso, l’applicazione della sola tutela risarcitoria - sembra possa affermarsi che è quella per la quale risultino accertati, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) che la condotta censurabile contestata al lavoratore risulti essere stata effettivamente tenuta; b) che la condotta non rientra in una delle fattispecie rispetto alle quali il contratto collettivo o il codice disciplinare applicabile prevede una sanzione conservativa, ma una sanzione espulsiva ovvero che non è stata affatto tipizzata nel codice disciplinare; c) che il Giudice ritiene che quella condotta censurabile non sia idonea ad incidere sull’affidamento fiduciario riposto nel lavoratore e, quindi, non ritiene che possa costituire il presupposto per la risoluzione del rapporto di lavoro; conseguentemente, qualora la condotta sia tipizzata con sanzione espulsiva ne effettua la cd. “derubricazione” – atteso che le tipizzazioni disciplinari non sono vincolanti per il Giudice - sulla base del criterio legale, ex art. 2106 c.c., di proporzionalità della sanzione all’infrazione e, qualora non sia per niente stata tipizzata nel codice disciplinare, ricorrerà ad una sua valutazione discrezionale.
Relativamente al principio di proporzionalità della sanzione all’infrazione ex art. 2106 c.c., va, pertanto, eliminata la convinzione/aspettativa – nutrita eminentemente da parte datoriale - che esso sia divenuto inoperante a seguito della riforma in oggetto. Come è stato felicemente detto, il principio in parola permane integro, «perché non costituisce il mero e semplice contenuto di un articolo del codice che, peraltro, non è stato abrogato esplicitamente o implicitamente; ma l’elemento caratterizzante dello stesso esercizio del potere disciplinare, che come tale lo connatura e lo condiziona nel suo stesso esistere»[13].
Non si possono sottacere le evidenti difficoltà per l’interprete derivanti dall’esame dei casi concreti, soprattutto nelle ipotesi, frequenti, nelle quali i contratti collettivi contengono una elencazione espressamente definita “non esaustiva” delle condotte disciplinarmente rilevanti e punite con la sanzione disciplinare conservativa, oppure nelle ipotesi in cui il codice disciplinare contenuto nel contratto appaia totalmente carente. E’ stato, quindi, affermato che: «in queste ipotesi, (…) la semplice omessa menzione, nel codice disciplinare, della condotta contestata al lavoratore licenziato, seppure assimilabile, come gravità, ad un'altra per la quale è applicata la sanzione conservativa, dovrebbe portare il giudicante ad affermare la legittimità del recesso, a causa dell’inesistenza di una previsione che riconduca alla condotta in contestazione una diversa sanzione di tipo conservativo»[14].
La drastica e preoccupante conclusione di cui sopra non è accettabile, perché il Giudice detiene pur sempre – come già detto - il potere-dovere legale di azionare il principio di proporzionalità della sanzione all’infrazione, e se, azionando quel criterio, raggiungerà la convinzione che quel comportamento censurabile era meritevole di una sanzione solamente di tipo conservativo, disporrà legittimamente la reintegra del lavoratore, come per le ipotesi di infrazione tipizzate nel codice disciplinare,
Ragionando diversamente ed accogliendo – per mera ipotesi dialettica - la tesi della sanzione della risoluzione del rapporto con indennizzo, si dovrebbe giungere alla conclusione che l’omissione di una tipizzazione nel codice disciplinare di un comportamento censurabile – cioè una negligenza degli agenti contrattuali nell’elencazione delle infrazioni o dello stesso datore, nel caso di un codice disciplinare unilateralmente approntato – verrebbe fatta ricadere ingiustificatamente a danno del lavoratore. Il che non deve essere.
La disciplina sanzionatoria del licenziamento disciplinare si accompagna ad una nuova regola, concernente la decorrenza degli effetti del licenziamento, introdotta con il comma 41 nel testo del nuovo art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge medesima.
La modifica consiste nel fatto che il licenziamento, intimato in esito al procedimento disciplinare di cui all’art. 7 dello Statuto, «produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato».
La carente menzione della malattia - tra le causali sospensive del licenziamento - è del tutto deliberata e intesa al fine di precludere la prassi di non pochi lavoratori di “cadere” in malattia una volta avuto sentore che il datore sta spiccando un provvedimento disciplinare espulsivo; in tal modo mostrando il neo legislatore di condividere la diffusa opinione dell’irregolarità (se non della falsità delle relative certificazioni) - invero con presunzione non assolutamente fondata - e favorendone l’accreditamento nell’opinione pubblica.
5. Le conseguenze per il licenziamento illegittimo disposto per giustificato motivo oggettivo (cd. economico)
Analoghe perplessità suscita la formulazione legislativa relativa alla cd. tutela spettante nel caso del licenziamento illegittimo basato su un giustificato motivo oggettivo e, quindi, su ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva.
In questa ipotesi, la tutela reintegratoria viene dal legislatore contemplata e affidata alla statuizione del Giudice, qualora il licenziamento - sprovvisto dei suoi presupposti di legittimità - sia dal datore di lavoro stato intimato a fronte di un presunto quanto infondato g.m.o., basato sull’inidoneità fisica o psichica (da intendersi sopravvenuta) del lavoratore, oppure quando il recesso sia stato dettato da un presunto (e parimenti infondato) superamento del periodo di comporto, cioè del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia o infortunio.
Si tratta di fattispecie per le quali sarebbe stato semplicemente “scandaloso” – come è stato scritto da P.G. Alleva – che una volta dichiarati illegittimi questi licenziamenti da parte del Giudice, si potesse escludere per essi la soluzione della reintegra e nei quali, peraltro, il danno risarcibile è limitato tra le 5 e le 12 mensilità.
Ancora, la medesima tutela spetta nelle ipotesi in cui il fatto posto a base del licenziamento si riveli manifestamente insussistente, cioè affetto da manifesta infondatezza. Ricorre la manifesta infondatezza del fatto che costituisce presupposto del licenziamento per g.m.o., nel caso - a titolo esemplificativo - in cui il datore di lavoro giustifichi il licenziamento a causa della chiusura di un reparto dell’azienda che risulti essere, invece, attivo ovvero adduca una riorganizzazione priva di oggettivo riscontro.
In mancanza di un’espressa precisazione – è stato notato - «sembrerebbero sottrarsi alla disciplina del reintegro quelle situazioni, frequenti nella prassi giudiziaria, nelle quali sia stata dimostrata l’esigenza di sopprimere un posto di lavoro, ma non anche l’impossibilità di reimpiegare il dipendente ad esso addetto in altre mansioni; ovvero, nell’individuazione del lavoratore da licenziare, non siano stati osservati i criteri di scelta di cui alla l. n. 223 del 1991, che la giurisprudenza ha ritenuto applicabili anche ai licenziamenti individuali»[15]. L’obbligo - di fonte prevalentemente giurisprudenziale, poi tracimato in taluni disposti normativi - di subordinare il licenziamento per g.m.o. al cd. “repêchage”, sebbene permanga a carico del datore di lavoro, non implicherebbe la conseguenza che la sua violazione sia idonea ad invalidare il licenziamento, che, pertanto, il Giudice potrà confermare, disponendo il solo relativo indennizzo economico per il lavoratore.
Il comma 6 del nuovo art. 18 dello Stat. lav. prosegue conferendo al Giudice il potere e l’obbligo di applicare la disciplina di cui al comma 5 – nelle “altre ipotesi” (diverse da quelle in precedenza esaminate) - in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo. Al riguardo, disponendo che: «In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo».
Relativamente al conferimento al Giudice del potere-dovere di individuare e disporre quella più adeguata tra il novero delle tipologie di sanzioni introdotte ex novo, non si è mancato di far rilevare– ancora da P.G. Alleva nello stesso saggio citato in nota 4 – che «è altrettanto palese la pericolosità di un affidamento al giudice del potere di disporre o meno il reintegro (…) una volta che non sono indicati, neppure in termini generici, i criteri ai quali egli dovrebbe attenersi nell’esercizio di tale facoltà. Se ne può arguire che ha proprio ragione il presidente Monti ad affermare, in una nota intervista rilasciata ad un quotidiano americano l’8 aprile scorso, che il reintegro è riferito “a fattispecie estreme e improbabili”. Anche in questo genere di licenziamenti la conseguenza prevista per i casi ordinari è, invero, di carattere meramente patrimoniale e consiste nel pagamento di un numero di mensilità retributive compreso tra 12 e 24; una conseguenza che consentirebbe ai datori di lavoro di sbarazzarsi di elementi ad essi “sgraditi” affrontando il rischio di un mero esborso inseribile tra i costi d’impresa».
Va ancora precisato che la legge di riforma ha previsto per il licenziamento per g.m.o. (cd. economico o per motivi economici) un nuovo strumento conciliativo di natura obbligatoria, nell’ottica di deflazionare il contenzioso giudiziario.
L’art. 1, comma 40, della legge di riforma introduce, infatti, attraverso la riscrittura dell'art. 7 della l. n. 604/1966, una procedura di conciliazione – sulla quale evitiamo di dilungarci per ragioni di economia del presente scritto, rinviando alla piana lettura del comma 40 citato - davanti alla Commissione provinciale di conciliazione costituita presso la Direzione territoriale del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dal nuovo articolo 18, comma 8, della legge n. 300 del 1970, deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ossia il licenziamento determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”), la quale si configura, quindi, come condizione di procedibilità. È previsto che nel corso della procedura le parti possano farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro.
Conviene solo segnalare - in questa sede - che viene disposto che il progetto (o intendimento) del datore di lavoro di licenziare debba essere preceduto da una comunicazione, effettuata a cura dello stesso, alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e, necessariamente, trasmessa per conoscenza al lavoratore.
Viene fatta (o ripristinata), poi, la scelta di considerare esperita la procedura anche nell'ipotesi in cui la Direzione territoriale del lavoro non abbia proceduto ad inoltrare alle parti la convocazione nel termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal datore di lavoro. Reiterando, pertanto, un infelice precedente – con analoghi risultati insoddisfacenti e meramente formalistici – che si attualizzò in passato tramite l'istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione, vigente sino all'emanazione della l. n. 183/2010, il quale se, da un lato, costituiva condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dall'altro si considerava validamente esperito anche se, trascorsi 60 giorni dalla proposizione della richiesta, la Direzione territoriale del lavoro (allora denominata Direzione provinciale del lavoro) non avesse nel frattempo proceduto alla convocazione delle parti. La carente convocazione nei termini da parte della Direzione provinciale del lavoro era divenuta, all’epoca, la regola – e non si vede come non possa essere ripetuta per l’odierna - con l’effetto singolare, quanto irragionevole, del doversi considerare esperita ugualmente la procedura senza che le parti coinvolte avessero dato corso ad un effettivo incontro conciliativo.
Qualora il tentativo di conciliazione dovesse avere esito positivo e portare alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore fruirà del trattamento economico assicurato dalle disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e, in sede di accordo, le parti potranno prevedere - al fine di favorire la ricollocazione professionale del lavoratore (cd. outplacement) - il suo affidamento ad un’agenzia di lavoro somministrato.
La procedura conciliativa obbligatoria implica e prevede - in un ottica di coercizione indiretta, impositiva o di astreinte – che: a) la sua violazione comporta l'inefficacia del licenziamento, la cui conseguenza è rappresentata dalla tutela risarcitoria ridotta; b) il comportamento tenuto dalle parti nel corso del procedimento venga valutato dal Giudice ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria prevista per l'ipotesi dell'illegittimità del licenziamento intimato per g.m.o., ove non dovesse essere pronunciata la reintegrazione nel posto di lavoro; c) il medesimo comportamento rileva ai fini della determinazione delle spese di giustizia.
6. Le inconsistenti conseguenze del licenziamento inefficace
Per licenziamento inefficace deve intendersi: a) quello «intimato in forma orale» oppure, b) in «violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
Entrambi i casi danno luogo ad un licenziamento “inefficace”, ma con un ben diverso rilievo del termine, perché per quello sub a), il comma 1 del nuovo art. 18 Stat. lav. prescrive – come abbiamo già detto - la stessa sanzione prevista in tema di licenziamento per motivo discriminatorio, cioè la tutela reale assicurata dalla “reintegra”; mentre per quello sub b), il comma 6 prescrive la sanzione introdotta dal precedente comma 5 relativamente alle ipotesi “minori” di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (“disciplinare”), garantite con la sola tutela obbligatoria costituita da una “indennità” ridotta del 50%, cioè compresa solamente tra le 6 e le 12 mensilità.
Al riguardo è stato detto, in dottrina, che: «Qualora non fosse stata esperita la previa procedura prevista dall’art. 7, l. n. 300/1970 per il licenziamento “disciplinare”, elevata dal Giudice delle leggi a garante del principio del contradditorio, ne sarebbe dovuta seguire la reintegra. E’ vero, però, che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in casu, valga la stessa sanzione applicabile per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo subbiettivo, quindi reintegra o indennità, in ragione della dimensione occupazionale dell’unità produttiva o dell’azienda. Solo che, qui, la legge di riforma per un licenziamento disciplinare ingiustificato ha previsto la reintegra o l’indennità fra le 12 e le 24 mensilità a seconda della causale; sicché, sarebbe sembrato coerente che alla prevista “inefficacia” si fosse applicata la sanzione più grave, cioè la reintegra e, comunque, non certo quella meno grave ridimensionata, cioè un’indennità ridotta della metà (fra le 6 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, ndr). A sua volta, qualora, invece, non fosse stata svolta la previa procedura contemplata dal novellato art. 7, l. n. 604/1966 per il licenziamento “economico”, secondo la logica generale condivisa dalla stessa legge, ne sarebbe dovuta derivare una improcedibilità (dell’azione in giudizio, ndr). Niente di tutto questo, ma come si è detto, tale inefficacia comporta la condanna ad “un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”. Tale indennità risulta addirittura dimezzata rispetto a quella prevista per le “altre ipotesi” di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (“disciplinare”) protette con la sola tutela obbligatoria, ai sensi del precedente comma 5; oltreché priva di qualsiasi contestuale elenco di criteri per la sua determinazione, se pur sempre accompagnata dalla necessità di una motivazione, con esclusione quindi di ogni liquidazione equitativa»[16].
Non v’è chi non veda come il legislatore abbia consentito al datore di lavoro di trovare un «modo per liberarsi di un lavoratore pagando solo un modesto dazio: effettuare un licenziamento “inefficace”, non dire e non fare niente in giudizio, corrispondere di buon grado l’indennità ridotta»[17].
Ove il citato dazio o costo è suscettibile di incrementarsi solo in presenza della domanda del lavoratore al Giudice di riscontrare se alle violazioni formali si accompagni un vizio di giustificazione del licenziamento. Ipotesi che il legislatore espressamente contempla all’ultimo periodo del comma 6 del nuovo art. 18 dello Stat. lav. (quale riscritto dall’art. 1, comma 42, della legge in commento) tramite la dizione «a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma (sei, ndr), le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo» (notoriamente più onerose per il datore, rispettivamente costituite dalla reintegra indennizzata con un massimo di 12 mensilità; dalla risoluzione del rapporto indennizzata fra le 12 e le 24 mensilità; ovvero dalla reintegra indennizzata con un massimo di 12 mensilità per il caso in cui il difetto di giustificazione attenga all’addotta incapacità psico-fisica del licenziato o al presunto superamento del comporto di malattia o infortunio, mentre - per il difetto di giustificazione nelle “altre ipotesi” più marginali - ricorre la risoluzione del rapporto indennizzata fra le 12 e le 24 mensilità).
7. Le modifiche di favore alla parte datoriale apportate alla disciplina dei licenziamenti collettivi
Il realizzato progetto di ridimensionare la tutela reale e di allargare quella obbligatoria, dall’area dei licenziamenti individuali si è esteso a quella dei licenziamenti collettivi. Infatti tramite l’art. 1, commi da 44 a 46, la legge di riforma va a modificare talune norme della legge n. 223 del 1991.
Stabilisce, in primo luogo, che gli eventuali vizi delle comunicazioni e informazioni inerenti l’avvio delle procedure di mobilità – che, in base all’art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 223 del 1991, vanno rivolte alle strutture sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria - possano essere sanate da un successivo accordo sindacale, più propriamente «nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura sindacale di licenziamento collettivo».
Relativamente alla sanatoria - contemplata tuttavia per via consensuale con organismi sindacali, che all’accordo non possono essere forzatamente costretti - è stato osservato condivisibilmente che essa «rischia di realizzare un drastico affievolimento dei diritti dei singoli lavoratori (eminentemente dei non iscritti ai sindacati, ndr) che attraverso quelle comunicazioni possono oggi esercitare un potere di controllo circa la regolarità delle procedure, denunziarne eventualmente l’illegittimità e, se posti in mobilità, agire in giudizio al fine di essere reintegrati nei loro posti di lavoro. In secondo luogo, ed a prescindere da ogni accordo con i sindacati, l’istituto della reintegra resta fermo solo nel caso, davvero improbabile, in cui il licenziamento collettivo sia privo della forma scritta, ed in quello in cui siano stati violati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, con esclusione, pertanto, di ogni altra inosservanza dell’articolata procedura prescritta dalla legge sopra indicata»[18].
A favore del datore, poi, l’art. 1, comma 44, della legge di riforma elimina la contestualità tra la comunicazione del licenziamento e la comunicazione ai vari soggetti (indicati nel comma 9 dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991) di una serie di dati informativi concernenti i licenziati - fra i quali spicca la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta -, concedendo al datore di lavoro un termine di 7 giorni per fare la seconda comunicazione. In tal modo viene lasciata al datore, dopo la comunicazione dei licenziamenti, la tutt’altro che teorica possibilità – in precedenza preclusa – di un adattamento dei criteri a copertura o correzione di soluzioni già prese.
Sempre con orientamento a favore degli interessi dell’impresa, il comma 10 del nuovo art. 18 introduce, per la prima volta nell’ordinamento positivo, una specifica disciplina della revoca del licenziamento. Al riguardo si dispone che la revoca – la quale notoriamente viene attivata dal datore quando nutre il (quasi certo) sospetto di aver disposto un licenziamento suscettibile di essere invalidato per vizi interni o errori compiuti – va effettuata entro i 15 giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta impugnazione giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore.
In merito è stato detto che: «Si consente, pertanto, tramite l’introdotta disciplina della revoca del licenziamento, al datore di lavoro, il quale - tutte le volte in cui abbia intimato un licenziamento del tutto illegittimo e arbitrario - ove abbia fondate ragioni per pensare che il lavoratore non sia disposto alla reintegrazione, di raggiungere il proprio obiettivo anche a buon mercato»[19], atteso che la retribuzione che dovrà pagare al lavoratore per averlo estromesso, quale sanzione indiretta, non eccederà l’importo relativo a 75 giorni (tenuto conto del termine massimo dei 60 giorni, per l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, cui si vanno ad aggiungere 15 giorni, al massimo, per disporre la revoca da parte del datore).
La revoca è legislativamente configurata quale iniziativa datoriale di “ravvedimento” (o “ripensamento”), alla quale il lavoratore deve sottostare e che è costretto a subire. Chiaramente – in ragione del brocardo “nemo ad facere cogi potest ”- egli è libero di non accettare la revoca[20], ma, essendo stato ora previsto dal comma 10 del nuovo art. 18 dello Stat. lav. che, per effetto della revoca datoriale, «il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo», il neo legislatore ha risolto, in negativo per il lavoratore, la problematica della eventuale spettanza dell’indennità sostitutiva della reintegrazione (ipotizzabile quale “sanzione” alternativa) che lo stesso avrebbe potuto richiedere in sostituzione della sanzione della reintegra a carico del datore, al riscontro da parte del Giudice dell’illegittimità del licenziamento.
Problematica, che nel precedente assetto di carenza di disciplina, era stata affrontata e risolta, invece, in positivo per il lavoratore, al quale la giurisprudenza ne aveva riconosciuto la spettanza (anche in assenza di sentenza costitutiva e dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento), sulla base delle seguenti motivazioni:«L’indennità prevista nell’art. 18, quinto comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall’art. 1, l. 11 maggio 1990, n. 108, è configurata come prestazione che si inserisce, in connessione con il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, in un rapporto obbligatorio avente la struttura di un’obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore. Ne deriva che la facoltà del prestatore non può essere arbitrariamente vanificata dal datore di lavoro revocando il licenziamento in corso di giudizio allo scopo di impedire la pronuncia giudiziale di condanna alla reintegra; onde l’invito a riprendere il lavoro, non seguito da una ricostituzione di fatto del rapporto (per effetto del rifiuto del lavoratore, ndr), non è sufficiente a far venir meno l’attualità dell’obbligo di reintegrazione e a sottrarre il diritto di opzione, il cui esercizio verrebbe altrimenti rimesso di fatto al datore di lavoro» (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 12 giugno 2000, n. 8015).
L’introdotta regolamentazione sottrae la revoca alla situazione di fatto in cui versava in precedenza e, tramite il riconoscimento del (solo) diritto del lavoratore «alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca», con espressa esclusione, per la fattispecie del licenziamento revocato, dell’applicabilità dei «regimi sanzionatori previsti dal presente articolo» - tra i quali può essere ricondotta, anche, l’indennità sostitutiva della reintegrazione (c.d. 15 mensilità, nelle aziende con più di 15 dipendenti) – al lavoratore indisponibile ad aderire alla revoca non resta altro che rassegnare le proprie dimissioni.
La legittimazione giurisprudenziale al rifiuto della “revoca” da parte dell’estromesso a seguito di licenziamento, risiede – come correttamente la precedente giurisprudenza ha evidenziato - nel riconoscimento della natura “bidirezionale” del rapporto fiduciario, cosicché come al datore é consentito di liberarsi, licenziandolo per giusta causa, del dipendente sul quale non nutre, dietro fondati riscontri, più alcuna fiducia, così al lavoratore licenziato é stato riconosciuto il pieno diritto di rifiutare sia l’invito datoriale al ripristino del rapporto a seguito di sentenza sia la revoca del licenziamento nel corso del giudizio, in considerazione della crisi di fiducia subita, di una perdita di stima nel datore di lavoro, di una prospettiva di riammissione in un ambiente ostile ed in una realtà aziendale immutata, del timore di ritorsioni successive, ecc.
Nel vecchio assetto, il rifiuto del lavoratore alla richiesta/invito datoriale di reinserimento in azienda era – dall’orientamento giurisprudenziale di favor per il lavoratore - indennizzato con l’indennità sostitutiva della reintegra, d’ora in poi non più!
Il carattere imperativo della disciplina regolante la revoca – provvedimento unilaterale cui il lavoratore viene assoggettato per effetto di una “comoda” e non onerosa iniziativa datoriale - sembra precludere anche un eventuale richiesta di risarcimento di danno.
****
In tema di licenziamenti va ricordato altresì che tramite l’art. 1, comma 37, il legislatore ha disposto - stavolta apprezzabilmente – che i motivi del licenziamento siano specificati contestualmente alla comunicazione del licenziamento, cioè nella stessa lettera e, dunque, non dopo che quest’ultimo ne abbia fatto richiesta, come in precedenza; sostituendo, pertanto, il comma 2 dell’articolo 2 della l. n. 604/1966 che, d’ora in poi, risulta così formulato: «La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».E’ stato altresì disposto, tramite l’art. 1, comma 38, della legge di riforma in commento, che il termine di 270 gg. – introdotto a pena di decadenza dall’art. 32 della l. n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) per il deposito del ricorso giudiziale dopo l’impugnativa del licenziamento (e rivendicazioni assimilate) effettuata entro i 60 gg. dall’irrogazione – sia abbassato a 180 gg., precisando al comma 39 del non doversi applicare, il nuovo termine ridotto, retroattivamente ma solo «in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge». Disposizione che è stata letta[21] costituire la prosecuzione di una politica di favor in materia verso le imprese, anticipata con il precedente governo che aveva – tramite la l. n. 183/2010 citata – introdotto l’obbligo di deposito del ricorso del lavoratore entro gli oramai superati 270 giorni.
(Altalex, 11 luglio 2012. Articolo di Mario Meucci)
_______________
estratto da http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=18878





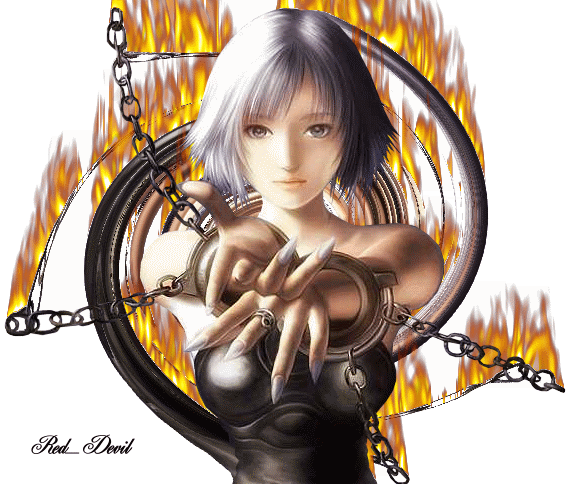
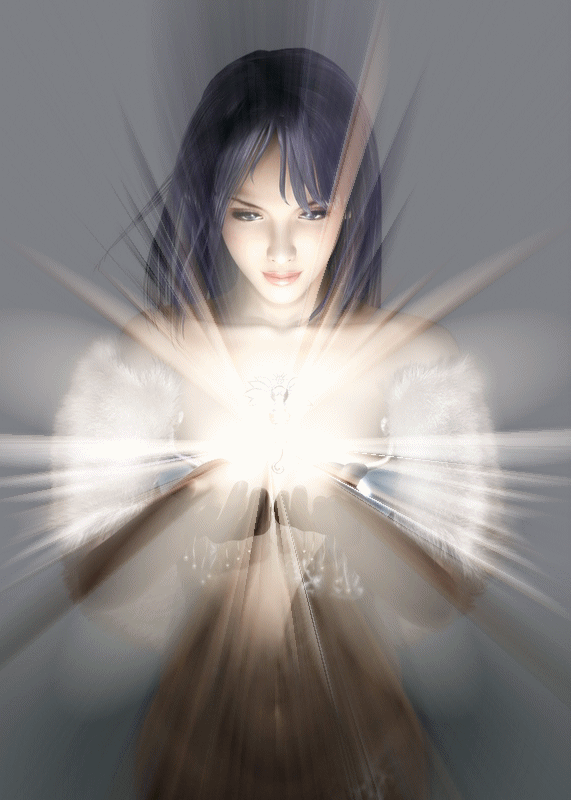
Nessun commento:
Posta un commento