Articolo 12.07.2012 (Catello Avenia)
Sommario
Del concetto di Minoranza
1. Definizioni proposte
2. Il riconoscimento ufficiale delle minoranze da parte dei singoli stati
Evoluzione storica della protezione delle minoranze
1. Fino alla Grande Guerra
2. L'assetto dopo la conferenza di Parigi
3. L’ONU, la dichiarazione universale dei diritti umani ed il Consiglio d’Europa
Attività di protezione
1. Patti internazionali sui diritti dell'uomo
2. Art.27 Patto sui diritti civili e politici: principi ed applicazioni
3. Convenzione europea sui diritti umani
Analisi del sistema
1. Obiettivi perseguiti dai governi
2. Il caso dei conflitti nella ex Iugoslavia
3. L’intervento della comunità internazionale
4. La richiesta di misure cautelari alla Corte di Giustizia Internazionale
5. Risultati conseguiti
6. Ulteriori strumenti da adottare
Bibliografia
Testi e monografie
Atti e Documenti
Del concetto di Minoranza
1. Definizioni proposte
 “Il problema delle minoranze è in realtà una congerie di singoli e specifici problemi ognuno dei quali gravante su un complesso di fattori politici, etnici, economici, sociali e, non ultimo, storici”: con queste parole si presentava, all'inizio degli anni cinquanta, un rappresentante dell'Assemblea generale dell'ONU[1] al fine di trovare una giustificazione alla difficoltà di raggruppare insieme sotto un’unica ed esaustiva definizione tutti i problemi relativi alla moltitudine di gruppi di minoranze, per apprestar loro adeguati sistemi di normative per la protezione dei loro diritti.
“Il problema delle minoranze è in realtà una congerie di singoli e specifici problemi ognuno dei quali gravante su un complesso di fattori politici, etnici, economici, sociali e, non ultimo, storici”: con queste parole si presentava, all'inizio degli anni cinquanta, un rappresentante dell'Assemblea generale dell'ONU[1] al fine di trovare una giustificazione alla difficoltà di raggruppare insieme sotto un’unica ed esaustiva definizione tutti i problemi relativi alla moltitudine di gruppi di minoranze, per apprestar loro adeguati sistemi di normative per la protezione dei loro diritti.
Nonostante il tempo trascorse, non è ancora chiara una definizione univoca del termine “minoranza” e le difficoltà dipendono dalle diverse metodologie adottabili per delimitarne il contenuto, sia in termini numerici (ossia il rapporto tra il gruppo di moniranza ed il resto della popolazione) che nella recisa opposizione a tale criterio. Oppure, nell’adottare, quali determinanti, fattori soggettivi di identificazione piuttosto che oggettivi, come la necessità di considerare o meno come minoranze i flussi migratori. La sociologia ci suggerisce l’esistenza di almeno tre correnti di studio delle minoranze: una europea – di matrice storico-giuridica ed etnografica - attiva sulle tradizioni autoctone, contraddistinte dalla lingua, dalle peculiarità nazionali, dalle religioni, che vengono in evidenza quale conseguenza di riordinamenti territoriali nazionali; una nordamericana, impegnata sulle minoranze alloctone, risultato congiunto di migrazione ed urbanizzazione, e che ricorre anche alla psicologia sociale per studiare i problemi razziali; ed infine una terza corrente, tendente a classificare tra le minoranze tutti i poveri, i subordinati, gli emarginati ed i deviati della società.
Con queste basi teoretiche, gli studiosi avanzano, con approssimazioni, verso l’individuazione del significato di concetti più o meno interconnessi, come naizone, popolo, gruppo etnico, minoranza nazionale e gruppi linguistici. È bene sottolineare che simili teorizzazioni, anche se rilevani per l’indagine conoscitiva, sono devianti a livello operativo, specialmente per le diverse qualificazioni che all’interno dei singoli ordinamenti il problema assume, in ragione della diversa importanza riconosciuta ai singoli fattori ed alle relative componenti. Individuare una precisa definizione di minoranza risiede, con molta probabilità, nella necessità di limitare la tendenza espansiva del movimento minoritario, evitando, così, di ricomprendervi anche gruppi fondati su bas inconsistenti. Con il risultato, di non poco peso, di facilitare la sicura applicazione dei trattati. In opposizione a tale tendenza oggettiva, alcuni studiosi considerano che l’appartenere ad una minoranza sia una questione non di fatto ma di volontà, sottolineando quindi implicazioni decisamente soggettive. Diversamente ha statuito la Corte Permanente di Giustizia Internazionale che, in due pronunce (una del 1928 relativa all’interpretazione sul trattato delle minoranze da parte della Polonia ed un’altra del 1930 in occasione della migrazione di comunità greco-bulgare in attuazione della convenzione intercorsa tra i due paesi) affermò che il diritto di reclamare i benefici riservati, dai trattati, alle minoranze, fosse una questione di fanno e non di volontà o di diritto.
Successivamente la Sottocommissione ONU per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione delle minoranze auspicò ,’adozione, da parte della Commissione per i diritti umani, di una risoluzione per la definizione del termine “minoranze” ai fini della loro protezione da parte dell'ONU. In tal senso vennero individuati i fattori da considerare: a) l’esistenza di gruppi riconosciuti come minoranze ed aventi caratteristiche etniche, religiose o linguistiche proprie e differenti da quelle del resto della popolazione, meritevoli di tutela internazionale per la loro conservazione ed il loro sviluppo; b) la circostanza che sebbene minoranza evochi “un minor numero di individui rispetto alla popolazione”, questi possono comunque rappresentare il gruppo dominante per le loro caratteristiche peculiari; c) il non voler interferire con lo sviluppo che spontaneamente si produce in una società posta a diretto contatto con un nuovo ambiente, con ciò che i moderni mezzi di comunicazione comportano, in termini di una rapida evoluzione razziale, sociale, culturale o linguistica; d) il rischio di adottare misure che possano comportare abusi nei confronti di una minoranza; e) il non voler concedere protezione a pratiche incompatibili con i diritti proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti umani; f) le problematiche connesse al riconoscimento dello "status" di minoranza da parte di gruppi così piccoli da poter determinare, se accolte, un carico spropositato per le risorse economiche di quello Stato. Altri elementi da considerare dovevano essere: 1) che il termine minoranza includesse solo i gruppi non dominanti di un popolo, desiderosi di salvaguardare le proprie tradizioni linguistiche, etniche e religiose, qualora segnatamente differenti da quelle del resto della popolazione; 2) che talune minoranze dovrebbero già comprendere in sé un numero sufficiente di membri a proteggere le proprie tradizioni; 3) che tali minoranze debbano essere fedeli allo Stato in cui si trovano.
Il lavoro della Sottocommissione si svolse secondo le direttive ricevute ed il materiale raccolto venne consegnato alla Commissione per i diritti umani; ma le critiche, anche dure, comunque arrivarono. Soprattutto per l’eventualità che il gruppo dominante della popolazione avrebbe potuto giustificare la mancata astensione dell’uguaglianza dei diritti ai gruppi minoritari, qualora fosse mancata in questi la volontà di mantenere la propria individualità. Carattere decisamente soggettivo ma discriminante. Altri, invece, evidenziarono la mancanza, nel disegno proposto, dela circostanza che la minoranza non può includere stranieri residenti nello Stato, od i gruppi formatisi per effetto di ondate migratorie.
Nel 1950 il Segretario Generale ONU, in un memorandum, mise in risalto come il termine “minoranza” possa riferirsi a comunità nazionali o gruppi similari che differiscono da quello predominante nel paese in quanto costituite in un vero e proprio Stato indipendente, già parti di un’unica nazione e poi da esse separatesi, o per essere (o essere stati) dei gruppi locali che non solo riusciti a costituire un grado, seppur minimo, di assimilazione reale con il gruppo dominante. Il Capotorti, relatore speciale della Sottocommissione, sottopose ai pareri dei governi e delle organizzazioni locali, alcune sue notazioni: la rilevanza del fattore soggettivo costituito dal desiderio più o meno espresso dei gruppi minoritari di salvaguardare le proprie tradizioni, il numero dei membri dei singoli gruppi, la possibile costituzione di una società multirazziale e l’applicabilità dei principi enunciati all’art.27 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.
In ragione delle risposte ricevute su tali teorie, la Sottocommissione ha conferito particolare importanza al fattore numerico, non solo in senso assoluto, ma anche in rapporto all’estensione territoriale di stanziamento del gruppo. Pari importanza venne riservata al fattore soggettivo, ovvero il desiderio del gruppo al mantenimento delle tradizioni e presupposto per la costituzione di ogni minoranza in un’entità autonoma, culturale e sociale. Infine, elemento ricognitivo venne considerato il senso di comunità persistente tra i singoli membri del gruppo, oltretutto definito dall’esistenza dei rapporti sociali intercorrenti tra gli individui. L’interpretazione del Capotorti fu considerata troppo estensiva dalla Sottocommissione, nonché inapplicabile a determinati paesi anche per la diversa natura dei problemi gravanti sulle minoranze tribali rispetto ai gruppi viventi all’interno di una società industriale. In tale ottica, i gruppi costituiti da immigrati, od i loro discendenti, non potrebbero essere inclusi nella definizione di “minoranza” poiché di volontaria assimilazione[2].
Si pone, così, la necessità di considerare la differenza tra “minorities by force” (minoranze coatte od involontarie) e “minorities by will” (minoranze volontarie): le prime tendono a far attuare i principi d’eguaglianza nel senso di divieto di trattamenti differenziati, come nel caso di gruppi minoritari contro cui vengono attuate discriminazioni razziali o politiche; le minoranze volontarie, invece, desiderano che cessino le discriminazioni di cui sono bersaglio e chiedono vengano tutelati i caratteri differenziali tra esse e la parte dominante della popolazione. Nel secondo caso, la tutela apprestata non necessita di uniformità di trattamento ma di una disciplina differenziata, come nel caso di minoranze etniche o linguistiche, per le quali un trattamento paritario costituirebbe una vera e propria oppressione delle loro legittime rivendicazioni. Nel 1973 il Consiglio d’Europa ha riferito, nell’ambito della Commissione europea sui diritti umani, di “persons belonging to National minorities” a proposito della questione sollevata dal suo organi governativo, sul contrasto tra l’art.14 della Convenzione, che parla di “national minorities”, e l’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici dell’ONU, che invece riferisce “ethnic, religious or linguistic minorities”, come appunto per differenziare.
Nella susseguente indagine, la Commissione ha osservato, inoltre, che manca il termine “minoranze nazionali” all’interno dei trattati conclusi dalla prima guerra mondiale in poi, e che appare per la prima volta, usato nella Convenzione contro la discriminazione nella educazione, adottata dalla Conferenza Generale dell’Unesco (art.5) nel 1960, anche se in modo tale da non rendere chiara la sua applicazione[3]. Dovrebbero essere qualificati come minoranza nazionale i gruppi che si differenziano tradizionalmente e consapevolmente per i loro caratteri distintivi, dalla maggioranza della popolazione dello Stato in cui stabilmente risiedono, esclusi gli stranieri non inseriti in forma stabile, gli emigrati e tutti i gruppi che aspirano all’assimilazione, ovvero le “minorities by force”.
Una citazione merita il seminario tenutosi ad Ohrid nel 1974 (nell’attuale Repubblica di Macedonia), nel corso del quale, posto l’accento sull’impossibilità di dar vita ad una definizione plurivalente di “minoranza”, venne avanzata una formula: “E’ minoranza un gruppo di cittadini sufficiente per numero a perseguire le aspirazioni della collettività, ma inferiore numericamente al resto della popolaizone, legato insieme da tradizioni storiche, etniche, culturali, religiose o linguistiche e desideroso di conservare integri tali legami, differenti da quelli propri dal gruppo dominante”. Seguiranno altri rapporti ONU[4], ai fini dell’applicazione della tutela dei diritti umani, ma grossi cambiamenti non sono ancora intervenuti. È bene, però, riassumere i due criteri principali fino a ora proposti: uno oggettivo, cioè l’esistenza nell’ambito di uno Stato, di gruppi distinti che ne posseggono la nazionalità e stabili caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono in modo palese da quelle del resto della popolazione, rispetto cui è in una relazione di non dominanza ed inferiore di numero; l’altro soggettivo, ovvero il desiderio dei membri dei gruppi in questione, si tutelare i caratteri peculiari, il quale desiderio, se si assumesse che debba preesistere all’applicazione dell’art.27, può far temere che lo Stato approfitti della sua assenza per giustificare il proprio rifiuto alla protezione dell’individualità del gruppo. Il desiderio emerge dall’esercizio continuato, da parte di quel gruppo, nelle sue tradizioni[5]: e questo, se considerato complementare al criterio oggettivo, già contribuisce a definire in modo esauriente il concetto di “minoranza”.
2. Il riconoscimento ufficiale delle minoranze da parte dei singoli stati
I comportamenti assunti dagli Stati nei riguardi delle minoranze, hanno assunto spesso toni di antiteticità: sal riconoscimento della loro esistenza riportato in una Carta costituzionale, alla mancanza di una qualsiasi forma di tutela giuridica. E tra questi estremi vi sono, spesso, numerose posizioni intermedie, come legislazioni speciali, specifiche misure amministrative od il semplice riconoscimento di organizzazioni private che rappresentino gli interessi di questi gruppi minori. Ma anche il termine “riconoscimento”, assume diversi significati, potendo indicare lo status di persona giuridica, una serie coordinata di diritti miranti a garantire i membri di alcune comunità(in base ai principi di protezione dell’identità minoritaria).
Nella maggior parte dei casi, l’unica misura utile è la garanzia di alcuni diritti specifici, senza il ricorso ad una sovraposizione organica ed in questo caso il riconoscimento della minoranza deriva dal fatto stesso della tutela – anche se parziale – apprestata. La difficoltà di ottenere un significato unitario del concetto di minoranza influisce direttamente sulla protezione internazionale, anche se elementi sufficienti a dimostrare la sua esistenza, consentirebbe l’applicazione delle regole internazionali, a cominciare dall’art.27 del Patto sui diritti civili e politici. Il problema così presentato, può esser considerato da due punti di vista: secondo il senso del concetto giuridico di riconoscimento ufficiale di determinati gruppi della popolazione, ed attraverso l’esame del procedimento logico secondo cui si mette in relazione un singolo individuo ad un gruppo, al momento di applicare il particolare status che lo riguarda. Tutto è però complicato non solo dal diverso approccio da tenere in relazione a Stati diversi, ma anche a causa delle diversità che si possono manifestare nell'ambito dello stesso paese, per le diverse caratteristiche che rivestono i singoli gruppi.
Vi sono poi casi in cui lo Stato, anche ammettendo l’esistenza di un gruppo minoritario all’interno della sua popolazione, mette in campo misure rigide nei confronti proprio dei suoi membri, come nel caso del Regno Unito quando ribadisce l’inesistenza di procedure ufficiali di riconoscimento di una minoranza, al fine di salvaguardare i diritti che le sono propri e sempre fino a quando tale minoranza non necessiti un riconoscimento ufficiale per la sua sopravvivenza. All’opposto, molti sono i paesi ove si è proceduto ad un riconoscimento ufficiale di determinati gruppi etnico-linguistici come minoranze, per concedere una diversità di trattamento, in relazione alle loro esigenze. Ed alcuni di questi paesi, hanno provveduto ad inserire, il diritto di riconoscimento, nel loro sistema normativo, come risulta da trattati internazionali o da accordi bilaterali, nell’ambito dei quali, i gruppi vengono qualificati come “minoranze nazionali”, “nationalities”, “cultural communities” o molto semplicemente, come avviene i Svizzera, come gruppi linguistici.
In molti Stati, poi, le leggi ed i regolamenti interni riguardano l’uso delle lingue dei vari gruppi linguistici, se questi non siano stati ufficialmente riconosciuti come minoranze. Quattro, dunque, sono le categorie di soluzioni adottate: 1) il riconoscimento costituzionale dell'esistenza di gruppi distinti e del diritto dei loro membri a godere di un regime speciale, soprattutto di tutela dello sviluppo collettivo; 2) il riconoscimento di determinate minoranze e la loro salvaguardia, sulla base di strumenti giuridici internazionali ad hoc; 3) il riconoscimento implicito, attuato attraverso leggi e regolamenti concernenti lo sviluppo della cultura di determinati gruppi linguistici; 4) non riconoscimento di minoranze nel sistema di diritto locale, dovuto ad atteggiamenti politici di totale rifiuto della loro esistenza, o ad esigenze di neutralità, comportanti misure privatistiche di tutela.
Le prime due soluzioni, sono decisamente ottimali, per riscontrare ordinati sistemi di tutela diretta. Ma se l’esistenza di una minoranza è obiettivamente dimostrabile all’interno di uno Stato, quest’ultimo non è dispensato dall’applicare l’art.27. Questo è facilmente realizzabile se leggi locali o regolamenti vengono adottati, anche senza un riconoscimento a livello costituzionale. Con l’espansione della democrazia, e delle sue garanzia, è possibile risolvere il problema tramite misure di diritto interno; con il diritto internazionale si può supportare ed indirizzare la normativa interna, tendendo a realizzare un diritto comune delle minoranze, fondato sui principi di libertà ed uguaglianza[6].
Evoluzione storica della protezione delle minoranze
1. Fino alla Grande Guerra
Pochi sono gli Stati in Europa che non prevedono un riconoscimento costituzionale dell’esistenza delle minoranze ed una tutela del principio di uguaglianza tra i cittadini nei confronti di qualsiasi discriminazione. Ma sono nel 1966, si avrà l’enunciazione di un principio internazionalmente accettato, ovvero l’art.27 del Patto sui diritti civili e politici. Il processo per arrivare a tale risultato, ha origini molto lontane ed una comune base: tutte le principali religioni si richiamano al principio di fratellanza, al di sopra di ogni distinzione di razza, colore o linguaggio; inoltre sono state proprio le persecuzioni religiose a costituire le prime occasione di ricerca di questi valori fondamentali di fratellanza universale. Bisogna tenere distinte le minoranze religiose da quelle nazionali anche al fine di evidenziare la sproporzione tra i due tipi, ed in relazione al tempo, distinguere il periodo che ha inizio dalla Riforma protestante - che ha originato le minoranze di fede - fino alla Rivoluzione francese - che ha invece sottolineato il principio della nazionalità - da quello che arriva dal congresso di Berlino del 1878 ed a tutte le convenzioni che precedettero lo scoppio del primo conflitto mondiale[7].
Punto di partenza sono i trattati di Passau ed Augsburg (rispettivamente del 1552 e del 1555) che rappresentano un tentativo di applicare la protezione della libertà di culto, sotto l'imperatore Carlo V[8]. Segue l’editto di Nantes del 1598, promulgato da Enrico IV, limitato alle minoranze religiose, regolando in maniera più completa il libero esercizio della fede protestante, ed istituendo dei tribunali speciali. Inoltre, la Capitolazione concertata in Milano il 3-9-1639 in nome di S.M. Cesarea e Cattolica, tra il conte di Daun e gli ambasciatori Grigioni quanto a religione, governo ed altri particolari spettanti ai contadi di Bormio e Chiavenna in Valtellina, che agli artt. 26 e 27 garantiva di fare osservare la religione cattolica apostolica romana con esclusione di ogni altra. Con i trattati di Westfalia del 1648 si fece, però, un notevole passo a ritroso: la libertà religiosa è accordata solo ai Prìncipi, mentre per il popolo vale il detto “cuius regio, eius religio”, da cui l’esigenza di norme per regolare la migrazione di quei sudditi fedeli al culto, entro due anni dalla data del trattato. Il primo trattato di pace, modificativo di tale ordine, fu quello di Oliva del 1660[9] che stabiliva fra l’altro, il libero esercizio della religione cattolica ai residenti del territorio di Livonia, ceduto dalla Polonia alla Svezia.
Analogamente il trattato di Nimega del 1678 tra Francia ed Olanda, garantì libertà di culto cattolico alla minoranza di fede residente nel territorio di Maastricht, ceduto dalla Francia all'Olanda[10]. Pari principio fu sancito fra le stesse parti nell’accordo di Ryswick del 1697, per la restituzione di altri territori, i cui abitanti poterono continuare a professare la propria fede. Nel trattato di Utrecht del 1713, con cui la Francia cedette all’Inghilterra la baia di Hudson e l’Acadia, si ebbe un rinvio alla legislazione interna inglese, accordando protezione ai sudditi solo se non in contrasto con l’ordine pubblico; si concedette inoltre agli abitanti dei luoghi ceduti una parvenza di opzione della cittadinanza, esercitabile entro un anno dalla data del trattato.
Analogo a questo, il trattato di Parigi del 1763, a cui parteciparono anche Spagna e Portogallo per ciò che riguardava il trasferimento dei francesi del Canada e degli spagnoli delle isole Grénade in altri territori, in rispetto del loro culto cattolico romano[11]. Prossimi alla Rivoluzione francese sono i trattati di Breslau (1742), Dresda (1745) e Varsavia (1772), tutti inerenti il libero esercizio del culto esercitato dalla popolazione del territorio ove era avvenuto un mutamento dell’autorità secolare.
Dalle disposizioni citate non si comprende se tale libertà venne poi realmente rispettata e tutelata anzi bisogna osservare che, quando l’evoluzione dei diritti civili dell’individuo pervase le coscienze delle classi più progredite, venne meno l’esigenza di tale tutela, ormai radicata. Infatti dopo la Rivoluzione francese (1789), rinveniamo il trattato di Vienna del 1815 concluso tra Austria e Regno d’Olanda (frutto dell’unificazione tra Belgio e Paesi Bassi), recante speciali garanzie in favore della minoranza cattolica belga, per il libero credo religioso e l’ammissione ai pubblici uffici. In contemporanea, nel Protocollo finale del Congresso di Vienna, si riservò ampio spazio al problema della salvaguardia delle minoranze nazionali, intesa come principio di autodeterminazione politica dei paesi firmatari (Austria, Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Prussia, Svezia) avviando il riconoscimento e la garanzia dei diritti di una nazione: art.1"...les Polonais, sujects respectifs de la Russie de l'Autriche et de la Prusse, obtiedront une representation et des institutions nationales, reglées d'aprées le mode d'existance que chacun des gouvernements aux quels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder"[12].
Il protocollo non chiarisce quali fossero i diritti nazionali da garantire: alcuni autori propendono per i diritti politici, altri fanno riferimento all'identità culturale delle minoranze considerate. Nel trattato di Parigi del 1856, tra Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Regno di Sardegna e Turchia, l'art.IX riporta una comunicazione tra il Sultano turco e gli altri contraenti, a proposito della legislazione da lui introdotta per il riconoscimento di un trattamento egualitario anche per i cristiani ivi abitanti, senza discriminazione alcuna. Il trattato di Berlino del 1878, rafforzò l’ideale antidiscriminatorio in materia di culto all’interno dei paesi Balcani; così pure la convenzione internazionale di Costantinopoli vergata nel 1881 in relazione all'uguaglianza ed al libero esercizio della propria religione, per i musulmani residenti nei territori annessi alla Grecia.
In questi ultimi trattati, nessun diritto riguardò mai le minoranze di lingua, tranne il protocollo finale del Congresso di Vienna, che sancì la libertà di usare il polacco nel territorio di Poznan, unitamente al tedesco.
3. L’ONU, la dichiarazione universale dei diritti umani ed il Consiglio d’Europa
È giusto sottolineare che, in ambito assembleare, tutte le discussioni aventi per oggetto la protezione delle minoranze, vennero considerate da un punto di vista socio-culturale ed umanitario piuttosto che politico, come invece avveniva nell’Assemblea delle Società delle Nazioni. Il problema venne affrontato dall’Assemblea nel 1952[17], statuendo che la prevenzione delle discriminazioni e la protezione delle minoranze erano da considerare come due tra le branche più importanti del lavoro dell’ONU. Volendo rintracciare qualcosa di non positivo nell’azione dell’ONU in materia di garanzia internazionale del rispetto dei diritti umani, lo si rinverrebbe nell’efficacia, non sempre puntuale, dell’azione stessa. Infatti tutti i trattati, fino ad ora menzionati, contengono strumenti di controllo ma la loro attuazione è spesso devoluta agli Stati membri: sono previste due procedure, ben distinte, promuovibili a seguito di comunicazioni di individui o di gruppi a relativi a “gravi e massicce violazioni dei diritti umani”.
La prima (del 1967) ha carattere pubblico, la seconda (del 1970) ha carattere confidenziale ed entrambe possono comportare motivo di inchiesta della Commissione per i diritti umani, se lo Stato interessato accetta il potere oppure la formulazione di un rapporto sulle violazioni constatate. Se valutiamo che dietro la Commissione vi sono gli Stati che si rendono colpevoli delle violazioni, si comprendono le forti limitazioni con le quali l’ONU deve operare, vista l’estrema eterogeneità dei paesi membri, in fatto di regime politico ed economico.
Diversamente dall’Assemblea Generale ONU, il Consiglio d’Europa è un’organizzazione intergovernativa, nata da un’idea di Winston Churchill del 1943 e concepito quale istituzione internazionale, volta ad unire e rafforzare, politicamente, ma anche sul piano ideale e culturale, i paesi democratici dell’Europa occidentale ed a promuovere il rispetto dei diritti umani[18]. Nel 1948, al congresso dell’Aja si dovette scegliere tra un modello inglese, con un’Europa fontata sulla operazione interministeriale dei vari Stati, ed un modello franco-belga, con un’integrazione da attuarsi tramite la creazione di un Parlamento.
Il trattato istitutivo fu quindi un compromesso, coesistendo accanto ad un organo intergovernativo – il Comitato dei Ministri – un organo collegiale – l’Assemblea consultiva – con deputati eletti dai Parlamenti nazionali, ma senza poteri decisionali. Nel preambolo del trattato, viene espresso "il forte vincolo ai valori spirituali e morali dei popoli che lo compongono, che sono all'origine dei principi di libertà individuale e politica ed al principio di supremazia del diritto, valori sui quali si fonda ogni democrazia". Frutto dell’elaborazione dell’Assemblea consultiva del 1949, fu un importantissimo trattato internazionale: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, concepita nel segno della protezione dei diritti civili e politici, mentre i diritti economici e sociali vengono tutelati dalla più recente Carta sociale europea del 1961. In questo modo sono garantiti il diritto alla vita, la proibizione della tortura, della schiavitù, delle pene inumane e degradanti, il divieto di ricorrere retroattivamente alla legislazione penale, il diritto alla corretta amministrazione giudiziaria, il rispetto della privacy del domicilio e della corrispondenza, le libertà di pensiero, coscienza e religione, opinione ed espressione, di riunione, di matrimonio e della costituzione di un nucleo familiare, i diritti a libere elezioni, a riunirsi in partiti e sindacati ed a scegliere l’istruzione per i propri figli.
Le norme relative ai diritti economici e sociali, non conferiscono ai destinatari una soggettività giuridica, ma vengono considerate come princìpi cui informare l’attività legislativa dai singoli Stati. Per ciò che concerne le minoranze, la Convenzione costituì un notevole progresso rispetto alla Dichiarazione universale dell'ONU, in quanto, a differenza di questa, menziona in forma chiara il termine “minoranze nazionali” e contiene disposizioni che prevedono sistemi di controllo e garanzia, nel caso di violazione dei diritti tutelati. In pratica, tale menzione costituisce una formulazione positiva ed esplicita dei singoli diritti riconosciuti, mentre nella Convenzione ONU, all’art.27, si enunciano delle premesse cui non possono essere negati gli stessi diritti, solo che questo si può soltanto desumere implicitamente.
Gli orani previsti nella Convenzione europea sono la Commissione europea dei diritti dell’uomo, composta da tanti membri quante sono le parti contraenti ed a cui può ricorrere ogni parte se un altro Stato non abbia assicurato, nella sua giurisdizione, i diritti e le libertà previste, od anche qualsiasi individuo od organizzazione non governativa, a patto che lo Stato contro cui è diretta la petizione abbia dichiarato di riconoscere tale particolare competenza. Viene poi la Corte europea dei diritti dell’uomo, cui possono ricorrere le parti contraenti e la Commissione stessa se questa non sia riuscita a dirimere la controversia ma a patto che le parti interessate abbiano riconosciuto tale giurisdizione obbligatoria. Nonostante la complessità del sistema, in alcuni casi gli Stati hanno apportato modifiche alla legislazione nazionale sulla base delle critiche degli organi di controllo, mentre in altri casi l’incapacità d’intervento degli organi stessi ha creato situazioni di tensione, come avvenne nel 1921 in Irlanda del Nord[19], nei Paesi baschi e nel luglio 1974 a Cipro, dove in virtù dell’art 4 di un Trattato intercorso il 16 agosto del 1960 tra i governi di Turchia, Grecia ed Inghilterra, l’intervento dell’esercito turco, legittimato a livello internazionale dal Consiglio d'Europa[20], pose un argine alle sofferenze in cui versava la comunità turco-cipriota[21].
Attività di protezione
1. Patti internazionali sui diritti dell'uomo
A questo punto, osserviamo gli strumenti di recente fattura e di rilevante importanza, a cominciare dai Patti sui diritti umani del 1966, frutto di una intensa e lunga stagione dibattimentale della Commissione ONU per i diritti dell'uomo, iniziata nel 1947 sulla base dell'incarico affidatole dal Consiglio economico e sociale: formulare proposte per una dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo e circa i mezzi necessari ad affermarne il rispetto. Si avvertì subito la necessità di redigere, insieme alla dichiarazione, un progetto di convenzione che definisse i singoli diritti ed i limiti posti al loro esercizio, in connessione con un certo numero di misure di applicazione. Apparve però impossibile definire contemporaneamente alla dichiarazione, un progetto di convenzione che chiarisse i singoli diritti ed i limiti posti al loro esercizio, in connessione con un certo numero di misure di applicazione. Da cui la decisione di concentrare gli sforzi sul progetto di dichiarazione che vide la luce nel dicembre 1948, rimandando a numerose sessioni della Commissione il lavoro rimasto.
Ricordiamo, l’inserimento dei diriti economici, sociali e culturali seguiti da quelli civili e politici – già considerati[22]- e la divisione in due Patti (nel 1952), introducendo però in entrambi, un articolo sul diritto di autodeterminazione dei popoli. Nonostante la contrapposizione in blocchi delle grandi potenze, l’Assemblea portò a termine il lungo dibattito, complice l’approvazione nel 1965 della Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, comprese una serie di misure di applicazione. In proposito, va sottolineato come gli organismi internazionali attivi nel campo economico e sociale, ponendo in essere progetti specifici di attività, siano stati indotti ad astrarre taluni principi di base relativi ai diritti dell’uomo, dalle linee generali dell’azione pratica che verso gli anni ’60 aveva ad oggetto la condizione umana. In secondo luogo, l’applicazione pratica di misure tendenti a risolvere problemi di carattere economicoe sociale, ha decisamente contribuito ad indicare quali dovessero essere le condizioni necessarie all’attuazione dei singoli diritti, e quindi non solo venne enunciato il diritto ma anche elencate le condizioni, premesse per l’attuazione del diritto in questione[23].
Osserviamo allora, i vantaggi e gli svantaggi del dualismo di due Patti al posto di uno solo. Il carattere programmatico dei diritti economici, sociali e culturali che comportano un’azione positiva dello Stato, è sicuramente diverso dal carattere precettivo dei diritti civili e politici, la cui natura assoluta presuppone l’astensione dello Stato da ingerenze in una sfera individualmente tutelata[24]. Infatti per garantire il godimento dei primi, ogni Stato svolge un’azione di concreto intervento, con misure amministrative nonché tecniche graduali; mentre per godere dei diritti civili e politici, bastano le norme presenti nell’ordinamento, compreso il ricorso al giudice, in caso di loro violazione. Tali confini non sono sempre netti, e quindi si dovrebbe sostenere che l’immediatezza e la gradualità nella realizzazione dipendono dalle strutture economiche preesistenti, politiche e sociali, invece che dalla pura natura dei singoli diritti[25].
Molti sono gli aspetti comuni tra i due Patti, dalla strutturazione al contenuto di alcune clausole. Entrambi si aprono con un preambolo e continuano con l’enunciazione del principio di autodeterminazione dei popoli (art.1). Le parti seconda, terza e quarta regolano rispettivamente, le misure di applicazione interna, i singoli diritti e le misure di applicazione internazionale, mentre la parte quinta del Patto sui diritti civili e politici si compone di due articoli che nell'altro Patto sono stranamente inseriti nella parte quarta. In entrambi l'ultima parte è formata dalle clausole finali d'uso comprendenti firme, ratifiche, adesioni ed emendamenti. Il Protocollo opzionale, annesso al Patto sui diritti civili e politici, contiene due gruppi di disposizioni: le competenze del Comitato per i diritti dell'uomo a ricevere od esaminare comunicazioni individuali, e per ultime, le clausole finali. Oltre l’esame dei singoli articoli, è bene considerarne il contenuto evidenziando da subito che i diritti enunciati nei Patti sono ugualmente assicurati a tutti gli individui e si riferiscono ad ogni persona. Il rafforzamento di tale principio di uguaglianza degli individui nel godimento o nell’esercizio di tali diritti, proviene dalle clausole di non discriminazione, poste all’art.2 dei Patti, con una duplice funzione: implicare che gli obblighi assunti dai contraenti in virtù delle norme materiali dei Patti debbano eseguirsi senza discriminare tra i beneficiari e dar vita ad un elenco delle più diffuse cause di discriminazione.
Nelle convenzioni del 1964-’65 erano previste misure atte a prevenire il fenomeno; nei Patti, invece, l’eliminazione delle discriminazioni è strumentale rispetto alla realizzazione dei vari diritti tuelati. I beneficiari dei patti sono cittadini, apolidi, stranieri, soggetti al potere in qualsiasi nazione (art.2.1 Patto internazionale sui diritti civili e politici) e ciò si desume osservando in maniera speculare l’art 2.3 del Patto sui diritti economici, sociali e civili che stabilisce che solo i paesi in via di sviluppo possono determinare in che misura garantiranno ai non cittadini i diriti economici previsti nel Patto. E di conseguenza quelli sociali e culturali non possono essere limitati. Il principio di non discriminazione viene ulteriormente ribadito all’art.26 del Patto sui diritti civili e politici, con una norma che affermando l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge (in conformità dell’art.7 della Dichiarazione universale), assume una funzione autonoma quando sancisce l’uguaglianza formale dei soggetti, rispetto a ciascun ordinamento giuridico considerato nel suo complesso[26].
Altro principio importante è quello dell’autodeterminazione dei popoli in relazione ad essi stessi, alle proprie ricchezze e risorse naturali ed al rispetto da parte degli Stati sottoscrittori di tali diritti. In merito, forti furono le perplessità manifestate prima del suo inserimento all’art.1 di entrambi i Patti. Ricordiamo quella di Sperduti, rappresentante italiano nella Commissione ONU per i diritti umani, che ne evidenziava la natura politica e la conseguente azione governativa; altri, invece, lo difendevano strenuamente al pari di uno dei più importanti diritti da riconoscere agli uomini.Quanto alle modalità di esecuzione dei Patti, tre indicazioni sono fornite all’art.2.1 del Patto sui diritti economici, secondo cui occorre una realizzazione progressiva dell’esercizio dei diritti, ma commisurata alla disponibilità di risorse economiche e tecniche dello Stato in questione. In relazione al modo, esso viene indicato programmaticamente nelle misure legislative apprestate dagli ordinamenti interni, in quanto da tali Patti innovati, a seconda della natura e dell’oggetto delle singole clausole. L’art.2.1, invine, menziona anche le misure da prendere tramite l’assistenza e la cooperazione internazionale, relativa all’opera prestata dalle organizzazioni internazionali.
Nel Patto sui diritti civili e politici, invece, diversamente si esprime l’art.2.2. Mancano le previsioni circa la progressività d’azione ed i contraenti sono tenuti a compiere i passi necessari, in conformità alle procedure costituzionali, per attuare i diritti sanciti dal Patto. In relazione al tipo delle misure, primo spazio viene riservato a quelle legislative ma in realtà prevalgono le clausole precettive, la cui esecuzione si effettua con mezzi normativi. Diverse sono le clausole programmatiche presenti nel Patto, come all’art.23.1 sulla protezione della famiglia, ed all’art.24.1 su quella dei fanciulli, la cui realizzazione richiede almeno misure di tipo amministrativo.
Per i diritti già riconosciuti negli ordinamenti interni, le misure previste dalle relative clausole perdono significato normativo, ma mantengono la loro funzione di garanzia nell'evenienza mai remota di una loro possibile violazione. Per quanto poi riguarda la natura dei ricorsi, spetta a ciascuno Stato di indicare l'organo competente, visto che il Patto ha solo funzione programmatica ed accessoria – e mai sostitutiva – dei rimedi interni. Altra differenza tra i due Patti sta nel campo di eventuale introduzione di limitazioni.
Se nel Patto sui diritti economici sociali e civili è permesso alle parti di limitare la portata di ciascuna clausola, in relazione alla materia trattata (art.4), nel Patto sui diritti civili e politici invece, ciò è possibile solo ove concesso da specifiche clausole (artt.12-18-19-21-22-25). Affinché ciò si verifichi, è necessario la venuta in evidenza di tre condizioni: 1) i limiti siano fissati con legge, 2) non oltrepassino le misure compatibili con la misura del diritto, 3) rispondano allo scopo di "favorire il benessere di una società democratica". Con l’espressione “misure internazionali di applicazione”, si indicano gli strumenti collettivi mediante i quali, gli Stati che abbiano stipulato accordi multilaterali o le organizzazioni internazionali che abbiano promosso accordi tra i membri, cercano di assicurare l’adempimento degli obblighi assunti da ogni contraente, stabiliti con apposite clausole dagli accordi stessi[27].
Sono riscontrabili tre tipi di misure di applicazione: a) rapporti periodici che i contraenti devono trasmettere sul loro operato, nell'adempimento degli obblighi; il loro esame viene compiuto da un organo già esistente[28] o da uno creato ad hoc, e può comportare delle "raccomandazioni" che invitano lo Stato in questione a svolgere un'azione ulteriore per il rispetto dell'accordo; b) un procedimento per la risoluzione delle controversie, relative all'esecuzione dell'accordo, sorte tra i contraenti, in seguito al quale il reclamante può anche sollecitare in ultima istanza, una decisione giudiziaria e non solo compromissoria; c) con cui, anche se raramente, un apposito organo può ricevere od esaminare comunicazioni o petizioni di individui che si ritengano vittime di violazione degli accordi: in tal caso, l'organo può formulare pareri, raccomandazioni o anche sentenze, in qualità di giudice internazionale. In relazione ad a), questi sistemi di rapporti saranno in tanto più efficaci, in quanto divengano più incisivi ed omogenei in relazione ad elementi oggettivi e soggettivi quali, la forma dei rapporti, la composizione dell'organo cui saranno trasmessi, la possibilità della partecipazione o meno di altri organi al loro esame, la natura ed il risultato dell'esame stesso.
Per quanto invece su b), il procedimento in questione riguarda solo gli Stati che avranno dichiarato di riconoscere la competenze del Comitato dei diritti dell'uomo a ricevere ed esaminare i loro reclami. Esso consta di tre fasi. Una di contatto preliminare, in cui si cerca di far dialogare i due Stati interessati attraverso il reciproco invio di "comunicazioni" sul problema, cui dare risposta entro tre mesi, risolvendo bonariamente la controversia. Una seconda fase in cui il problema viene deferito al Comitato dei diritti dell'uomo (art.28 Patto sui dir. civili e politici parte V) se siano trascorsi invano i primi tre mesi dalla prima comunicazione, più altrettanti, senza che si sia raggiunta una composizione amichevole; il Comitato presterà i suoi buoni uffici chiedendo alle parti ogni opportuna delucidazione, quindi, entro ulteriori sei mesi, dovrà elaborare un rapporto e sottoporlo alle parti: se verrà accettata la soluzione amichevole, il Comitato ne prenderà atto, altrimenti unirà al rapporto le allegazioni scritte dalle parti. Una terza fase del procedimento avviene se la controversia continui ad esistere ad un anno dal suo inizio; in tale fase, il Comitato nomina una Commissione di conciliazione di cinque membri, che partecipano a titolo individuale, scelti dalle parti, se d'accordo, altrimenti dal Comitato stesso, tra i suoi membri.
Entro altri dodici mesi, tale Commissione sottoporrà un rapporto al Presidente del Comitato: se non completano l’esame se ne darà atto, se invece si sia raggiunta una soluzione amichevole, se ne redige un resoconto dettagliato, mentre, se non si addiviene a ciò, tale rapporto conterrà i dati di fatto e le opinioni dei compilatori sulle possibilità di concordato (in tal caso le parti hanno tre mesi dalla notificazione del rapporto per accettare o meno le conclusioni della Commissione).
Questo secondo tipo di misure è risultato essere totalmente innovativo nella disciplina internazionale. Arriviamo quindi all'ipotesi c): è il caso del Protocollo opzionale, aggiunto al Patto sui diritti civili e politici, diretto a realizzare uno strumento auspicato già nel 1962 come probabilmente l'unico in grado di accordare una reale garanzia nell'ambito dei diritti dell'uomo[29], cioè il diritto di petizione, in base al quale un individuo possa ricorrere ad uno strumento internazionale contro la violazione di uno dei diritti pattizi. Tale organo è il Comitato dei diritti dell'uomo che deve verificare l’ammissibilità del ricorso, in base alla sottoscrizione, alla compatibilità con il Patto, all’essenza di parte rispetto al Patto, ma anche al Protocollo, dello Stato colpevole della violazione, di quello sotto la cui giurisdizione si trova il ricorrente ed infine, all’avere già fatto appello a tutti i ricorsi interni disponibili e ragionevoli. Se ritenuta ammissibile, la comunicazione viene portata a conoscenza dello Stato chiamato in causa il quale, entro sei mesi, dovrà fornire spiegazioni scritte o dichiarazioni chiarificatrici che indichino il rimedio adottato.
Alla fine della procedura, il Comitato potrà rivolgere suggerimenti e raccomandazioni allo Stato o all’individuo. La particolarità del sistema è tanto più importante, se si considera l’obbligo di avere esaurito tutti i mezzi di ricorso dell’ordinamento interno, i quali hanno negato il diritto reclamato dal soggetto. Ciò fa comprendere la natura opzionale di questo rimedio cui fa però riscontro un modesto risultato: solo una raccomandazione, anche se in conseguenza di una violazione governativa, a causa della natura non giudiziaria del Comitato.
2. Art.27 Patto sui diritti civili e politici: principi ed applicazioni
Fissati i capisaldi teoretici del problema dei gruppi minoritari, nelle loro pretese legittime di uguaglianza di trattamento nei confronti della maggioranza della popolazione e delle misure legislative speciali che, in aggiunta alle leggi ordinarie, ne garantiscano la protezione, possiamo osservare l’art.27 del Patto sui diritti civili e politici, il quale afferma chiaramente che: “In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze, non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”.
L’evoluzione storica dell’articolo fu decisamente segnata dal succedersi di varie formulazioni: ad esempio il concetto di appartenenza al gruppo fu suggerito per fornire l’idea della totale impossibilità dell’individuo ad essere soggetto di diritto mentre la frase “In quegli stati nei quali esistono…” è stata aggiunta successivamente. Rientrano nella discussione dottrinaria, tutti i problemi, già affrontati, relativi alla corretta definizione del termine “minoranza” ma ricordiamo che è solo nel 1966 che si raggiunse il risultato a lungo atteso: un principio sovranazionale di protezione, onnicomprensivo ed universalmente accettato, in base alla Ris. 220 A (XXI) dell’Assemblea Generale ONU, nella sua 1496^ sessione plenaria del 16 dicembre 1966.
Un simile principio aveva subito in passato, già degli attacchi dalle grandi potenze che non riconoscevano agli organismi internazionali la maturità necessaria per formulare il principio e per la sua garanzia. In tal senso, nel determinare la natura delle obbligazioni imposte agli Stati, fu inserita la menzione “..non possono essere privati”, con la quale gli Stati si impegnavano a non negare od impedire tale uguaglianza di diritto promessa, ma senza concedere il potere ai singoli membri dei gruppi minoritari, di agire personalmente per l’attuazione da parte di uno Stato di tale tutela. In questo modo, però, il meccanismo poteva manifestare delle lacune, perché praticamente solo un effettivo esercizio dei diritti posti dall’art.27 poteva garantire il diritto all’uguaglianza reale e non solo formale[30].
Fu quindi avvertita la necessità di creare misure speciali di garanzia, atte a bilanciare le diseguaglianze in relazione allo status etnico, linguistico o religioso, di un determinato gruppo sociale in un paese e la loro stretta interconnessione con i principi dell’art.27, con quali danno vita a due aspetti dell’unico problema, ovvero quello di assicurare una piena uguaglianza di diritti a tutti i membri della popolazione in quanto collettivamente tali. Più che conferire una situazione privilegiata ad un gruppo rispetto agli altri, bisogna adottare un trattamento speciale, per indirizzare lo Stato in questione a considerare, come membri di un determinato gruppo, i soggetti in situazione di minoranza, attuando così quei provvedimenti richiesti per la protezione dei diritti umani ed il rispetto delle libertà fondamentali. L'enunciazione, poi, di diversi tipi di minoranze etniche, linguistiche o, religiose, non comporta che tali situazioni non possano coesistere, anzi, per esempio, tra la lingua e la cultura c'è una linea di demarcazione molto più sottile di quanto non si pensi, così come tra cultura e religione e per di più, con minori difficoltà d'individuazione, per cui molti aspetti dei diritti relativi alla cultura, concernono anche persone in situazione di minoranza linguistica o religiosa: quindi di tali tre categorie, sebbene considerate separatamente, non si può negare la complementarità, ai fini della disciplina della materia. E tutte queste fattispecie vengono considerate dalla lettera dell’art.27. Cominciando dai diritti alla cultura, osserviamo che quando le minoranze etniche sono uniformemente presenti su determinate aree, hanno migliori possibilità per mantenere e tutelare la loro cultura.
Ovviamente, se ottengono un’autonomia politica in relazione alla loro estesa territorialità, la responsabilità per la politica culturale, a quel punto, ricade su di esse e non più sul governo centrale. Le misure prese a tutela di queste minoranze riguardano il campo letterario, attraverso la pubblicazione e traduzione di libri nella lingua del gruppo, l’assistenza finanziaria per i loro scrittori o l’istituzione di case editrici specifiche; la creazione di enti istituzionali come dipartimenti della cultura, la promozione di ricerche sulla cultura, la lingua e le tradizioni del gruppo in questione; nel campo artistico, la creazione di fondi pubblici di utilità da investire, da parte dei governi, nel settore per la tutela e l’incoraggiamento delle manifestazioni artisiche locali; l’organizzazione di festival per le arti, mostre e compagnie stabili di teatro, danza o altre arti figurative. In questa direzione si è affermata la convinzione che, per rendere efficace una politica culturale, bisogna diversificarla concedendo una grande varietà di opportunità perchè raggiunga una vasta diffusione multidirezionale.
La tendenza principale è di un sistema di diritto che protegga in maniera uniforme tutto il paese: in alcune realtà locali, specie in Asia od Africa, dove l’autonomia politica viene garantita a quelle aree di stanziamento di gruppi minoritari, si sommano ai principi fondamentali dell'autorità statale quelli particolari del diritto privato locale che consentono integrazioni difficilmente controllabili a un sistema più rigido. Sembrerebbe però opportuno che debba essere la politica legislativa statale a regolamentare in assoluto i rapporti relativi a tali gruppi[31].
Altro campo è quello dell’educazione: l’accesso a scuole speciali come anche il diritto di scegliere una qualsiasi scuola, sono elementi chiave per l’attuazione di una corretta politica non discriminatoria nei confronti di tali soggetti. Per le minoranze linguistiche, il problema principale è la selezione di una lingua, all’interno di una società poliglotta, da considerare come ufficiale. È una decisione politica, basata su diversi fattori, come quello numerico, della consistenza di un ceppo linguistico oppure la sua posizione politica od economica all’interno di un paese, l’esistenza ai confini di un tale paese di uno Stato nel quale la lingua ufficiale sia quella che nel paese in questione è considerata minoritaria. Gli approcci proposti sono quattro. Una soluzione è quella di dichiarare nazionali od ufficiali, tutte le lingue parlate dai vari gruppi, come avviene in Svizzera dove, nonostante il 75% della popolazione sia di ceppo germanico, le lingue ufficiali sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre altri ceppi linguistici minori, come il romancio, godono di autonomia locale cantonale. Altra soluzione prevede la limitazione ad alcune soltanto tra le lingue dei vari ceppi, la designazione di ufficiale come avviene in Finlandia per la lingua della minoranza svedese - ma non per quella dei Sami – che è stata aggiunta al finnico come lingua ufficiale[32].
Una terza soluzione è quella di riconoscere alla lingua parlata dalle minoranze, uno status di ufficialità a livello regionale, come nel caso dell’accordo del 1946 tra governo italiano ed austriaco per la risoluzione del problema del bilinguismo in Alto Adige, o tra l’Austria e le minoranze serbo-croate site in Carinzia e Stiria, tra l’Italia e la Francia per le popolazioni valdostane, tra l’Italia e l’ex-Jugoslavia per la parte slovena del territorio di Trieste. Quarto approccio al problema è il caso in cui non venga garantito uno status di ufficialità alla lingua della minoranza ma il diritto al suo utilizzo viene garantito costituzionalmente o da leggi e trattati. Altro problema, considerato dall’art.5 della Convenzione UNESCO del 1960, contro le discriminazioni nel campo dell’educazione, è che l’apprendimento della lingua del ceppo di appartenenza, non deve essere di ostacolo all’apprendimento della lingua parlata dalla comunità nel suo insieme, cosa che porterebbe, diversamente, ad un ulteriore trattamento discriminatorio.
Giungiamo infine alla categoria di minoranze religiose ed i loro diritti di professare liberamente il credo di appartenenza. In ambito ONU, il problema venne sollevato sin dal 1962 con la predisposizione di uno studio in materia da parte della Commissione per i diritti umani[33], completato due anni dopo ed adottato parzialmente dall’Assemblea per poi essere infine ripreso nel 1972 con un laborioso iter di ricerca per pervenire ad uno specifico testo legislativo ovvero una dichiarazione per l’eliminazione di ogni forma di intolleranza religiosa con un relativo Patto. È evidente che, insieme al conseguimento delle libertà fondamentali è necessaria una politica di sussidi tramite i quali lo Stato possa dare materiale assistenza all’attività delle comunità minoritarie. Al momento è solo l’art.27 del Patto a riservare la considerazione dovuta per le comunità che professano un culto non ufficiale, sia che venga loro riconosciuto un particolare status, sia che ciò non rientri nell’ordinamento locale.
È già previsto un eventuale finanziamento per la comunità religiosa da parte dello Stato in cui si trova, sia a vantaggio della comunità che rispetto ai sussidi riconosciuti alla religione di Stato o tramite le tasse che gli appartenenti al gruppo devono versare a beneficio di culti non professati. Altre situazioni di svantaggio per le minoranze religiose sono l’impossibilità di contrarre matrimonio secondo le regole del proprio culto, l’imposizione di feste religiose in disaccordo con il loro culto oppure l’impossibilità di esercitare l’obiezione di coscienza nei riguardi del servizio militare o di prestare giuramento secondo il proprio credo. In tale ottica il disegno di legge per un Patto internazionale per l’eliminazione di tutte le discriminazioni religiose, contiene previsioni circa le libertà suddette ed anche quella di aderire o meno ad una religione o ad un credo, di cambiarla, di manifestarne i principi in pubblico ed in privato, di esprimere pareri in ambito di culti.
Gli Stati, dal canto loro, devono assicurare le libertà in materia di riunione, di disponibilità di posti, di insegnamento di ogni credo e della sua pratica attraverso l’istituzione di organismi assistenziali ed educativi, nonché una protezione legale per tutti i luoghi di culto, di non contrarre giuramento secondo il credo nazionale, e di organizzazione connessa all’esercizio del culto professato. Il 18 dicembre 1992, l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la “Dichiarazione sui diritti delle persone in situazione di minoranza nazionale, etnica, religiosa o linguistica”[34], ove si ribadisce che gli Stati sono tenuti ad incoraggiare la promozione dell’identità delle minoranze e che gli individui appartenenti a tali gruppi minoritari hanno il diritto di partecipare in maniera effettiva alle decisioni prese a livello nazionale e regionale che concernono la minoranza stessa, compatibilmente con l’ordinamento interno.
Le linee guida di come questa discriminazione positiva prende forma, sono enunciati all’art. 4, ove è statuito che lo Stato è tenuto ad adottare misure atte a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizioni della minoranza, a prevedere l’insegnamento anche nella lingua della minoranza ed a promuovere la conoscenza della cultura della minoranza nel resto del paese. Tuttavia, come evidenziato nel corollario della Dichiarazione[35], si è assunto un atteggiamento di cautela per evitare che gli Stati indulgano alle rivendicazioni separatiste e secessioniste di cui è potenzialmente portatrice ogni minoranza, facendo ricorso ad una serie di concessioni che permettano un dispiego di diritti sufficiente a non determinarne l’estinzione, senza dover mettere in discussione i propri confini.
3. Convenzione europea sui diritti umani
Proviamo ad approfondire il discorso sul sistema di garanzie approntato dal Consiglio d’Europa con la Convenzione europea sui diritti umani, siglata a Roma il 4 novembre 1950, e con i Protocolli addizionali, il primo dei quali firmato a Parigi il 20 marzo del 1952 i cui articoli da 1 a 4 sono parte integrante della Convenzione. Il sistema di garanzia che emerge, appare più improntato a quelli civili e politici che a quelli economici, sociali e culturali, già garantiti dalla Carta sociale europea, sancendo così un compromesso tra esigenze sovrane degli Stati ed umanitarie degli individui[36].
Il meccanismo internazionale di controllo creato a garanzia dei diritit umani, è formato da una serie di operazioni: l’individuo od il gruppo che sostenga di essere vittima di una violazione, commessa da uno Stato che abbia riconosciuto ed accettato l’art.25 della Convenzione[37], può inoltrare ricorso alla Commissione europea per i diritti umani che, dopo aver esaminato la ricevibilità del ricorso e affermatane la correttezza procedurale nonché la fondatezza, lo esamina nel merito. L’organo in esame può proporre alle due parti un componimento amichevole della vicenda attraverso un indennizzo forfettario o l’impegno di abolire le misure criticate. Se tali proposte non trovano accoglimento, la Commissione redige e trasmette il suo rapporto alla Corte europea dei diritti umani ma se lo Stato accusato non ne ha accettato previamente la giurisdizione o se il caso non riveste particolare importanza per la Commissione, il rapporto viene allora sottoposto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, organo politico. Ed il risultato del procedimento può essere una sentenza della Corte – di assoluzione o di condanna – oppure una decisione. In caso di condanna, lo Stato può essere tenuto a fornire “un’adeguata soddisfazione” alla vittima della violazione, anche pecuniaria ed il Comitato dei Ministri ha il dovere di sorvegliarne l’ottemperanza. Requisiti per l’ammissibilità del ricorso sono, la sua sottoscrizione, il carattere della novità e l’aver esaurito tutti i rimedi giurisdizionali interni da non più di sei mesi.
Il procedimento si può inoltre svolgere nella lingua del ricorrente e viene garantito, a certe condizioni il diritto al patrocinio gratuito. Come si può notare, è con la Convenzione che si realizza la prima attuazione al diritto di petizione, attraverso cui è il cittadino a ricorrere direttamente contro uno Stato anche straniero, a causa della violazione di un diritto o libertà fondamentale da parte di questo, quasi limitandone la sovranità nazionale, attraverso l’eventuale sua condanna, per mezzo dell'organo giurisdizionale, reale e non limitata a formulare inviti o raccomandazioni allo Stato riconosciuto colpevole.
Il Comitato dei Ministri deve altresì esaminare le misure atte a realizzare gli scopi del Consiglio d’Europa tra cui la salvaguardia e l’ulteriore sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il collegamento tra i poteri statutari del Comitato dei Ministri ed il sistema di garanzie esaminato, si può dedurre dalla possibilità di esercitare questi poteri in seguito all’esercizio del potere di interpellanza, devoluto al Segretario generale del Consiglio d’Europa dall’art.57, per il quale “ogni parte contraente fornirà su domanda del Segretario generale le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l’effettiva applicazione delle disposizioni della Convenzione”.
In relazione alle domande provenienti dagli Stati contraenti, la Commissione ha competenza obbligatoria; facoltativa nel caso di ricorsi individuali, di gruppi non governativi o di privati, che peraltro costituiscono la maggior parte.
Esercita la sua competenza sotto diversi profili: ratione personae, materiae, temporis, loci ed inoltre non si attiene strettamente al petitum, ma esamina se i fatti, anche se sommariamente allegati, possono far dedurre possibili violazioni – pur se non espressamente fatte valere dal ricorrente - senza che ciò costituisca deroga ai rigidi criteri di ammissibilità di cui sopra. Il ruolo della Commissione risulta quindi definito dall’art.19, e consiste nell’assicurare il rispetto degli impegni risultanti dalla Convenzione per le Alte Parti contraenti come necessario tramite tra i ricorrenti e la Corte europea per i diritti umani.
Le parti contraenti hanno voluto conferire carattere facoltativo a quelle clausole della Convenzione che condizionano l’effettivo raggiungimento dello scopo o, a seconda dei casi, il suo migliore raggiungimento: si tratta delle clausole degli articoli 25 e 46 rispettivamente relativi ai ricorsi individuali ed alla giurisdizione della Corte, sottoscritte dalla quasi totalità degli Stati contraenti, in attuazione del principio ispiratore della Convenzione, espresso nel suo art.1, di riconoscimento ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione dei diritti e delle libertà oggetto delle stipulazioni delle parti contraenti, senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, colore od opinione politica, di appartenenza ad una minoranza nazionale, di nascita o altra condizione (art.14), pietra miliare della formazione di un sistema di diritto pubblico europeo. La fattispecie dei diritti economici e sociali viene considerata nel quadro della Carta sociale europea del 1961, entrata in vigore quattro anni più tardi e vincolante vari Stati europei in materia di diritto al lavoro, equità retributiva e di condizione lavorative delle donne e dei fanciulli, diritti sindacali ed alla sicurezza sociale. Si tratta comunque di disposizioni che prevedono vengano prese delle misure di ordine interno, attraverso leggi od altri mezzi appropriati, affinchè sia concessa agli interessati la titolarità dei diritti considerati. Sono i lavori preparatori a chiarire la formula di garanzia espressa dalla Carta sociale, introdotta precipuamente per “escludere ogni possibilità per gli interessati di valersi direttamente delle disposizioni della Carta, davanti alle autorità o giurisdizioni nazionali”[38].
A tale sistema di garanzia partecipano gli organi: lo sbocco del controllo può consistere in una raccomandazione rivolta allo Stato contraente risultato colpevole, adottata dall’organo politico, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, a maggioranza di due terzi, cioè almeno 14 membri. Qui si nota come tale garanzia sia meno incisiva di quella prevista dal meccanismo composto da Commissione e Corte europea, stante la diversa natura dei diritti considerati, che in questo caso necessitano di adozione, da parte degli Stati, di preventive misure sociali di ordine interno. Da ciò deriva la difficoltà di portare a conoscenza degli organi internazionali di controllo, le misure interne che di volta in volta vengono adottate in attuazione alla Carta sociale. Risulta necessaria una distinzione tra norme giuridiche che mirino a stabilire direttive obbligatorie per l’azione governativa in ambito sociale e norme giuridiche comportanti l’effettivo riconoscimento dei diritti in questione. Le prime norme si trovano nella Carta sociale come nel Patto dell’ONU e sono pertanto di diritto internazionale; le seconde, invece, competono alla normativa giuridica interna degli Stati contraenti. Di conseguenza la tutela delle prime è devoluta agli appositi organismi internazionali, mentre spetta alle istanze nazionali dei singoli Stati, che venga rispettato il diritto interno conforme alle prescrizioni internazionali. Bisogna però accertare che queste prescrizioni indicate dagli ordinamenti interni, servono effettivamenti a conferire ai soggetti tutelati uno status internazionale conforme ai diritti previsti dalla Carta sociale europea. Una dottrina sostiene che ciò avvenga e che in sostanza si materializza così un raccordo ideale tra la Carta sociale e la Convenzione europea[39].
Infatti se si considera la garanzia giudiziaria apprestata si deve riconoscere, alle persone sul piano internazionale, il diritto alla buona amministrazione giudiziaria ricompreso all’art.6.1 della Convenzione - quando istituisce un tribunale speciale per la risoluzione delle “controversie sui diritti di carattere civile” - parole che hanno anche nel Patto sui diritti civili e politici ONU all'art.4.1 un ampio significato, in contrapposizione a quello di diritti politici. Ne consegue che l’art.6.1 della Convenzione non si applica solo alle contestazioni fra privati, ma anche qualora venga messa in causa la responsabilità della pubblica autorità.
Analisi del sistema
1. Obiettivi perseguiti dai governi
L'analisi delle misure internazionali di applicazione – in particolare quelle incluse nei Patti e nel Protocollo opzionale – evidenzia le deficienze del sistema a cominciare dai rapporti degli Stati che, oggetto di un esame superficiale, può concludersi con raccomandazioni di ordine generale, non specifico e neanche con segnalazioni di determinati episodi.
La procedura per la risoluzione delle controversie, che si fonda esclusivamente sulla buona volontà degli Stati, può inoltre essere interrotta da una parte prima della nomina della Commissione di conciliazione e non consente il ricorso unilaterale ad organi giudiziari nel caso che l’accordo si riveli impossibile. Il sistema della petizione individuale può essere bloccato da una dichiarazione di inammissibilità da parte dell'organo che la riceve ed in ogni caso, se ammissibile, non dà luogo ad alcun esame sul fatto, nè a valutazioni giuridiche: è infatti previsto che il Comitato per i diritti dell'uomo, che non è organo giurisdizionale, si limiti ad esprimere le sue vedute. Complessivamente si è portati a ritenere il sistema dei rapporti previsti dai due Patti, come uno strumento di informazione più che di controllo: riescono quindi maggiormente utili quelli in materia economica, sociale e culturale, nei quali l’informazione può servire per una azione internazionale di assistenza[40].
Così come era stata l’enunciazione del principio di autodeterminazione dei popoli, contenuto nei Patti agli artt.1, a rivestire il carattere di diritto fin dal 1966. Se ne trova conferma ulteriore in sede europea, nell’Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975 (l’Atto di Helsinki), in cui si ribadisce il diritto di tutti gli Stati a scegliere liberamente la loro forma di Stato, di politica, di governo e di economia. Sempre in materia, ed in ambito ONU, altri atti furono la Dichiarazione per l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati, mentre al di fuori dell'ONU, tale diritto fu considerato anche nella Carta Africana dei diritti dell'uomo (1981) come imprescrittibile ed inalienabile. Si può quindi affermare che l'esistenza di questo diritto per i popoli e la sua natura di vero e proprio diritto, e non soltanto di un principio di ordine generale, sia ormai universalmente accolta nella comunità internazionale[41].
Bisogna però verificare se il diritto all’autodeterminazione appartenga al popolo quando questo costituisce l’unica collettività presente in una organizzazione statuale, oppure alle singole collettività quando più d’una coesistano nell'ambito dello stesso territorio. Nella prima ipotesi, un unico popolo, è noto che non sono sorti particolari contrasti nel riconoscere il diritto all’autodeterminazione ad uno o più popoli “coloniali”; ma, esauritosi il fenomeno, si è visto anche che il contenuto di tale diritto andava ben oltre tale implicazione. Quando si è tentato di applicare tale principio alle spinte nazionalistiche in qualche area, europea o non, è subito sorta la preoccupazione che se autodeterminazione equivale a dare via libera all’autonomia di qualunque nazionalità, ciò avrebbe significato automaticamente il crollo per l'Europa dei confini politici mantenuti in vigore per oltre trent’anni[42].
Le Nazioni Unite dovevano quindi trovare un limite a questo principio, con nuove e convincenti argomentazioni giuridiche: ed infatti nell’ambito della Dichiarazione sui principi delle relazioni amichevoli fra gli Stati, si è introdotto il concetto dell'integrità territoriale, secondo il quale sembrerebbe che il diritto all’autodeterminazione non possa essere riconosciuto ad un popolo, laddove l’esercizio del diritto stesso porti allo smembramento dell’unità territoriale. Ma ciò sarebbe una contraddizione in termini, in quanto non si può limitare il diritto ad un soggetto soltanto sulla base di una mera circostanza di fatto e cioè sull'esistenza nell'ambito territoriale di uno o più di un popolo. Com molta probabilità questo concetto di integrità territoriale ha un significato politico: evita che siano incoraggiati i processi di smembramento o di secessione nell'ambito degli stati. Ma la stessa Dichiarazione contiene anche dei limiti a tal principio, laddove per esempio, si considera legittimo il diritto all’autodeterminazione di un popolo, anche se il suo esercizio dovesse condurre allo smembramento dello Stato, qualora il potere costituito nell'ambito di quel territorio non rispetti i diritti dell’uomo[43].
Nonostante i numerosi esempio di esercisio del diritto di autodeterminazione – come in Congo, Nigeria e Pakistan – da cui si sono scissi altrettanto Stati col placet della comunità internazionale, ci sono altre istante autonomiste contro cui è stato invocato il principio dell’integrità territoriale: a Cipro, dove non si può dar luogo all’autodeterminazione turco-cipriota o nei territori dell’ex-Jugoslavia, ove si riutilizzano termini ormai desueti come balcanizzazione - invitando cautamente ad invitarla – cioè la frammentazione di queste ex unità territoriali in nome di un’integrità non più voluta dal popolo. Ponendosi la questione di perché tutto ciò, è forse possibile e legittimo pensare che gli Stati europei hanno continuato a giudicare della legittimità di un avvenimento solo per finalità politiche ben chiare, come la intangibilità dei confini dei paesi europei o dei paesi sui quali gli europei avevano una particolare influenza o degli interessi economici e/o strategici[44].
In presenza di una politica pluralistica nei confronti dei gruppi etnici o linguistici minoritari, l’istituzione di strutture di governo federalistico per le garanzie autonomistiche di particolari regioni, si sono rivelate efficaci per salvaguardare l’identità culturale ed i diritti fondamentali di tali gruppi. È presupposto fondamentale, l’allocazione geografica in un dato territorio; diversamente nel corso del tempo potrebbe verificarsi uno sbilanciamento rispetto ad altri gruppi minoritari non omogenei, residenti in aree differenti dello stesso paese. In altri paesi la concezione pluralistica è stata completata con misure speciali per la garanzia ai gruppi minoritari dei diritti loro specifici, nell’ambito di un unitario disegno di governo.
L’effetto del corporativismo dei gruppi etnici[45] sul pluralismo etnico non è però chiaro: l’incorporazione di gruppi etnici può avere una notevole varietà di conseguenze, in relazione all’estensione del paese ed alla coesione del gruppo stesso. Nei paesi, poi, in cui i gruppi di minoranza non siano riconosciuti implicitamente od esplicitamente, la politica adottata è normalmente quella dell’assimilazione. Nei paesi in via di sviluppo, a causa della facilmente riscontrabile fragilità di governo, valori fondamentali come unità nazionale e sicurezza dello Stato sono spesso calpestati: in tal caso i caratteri multilinguistici ed etnici vanno valutati di volta in volta, e spesso si è verificato che tali requisiti, apparentemente contrastanti, abbiano guidato molti di questi paesi al riconoscimento dell’integrazione dei gruppi minoritari, quasi a perseguire un preordinato disegno politico.
Capotorti considera che il sistema dell’integrazione non può essere, in nessun caso, imposto ai membri dei gruppi di minoranza, dipendendo dalla loro libera volontà[46]. Infatti, l’esperienza ha mostrato che in una società multirazziale, il modo più efficiente e soprattutto pacifico per edificare una nazione unitaria, consiste nell’adottare una politica di salvaguardia delle tradizioni proprie dei singoli gruppi che lo compongono. Evitare il separatismo e difendere l’integrita dello Stato è l’obiettivo di ogni governo. È un grosso limite per introdurre ogni politica minoritaria ma è il risultato da perseguire per le istanze equalitaristiche dei gruppi minoritari, al fine di registrare una società in grado di garantire unitariamente le specifiche esigenze dei suoi componenti.
2. Il caso dei conflitti nella ex Iugoslavia
La Yugoslavia, Stato federale multinazionale, ha cessato di esistere già prima del 27 aprile 1992, data della proclamazione di una nuova Repubblica federale di Yugoslavia, formata dal Montenegro e dalla Serbia. Si presentava decisamente meno omogeneo rispetto agli altri Stati del continente: fondato su di un sistema composto da tre elementi, sei nazionalità ufficialmente riconosciute cioè croati, macedoni, montenegrini, musulmani, serbi e sloveni e ciascuno formante la base di una Repubblica; dieci gruppi etnici yugoslavi tra i quali occorre ricordare gli albanesi del Kossovo e gli ungheresi della Voivodina; infine le due minoranze austriaca ed ukraina.
Il sistema era quindi precario, considerando che il gruppo più numeroso – i serbi – al censimento del 1981 rappresentava solo il 35% dell’intera popolazione. Completano il quadro le dichiarazioni di indipendenza di Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Macedonia, che hanno generato la frammentazione territoriale che ha condotto alle note tragedie umanitarie. Se la Slovenia non ha creato problemi, complice la sua omogeneità etnoculturale, e la questione macedone si risolta con la cessazione delel rivendicazione greche ad una territorialità estesa, il problema Bosnia e Croazia si manifesterà fino a quando la predominanza serba è stata avvertita, in tutta la Yugoslavia, come una minaccia incombente.
La situazione ante-dissoluzione vedeva il territorio bosniaco controllato al 65% dai serbi, al 30% dai croati ed il rimanente dai musulmani, tanto da costituire una repubblica serba in territorio bosniaco, avversata da un’alleanza costituita da bosniaci e croati, non scevra da contraddizioni e diffidenze reciproche a causa dei timori che tra alleati le legittime aspirazioni di un gruppo nazionale, si tramutavano in egemonia ed accentramento politico. Arrivano quindi le dichiarazioni di principio fatte in occasione della Conferenza di Ginevra sull’ex-Jugoslavia, ma anche le strumentalizzazioni delle minoranze nazionali locali, sia da parte della Serbia che della Croazia. Prova ne è il testo costituzionale della nuova Jugoslavia, ristretta a Serbia e Montenegro, che prevede che il nuovo Stato possa allargarsi a tutte le repubbliche che lo desiderino, incoraggiando le repubbliche secessioniste serbe di Bosnia e Croazia, autoproclamatesi tali, a far valere il loro diritto all’autodeterminazione in vista dell’annessione. Ecco perché ciascuna parte mirasse a consolidare le conquiste territoriali, anche se in danno delle minoranze nazionali contigue, prima del sopravvento del necessario regolamento politico che di lì a poco avrebbe regolamentato gli statuti delle minoranze nazionali del nuovo Stato[47]. La situazione nel Kossovo presentava alta instabilità con un milione di albanesi – il 90% della popolazione – privati del loro statuto autonomo dal 1991 ed occupati dalle più agguerrite milizie serbe impegnate – con difficoltà – a mantenere l’ordine.
Le parti erano in aperta contraddizione su tutti i fronti: i serbi si annettono il Kossovo definendolo parte integrante del loro territorio; gli albanesi, invece, rivendicano il diritto dei popoli all’autodeterminazione dei popoli e resistono all’occupazione serba.Indette poi nuove elezioni nel maggio 1992, si sono dotati di un Parlamento ed un Presidente, elezioni che - prontamente qualificate come illegali dalle autorità serbe - non hanno fatto altro che inasprire il contrasto e che negli albanesi hanno rinfocolato sentimenti irredentisti mai sopiti, votati all'unificazione col Governo centrale di Tirana, per la costituzione di una "grande Albania", dato che più del 50% del ceppo albanese vive al di fuori dei confini del paese, nel Kossovo, in Macedonia e in Montenegro (3,2 milioni contro i 2,5 milioni entro confine)[48]. Una missione della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione Europea ha cercato di smorzare questi sentimenti[49], producendo parallelamente pressioni sulle autorità serbe per la concessione di uno statuto autonomo agli albanesi del Kossovo, ma inutilmente, dato che questi rifiutano il ruolo di cuscinetto tra gli stati serbi; in effetti si può parlare più che di una tensione di gruppo minoritario, della ben più grave situazione di una nazione divisa.
Per risolvere in modo pacifico la questione del Kossovo, ci fu chi avanzò la proposta di separare la controversia in esame dall’insieme dei conflitti allora in atto[50], designando, da parte ONU, un gruppo di personalità serbe e kossovare, che convenissero all’elaborazione di un accordo tra le parti, affiancando tale comitato alle misure già in atto per la ristabilizzazione della pace. Le due delegazioni dovevano ricevere l’approvazione del mediatore ONU nominato dal Segretario generale, incaricato di organizzare gli incontri, come delle rispettive controparti. Ma i problemi da considerare spaziavano dall’educazione alla sanità, dall’economia alla composizione delle discriminazioni in materia di lavoro, sino ai diritti culturali, linguistici, religiosi e comunque etnici senza riguardare minimamente lo Statuto territoriale autonomo, che da parte albanese veniva ovviamente auspicato nonché la delimitazione delle frontiere. Il mediatore doveva istituire una procedure di ricorso presso un ombudsman ed un meccanismo di supervisione sul rispetto degli accordi trattati.
Con questa separazione del problema politico da quello culturale si voleva evitare di giungere necessariamente alla nascita di un nuovo Stato. Si trattava sempre del principio di autodeterminazione, come espresso dall’art.1 dei Patti[51], ma completato dall’autolimitazione in entrambi i sensi: la nazione maggioritaria, che costituisce lo Stato, doveva rinunciare all’interpretazione esclusiva della dottrina della sovranità nazionale se la conduce a ritenersi unica depositaria dell’identità Stato-nazione, escludendo così le aspirazioni autonomistiche degli altri gruppi nazionali; questi ultimi dovevano limitare le rivendicazioni autonomistiche cioè permetterne lo sviluppo e la realizzazione nell’ambito istituzionale dello Stato[52]. In tale ottica, autodeterminazione significava qualsiasi forma di autonomia richiesta dal gruppo, per la preservazione della sua identità nazionale, realizzabile all’interno di un ordinamento democratico: così, ai fini della tutela delle minoranze, si raggruppano tutte le nazionalità presenti in Europa.
3. L’intervento della comunità internazionale
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU con la Ris.713 del 25 settembre 1991 decise l’adozione dell’embargo commerciale sulle armi dirette in Yugoslavia. Successivamente venne istituito, nell’ambito della Sottocommisisone ONU per la lotta contro le discriminazioni e la protezione delle minoranze, un osservatorio per “tastare il polso” alla situazione ed adottare le misure cautelative necessarie. In tale senso, la Sottocommissione, nella 14^ seduta del 13 agosto 1992, ribadì che alla base del suo mandato c’era la protezione dei differenti gruppi etnici e religiosi e che in funzione degli orrori suscitati dalle politiche di pulizia etnica e di esodo forzato di rilevanti parti della popolazione musulmana, nella ex Yugoslavia, esigeva che venissero adottati provvedimenti d’urgenza per porre fine alle massicce violazioni dei diritti garantiti internazionalmente ai popoli, ponendo fine alle politiche ed alle pratiche di pulizia etnica, garantendo il rientro ai luoghi d’origine degli esuli e la loro sicurezza, risarcendo integralmente i danni nonché l’assicurazione alla giustizia dei responsabili dei crimini commessi,a nche tramite misure particolari d’urgenza[53].
Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha risposto proprio a quest’ultima istanza della Sottocommissione, decidendo la creazione di un Tribunale internazionale per perseguire i responsabili diretti ed indiretti delle gravissime violazioni alle convenzioni umanitarie internazionali, commesse nei territori della ex Yugoslavia a partire dal 1991[54], in relazione anche al paragrafo 10 della risoluzione 764 del 13 luglio 1992 in cui si confermava che tutti gli individui colpevoli o mandanti di gravi violazioni delle convenzioni internazionali, ed in particolar modo di quella di Ginevra del 1949, vengono ritenuti responsabili personalmente di dette violazioni. Richiamava inoltre la risoluzione 771 (1992) nella quale veniva imposto a tutte le parti in conflitto di deporre le armi e cessare da ogni violazione delle leggi umanitarie internazionali, la risoluzione 780 (6-10-1992) in cui richiedeva al Segretario generale dell'ONU di istituire come misura d'urgenza un’imparziale commissione di esperti, per esaminare ed analizzare i dati informativi relativi alle citate risoluzioni nonché il rapporto che tale commissione aveva poi elaborato, in cui si confermava che l'istituzione di un Tribunale internazionale ad hoc sarebbe stata coerente con le finalità perseguite dal Consiglio di Sicurezza ONU[55].
Ribadiva, nella stessa risoluzione 808(93), che “la situazione attuale costituisce minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, a causa delle deportazioni di massa ed epurazioni intese come operazioni di pulizia etnica, oltre che dei gravissimi crimini commessi a tal fine, in special modo su moltissime donne musulmane”. Successivamente, la Sottocommissione per la protezione delle minoranze, ribadendo il rigetto unanime per qualsiasi forma di violazione dei diritti umani ed in riferimento agli abbozzi programmatici di un accordo costitutivo per la nascita di un Unione delle Repubbliche di Bosnia ed Erzegovina, nega la validità di qualsiasi accordo, non volto alla cessazione delle ostilità, aprendo la via ad una maggiore stabilità geopolitica, basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite[56].
Viene quindi, nello stesso rapporto, espresso il parere che l’inizio del disarmo delle parti sia il modo migliore per giungere all'elaborazione di un piano di pace, purchè esteso anche alle fazioni non controllate dall'attuale Governo, senza impunità per i responsabili degli eccidi e, a tal fine, viene sollecitato l'impianto del Tribunale internazionale introdotto dalla risoluzione 808(92) del Consiglio di Sicurezza.
4. La richiesta di misure cautelari alla Corte di Giustizia Internazionale
Nella vicenda si innesta il ricorso di Governo di Bosnia presso la Corte di Giustizia Internazionale, organo giurisdizionale sovranazionale, per ottenere l’indicazione di misure cautelari ai sensi dell’art.41 dello Statuto, un giudizio di netta riprovazione nei confronti della nuova Federazione Yugoslava, al fine di dissuadere quest’ultima dal partecipare alla guerra[57].
Nell’atto introduttivo, insolitamente lungo, e dopo aver descritto una numerosa serie di episodi di estrema gravità, la Bosnia chiedeva che la nuova Yugoslavia (Serbia e Montenegro) fosse riconosciuta colpevole di aver violato nei suoi confronti alcune norme internazionali tra le più importanti, oltre alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, il primo Protocollo aggiuntivo del 1977 e le norme consuetudinarie, compreso il regolamento dell’Aja sulla guerra terrestre del 1907, e altri principi fondamentali del diritto umanitario internazionale, molte disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della Carta delle Nazioni Unite.
Inoltre chiedeva che la Corte riconoscesse: il diritto all’autodifesa ai sensi dell'art.51 della Carta e del diritto internazionale consuetudinario; la non applicabilità della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 713(91), che aveva disposto l’embargo sulle armi contro la Yugoslavia e delle successive risoluzioni sullo stesso argomento; la facoltà degli Stati membri delle Nazioni Unite di esercitare in relazione alla Bosnia il diritto all’autodifesa collettiva ai sensi dell'art.51 della Carta. Infine il governo bosniaco chiedeva alla Corte di dichiarare che la Yugoslavia ed i suoi alleati erano tenuti a cessare dal commettere atti in violazione delle predette norme internazionali e condannati a riparare i danni subiti dalla Bosnia. L’atto introduttivo è stato immediatamente seguito dalla richiesta di misure cautelari pendente lite, in gran parte relative alle conclusioni dell’atto introduttivo stesso, e cioè:
- la Yugoslavia "togheter with its agents and surrogates" deve cessare immediatamente da qualsiasi atto di genocidio contro popolo e Stato di Bosnia;
- la Yugoslavia deve cessare altresì di appoggiare ogni nazione, gruppo, organizzazione, movimento, milizia o individuo impegnato o che intenda impegnarsi in attività militari o paramilitari contro popolo, Stato o Governo di Bosnia;
- il Governo bosniaco ha diritto di chiedere e ricevere aiuto (anche militare) da altri Stati per difendersi e, viceversa, ogni Stato ha il diritto di intervenire a difesa "anche armata" della Bosnia.
La procedura sulla richiesta di misure cautelari si è svolta con la maggiore celerità possibile. La Yugoslavia ha scelto di prendervi parte. Le udienze furono fissate per giorni 1 e 2 aprile 1993 e una richiesta di proroga del Governo Yugoslavo venne respinta. Lo stesso Governo, anche se non espressamente autorizzato a farlo, il 1° aprile aveva prodotto delle osservazioni scritte in cui chiedeva venissero adottate misure in parte corrispondenti a quelle suddette, nei confronti delle “authorities controlled by A.Izetbegovic”.
Ricordiamo la prima di queste richieste, in cui si raccomandava alle autorità bosniache di conformarsi strettamente all'allora ultimo accordo sul cessate-il-fuoco, entrato in vigore il 28 marzo 1993. Nel primo argomento avanzato dalla difesa yugoslava, si contestava al Presidente Izetbegovic, la competenza a nominare gli agenti di parte bosniaca e a decidere la proposizione del giudizio avanti alla Corte. Ma la Corte ha constatato che il Presidente bosniaco è riconosciuto dall’ONU come capo legittimo dello Stato e quindi universalmente riconosciuto come il potere di un capo di Stato di agire per conto di esso, in materia di relazioni internazionali[58].
La competenza della Corte a conoscere il merito della controversia (competenza principale), è stata subito oggetto di contestazione, cosa che le ha imposto di prender posizione al riguardo cercando di accertare l’esistenza di una competenza almeno “prima facie”, ma con una formula lievemente innovata rispetto al passato: la Corte infatti annuncia di voler esaminare se sussista tale competenza, alla luce non solo delle disposizioni invocate dalla parte istante, ma anche di quelle “found in the Statute”, come a volersi riservare il potere di indicare d’ufficio, titoli di competenza non indicati dalla parte istante, almeno quando si tratti di disposizioni contenute nello stesso Statuto, autoattribuendosi un’autonomia maggiore dalle richieste di parte. Questa è la prima volta che la Corte si è trovata nella necessità di verificare la propria competenza non solo in termini di “ratione materiae” ma anche “ratione personae”. Quest’ultima competenza è definita dal combinato disposto dell’art.93 della Carta e dell’art.35 dello Statuto, da cui si ricava che hanno legittimazione attiva presso la Corte: a)gli Stati membri delle Nazioni Unite; b) gli Stati non membri ma divenuti parte dello Statuto secondo le condizioni stabilite dall’Assemblea Generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza (art.93 par.2); c)gli Stati non parti dello Statuto, alle condizion prescritte nell’art.35 par.2 dello Statuto.
I dubbi, nella fattispecie, riguardavano la possibilità della partecipazione all’ONU della Yugoslavia, dopo che l’Assemblea Generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, aveva adottato la risoluzione 47/1 del 22 settembre 1992, ove si affermava che la nuova Yugoslavia, non potendo assumere automaticamente la qualità di membro già assunta dall’ex Jugoslavia, doveva presentare una nuova domanda d’ammissione e nelle more, non poteva partecipare ai lavori dell’Assemblea. La questione di competenza è stata risolta, considerando l’adesione del nuovo stato, ad un trattato in vigore come la Convenzione sul genocidio, sufficiente a fondare “prima facie”, la competenza “ratione personae” della Corte, in base all’art.35 par.2 dello Statuto. I dubbi circa la competenza “ratione materiae” riguardavano la Bosnia. Infatti, nell’atto introduttivo del giudizio, la competenza della Corte veniva fondata sulla clausola compromissoria contenuta nell’art.IX della Convenzione sul genocidio. Ma per poter invocare tale titolo di competenza, era necessario che la Bosnia dimostrasse di essere divenuta parte della Convenzione.
La Corte non ha ritenuto necessario esaminare se la notificazione di successione dal Governo bosniaco trasmessa all’ONU fosse realmente tale, conferendo quindi alla Bosnia qualità di parte della Convenzione immediatamente od a partire dalla data della proclamazione di indipendenza. A giudizio della Corte la Bosnia è divenuta parte alla scadenza di un periodo di 90 giorni dalla predetta notificazione; tale termine cadeva dopo l’atto introduttivo, ma prima delle udienze, e ciò, secondo la Corte non costituisce necessariamente un ostacolo all’indicazione di misure cautelari ex art.41 dello Statuto, dal momento che per la Corte vengono in rilievo fatti presenti e futuri e non fatti passati[59]. La competenza “prima facie”, è limitata secondo la Corte ai profili della controversia che riguardano interpretazione ed applicazione della Convenzione; per gli aspetti non coperti dal citato articolo, la Bosnia aveva invocato in una memoria supplementare del 31 marzo 1993, un ulteriore titolo di competenza, tratto da una lettera in cui i presidenti di Serbia e Montenegro demandano proprio al giudizio della Corte le questioni giuridiche derivanti dalla disgregazione dell’ex Yugoslavia in merito alle quali le parti non avessero raggiunto un accordo. Secondo la Bosnia tale lettera, inviata al Presidente della Commissione d’arbitrato istituita dalla conferenza internazionale per la pace in Iugoslavia, in unione alla sua accettazione da parte bosniaca, era sufficiente a fondare la competenza della Corte.
La Yugoslavia, invece, la contestava sia perchè non inserita nell’atto introduttivo, sia perchè non vincolante. Questo documento non è stato accettato come probante la competenza della Corte, perchè dubbio era il significato da attribuirgli, nel senso richiesto dalla Bosnia, producendo come unica conseguenza negativa quella di limitare le misure cautelari ai soli profili della controversia riconducibili alla violazione della Convenzione sul genocidio. Da tutto ciò consegue che il diritto da proteggere attraverso l’indicazione delle misure cautelari è, secondo la Corte, quello che ciascuna parte trae dall’art.1 della Convenzione: il diritto di ottenere che l’altra parte prevenga la commissione di atti di genocidio per l’avvenire. La Corte non deve prendere posizione nè sul se atti di genocidio siano già stati commessi, nè tantomeno sul se la Yugoslavia abbia responsabilità dirette o indirette su tali atti. Nell’ordinanza si deduce la presenza dei presupposti per l’indicazione delle misure cautelari solo dall’accenno che al par.45 la Corte fa al rischio di grave danno al diritto di cui si chiede la provvisoria protezione, e dalla sua imminenza da cui discende l’urgenza dello strumento richiesto. Inoltre la Corte fa riferimento al rischio di un aggravamento o di un’estensione della controversia.
Viene poi sottolineata l’autonomia di valutazione della Corte stessa, in base alla quale possono essere indicate misure diverse da quelle richieste (par.46) ex art.75 par.2 reg.proced.; inoltre la Corte esclude la rilevanza dell’art.VIII della Convenzione, invocato dalla Bosnia (che consente ad ogni Stato membro di invitare gli organi ONU competenti ad assumere le misure di prevenzione o repressione degli atti di genocidio più appropriate), in quanto non amplia i poteri previsti dallo Statuto per la Corte. Sono, infine, state adottate dalla Corte, tre distinte misure, la prima e la seconda dirette alla sola Yugoslavia, mentre la terza ad entrambe le parti: la prima ha contenuto generico e si limita a richiamare la Yugoslavia all’obbligo di prevenire la commissione di crimini di genocidio, senza alcun riferimento agli episodi in corso in Bosnia; la seconda misura è più specifica ed impone alla Yugoslavia di assicurarsi che nessuna unità militare sotto il suo controllo, commetta atti di genocidio, di incitamento pubblico o di cospirazione a commettere genocidio, o di complicità in genocidio contro la popolazione musulmana di Bosnia-Erzegovina, o di qualsiasi altro gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. La terza ed ultima misura, indica ad entrambe le parti di non assumere alcuna iniziativa che possa aggravare o estendere la controversia.
Le decisioni della Corte in questa materia, hanno per natura lo scopo di assicurare la difesa temporanea ed in tempi stretti, dei diritti delle parti, mai in modo definitivo: la Corte si riserva sempre, attraverso apposite clausole, piena libertà di giudizio per le fasi successive del procedimento. L’ordinanza non ha affrontato le questioni più difficili della controversia, soprattutto l’eventuale responsabilità yugoslava sugli atti già commessi in territorio bosniaco; in mancanza di una provvisoria presa di posizione sul tema, anche il contenuto delle misure indicate dalla Corte, rischia di essere troppo generico, e solo una previa qualificazione delle azioni commesse in Bosnia come atti di genocidio avrebbe dato un contenuto concreto all’inibitoria inserita nelle prime due misure indicate, che funzionasse almeno da deterrente contro il possibile ripetersi di tali atroci eventi.
5. Risultati conseguiti
Oltre agli strumenti già considerati precedentemente, esistono numerose convenzioni ed organismi interni che hanno sortito effettivi risultati operativi, spesso in attuazione delle normative internazionali, secondo il principio per cui è lo Stato la variabile che trasforma una o più primigenie comunità in una Nazione, i membri della quale la determinano politicamente e non come parti di un gruppo etnico più o meno importante, ma principalmente da individui provenienti dalle più varie estrazioni però accomunati da criteri oggettivi[60].
Da questo punto di vista sono stati fatti un buon numero di sforzi per organizzare la convivenza di diverse comunità etniche senza arrivare al separatismo od allo smantellamento di uno Stato. Il federalismo, inteso secondo criteri etnici, in Svizzera, India, ex USSR, ex Iugoslavia ed in parte in Canada. Il quasi-federalismo e pseudo-federalismo in Belgio, Spagna (Catalogna), Italia (Trentino Alto Adige e Val d’Aosta), Cecoslovacchia (alternativamente, dopo la II guerra mondiale). Le autonomie regionali o locali come i fiamminghi e valloni in Belgio, i polacchi e russi a Vilnius ed i magiari in Transilvania (la cui esistenza come minoranza etnica è negata dal governo rumeno). Il consociativismo in Belgio, Olanda ed, in minor misura, Austria e Svizzera. La decentralizzazione delle funzioni, in Sri Lanka e quella mista, di funzioni ed autonomie nella Polonia del 16° e 17° secolo per il Consiglio (ebraico) delle Quattro Terre.
La rotazione dei pubblici uffici, come nel caso delle presidenze del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige e dell'assemblea provinciale di Bolzano. La garanzia di una rappresentanza legislativa per minime quote, per i gruppi etnici più rilevanti a Trinidad e nelle Figi. Sistemi legislativi e giurisdizionali multipli, funzionalmente differenziati in Nigeria, Stati Uniti del sudovest, Canada ed Israele. La creazione di commissioni di controllo, come in Austria, presso la Cancelleria federale, per le minoranze (slovene e croate) che si riuniscono periodicamente con lo scopo di influenzare la politica di governo in attuazione dei diritti di tali gruppi, attraverso l’inserimento di loro rappresentanti al governo federale, a quello provinciale e nell’ambito del sistema dei partiti. Altri casi sono rappresentati dal Belgio ove sono costituzionalmente previsti dei Consigli culturali per le comunità francese e fiamminga, che decretano su problemi culturali, linguistici e cooperativi; tali decreti hanno chiaramente efficacia limitata al territorio delle rispettive comunità, ma unitaria nella regione metropolitana bilingue di Bruxelles, in forza della normativa prevista. Possono muovere o ricevere petizioni scritte e devono perseguire la cooperazione tra le due comunità, attraverso un apposito Comitato.
Similmente, in Canada, è stato creato l’ufficio del Commissario delle lingue ufficiali (1969), che annovera tra i suoi doveri quello di attuare ogni misura necessaria ad assicurare il riconoscimento dello status di ognuna delle due lingue, francese ed inglese, nello spirito e con gli intenti dell’Atto istitutivo. In Finlandia il governo ha istituito una Commissione sugli affari lapponi, composta tra gli altri anche da rappresentanti di questa minoranza, la cui funzione è quella di suggerire al Consiglio di Stato le misure da prendere in relazione alla promozione della cultura del gruppo ed alle sue necessità materiali. Con analoghe funzioni esistono, in Svezia un’omonima commissione ed in Norvegia due organi, il Consiglio norvegese sui lapponi - composto da otto membri lapponi, col compito di apprestare raccomandazioni sulle misure relative alla situazione economica, sociale e culturale del gruppo - ed il Comitato di scelta - formato da rappresentanti governativi dei lapponi - per esaminare i problemi dello sviluppo educativo della minoranza. Sempre in Finlandia esiste la Gipsy mission del 1906, creata allo scopo di regolare i rapporti interrazziali tra la minoranza Gipsy ed il resto della popolazione.
Anche in Ungheria opera una commissione apposita con compiti analoghi ai suddetti. In India è previsto dalla Costituzione un Ufficio per le minoranze linguistiche, che cerca di risolvere i problemi relativi alla salvaguardia di tali gruppi, attraverso rapporti periodici, trasmessi direttamente al Presidente e ad ognuna delle Camere del Parlamento. In Nuova Zelanda sono stati creati due uffici governativi per trattare i problemi relativi ai Maori: il Dipartimento degli affari maori e dell’isola, che coordina ed integra la politica statale relativa, ed il Consiglio neozelandese dei maori che, da organo consultivo, esprime pareri su ogni questione riguardante la minoranza. Inoltre col Race Relation Act del 1971, fu creato l’Ufficio del Conciliatore, con poteri investigativi sia autonomi sia basati su istanze relative a qualsiasi atto in violazione alle previste disposizioni antidiscriminatorie, col compito di determinare un accordo tra le parti in questione ed, eventualmente, fornire le assicurazioni contro il ripetersi di tali atti. A Singapore esiste un Consiglio presidenziale per i diritti delle minoranze, razziali e religiose in prevalenza, col compito di riferirne in Parlamento.
Negli Stati Uniti, attraverso il Civil Rights Act del 1957, sono stati istituiti due organi relativi alle problematiche minoritarie: la Commissione sui diritti civili ed il Community Relations Service. I compiti della prima comprendono lo studio degli sviluppi legali e delle politiche federali, in relazione ad un’eguale protezione legislativa in settori come quello dell’educazione e con funzioni informative. Il secondo invece aiuta le comunità a sviluppare piani per il miglioramento delle politiche interrazziali attraverso conferenze, pubblicazioni ed assistenza tecnica. Per ciò che concerne poi le comunità indiane, esistono all'interno del Congresso, ben quattro commissioni specifiche.
6. Ulteriori strumenti da adottare
Il miglior deterrente contro i crimini lesivi di interessi comuni alla generalità degli Stati – i delicta juris gentium – è sicuramente il maggior rischio per l’individuo di essere penalmente perseguito, piuttosto che dalla possibilità di far valere l’eventuale responsabilità statale[61].
Il rischio per l’individuo - privato od organo di Stato - di essere punito, aumento nella misura in cui gli Stati realizzino a tal fine una cooperazione nella repressione penale del crimine, tanto più difficile quanto più il crimine sia collegato con un ambito di sovranità statale, per evidenti ragioni di rispetto della libertà di ciascuno Stato nei rapporti con i propri sudditi. È così che, in relazione al caso classico della pirateria marittima, l’esigenza della repressione a livello internazionale trova facile attuazione attraverso il riconoscimento della facoltà di qualunque Stato di esercitare atti di giurisdizione su pirati anche se la loro nave non ne porti la bandiera, o il fatto sia accaduto in un luogo non soggetto al suo potere giurisdizionale[62]. Si è invece pervenuti a permettere a Stati diversi da quello di appartenenza, la repressione penale di crimini commessi in una sfera di controllo statale, spesso come sistema di governo o di condotta delle ostilità nel corso di un conflitto armato[63].
Inizialmente si è arrivati a ciò solo a fini di tutela del combattente, con la possibilità per gli Stati di perseguire penalmente gli individui responsabili di crimini di guerra, anche se organi dello Stato straniero. Fino al Trattato di Versailles, i giudizi erano limitati al periodo del conflitto, qualora il criminale in questione, membro delle forze armate di una Parte belligerante, si trovasse nelle mani dell’altra. Era il principio della reciprocità che rimetteva le cose in pari, seppure sempre in conformità col diritto internazionale, poiché, in deroga alla norma che lo vieta in via generale, l’esercizio della giurisdizione penale nei confronti di organi stranieri, era in questo caso lecito.
A Versailles, invece, abbandonata la prassi delle amnistie fino ad allora contemplate dai trattati di pace, si fece emergere l’esigenza di assicurare i criminali alla giustizia anche a conflitto ormai concluso, e peraltro, non solo i membri delle forze armate dello Stato vinto, ma anche il più diretto responsabile della stessa guerra di aggressione del 1914, ovvero Guglielmo II. Inoltre, nel Trattato di Sèvres del 1923 tra le potenze alleate e l’Impero ottomano erano contemplati anche i "crimini contro le leggi dell'umanità", in riferimento al genocidio di un milione e mezzo di armeni ad opera delle autorità turche, per la cui repressione la Turchia si impegnava ad estradare i responsabili. È noto che il sistema repressivo pensato in tali trattati fallì anche a causa dei Paesi Bassi che rifiutarono l'estradizione di Guglielmo II e per la mancata ratifica del Trattato di Sèvres, sostituito nel 1927 con quello di Losanna che, per quegli atti di genocidio, prevedeva l’amnistia. Tale fallimento, nonchè l’intento di operare al di fuori della logica dei vincitori che si ergono a giudici di vinti, contribuirono fra le due guerre mondiali, all’emergere dell’idea di istituire una corte penale internazionale, per la quale furono elaborati numerosi progetti, tanto a livello intergovernativo che non governativo[64].
In particolare, nel quadro della Società delle Nazioni, già nel 1937, in aggiunta alla Convenzione contro il terrorismo, firmata da 24 Stati, venne adottato un Protocollo, firmato da 13 Stati, che prevedeva una corte penale internazionale, mai istituita anche a causa delle vicende belliche che impedirono l’entrata in vigore di entrambi gli strumenti. Neanche il sistema creato dopo il secondo conflitto mondiale, ha dato risultati soddisfacenti, nonostante abbiano funzionato tue tribunali definibili internazionali: anzitutto per il sospetto di parzialità che non può non accompagnare una giustizia amministrata dai vincitori nei confronti dei vinti[65], ma anche perchè la giustizia di Norimberga e di Tokio ha raggiunto in verità ben pochi criminali e ha dunque rappresentato un fenomeno marginale di repressione dei crimini di guerra. Fin dal primo operare delle Nazioni Unite, si sono poi tentate vie diverse nel campo della cooperazione interstatale per la repressione dei delicta iuris gentium, vie che peraltro non sembrano aver dato risultati migliori. E' così che nell’elaborazione della Convenzione contro il genocidio ci si è resi subito conto che l’unica via praticabile è quella della competenza preventiva di una corte penale internazionale, contemplata nell’art.VI accanto a quella dello Stato del locus commissi delicti. Nessuno dei progetti per lo statuto di una tale corte, elaborati nel 1947 dal Segretario generale delle NU, ha avuto seguito. Ed era poco probabile che lo Stato territoriale rispettasse l’obbligo di reprimere il crimine, o che qualche altro Stato parte si facesse carico del rispetto di tale Convenzione, facendo valere l’eventuale responsabilità statale davanti alla Corte internazionale di giustizia, sulla base della clausola giurisdizionale prevista dall’art.IX. Lo stesso destino della corte penale internazionale contro il genocidio hanno avuto, tanto il progetto di corte elaborato da un comitato ad hoc delle N.U. del 1953, quanto il progetto del 1981 di quella corte la cui competenza è prevista dalla Convenzione contro l’apartheid del 1973, accanto alla competenza obbligatoria dello Stato territoriale[66].
Una via diversa si era nel frattempo seguita nella Conferenza di Ginevra del 1949 sul diritto applicabile nel corso dei conflitti armati: la previsione di un obbligo di repressione o di estradizione (aut judicare aut dedere) a carico di tutte le Parti contraenti, a prescindere da qualsiasi collegamento con la fattispecie criminosa. È noto che le Parti delle quattro Convenzioni di Ginevra, nonchè dei Protocolli aggiuntivi del 1977, non si mostrarono sollecite a conformare a tale principio i propri ordinamenti[67], con la conseguenza che la repressione penale ad opera degli Stati terzi dei crimini perpetrati in tempi di conflitto armato internazionale ed interno non trova effettiva realizzazione. L’obbligo di adattamento previsto infatti nelle quattro Convenzioni e nei Protocolli, non significa che la repressione o l’estradizione possano direttamente operarsi: è necessario che sia adempiuto tale obbligo con specifici provvedimenti, e non con semplici norme di rinvio, a meno che, naturalmente, l’ordinamento interno non sia già conforme.
Anche in altre Convenzioni che si occupano della prevenzione e della repressione di delicta juris gentium ci si pone nella logica di lasciare agli Stati stessi l’esercizio dell’attività punitiva, provvedendo soltanto ad ampliare l’ambito della giurisdizione penale statale con la previsione di criteri obbligatori in aggiunta a quello territoriale: infatti, secondo le convenzioni che si occupano di prevenire e reprimere la pirateria aeronavale, gli atti diretti contro persone particolarmente protette e le torture, l’obbligo della repressione opera nei confronti dello Stato del locus commissi delicti, ricomprendente la nave o l’aeromobile immatricolati nello Stato, di quello di appartenenza attiva (collegato cioè con l’autore del crimine o con colui che ha noleggiato il mezzo), o passiva (collegato cioè con la vittima del crimine), e, per alcuni crimini, dello Stato leso in un suo interesse particolare (criterio protettivo), nonchè di quello di detenzione, con la libertà di questo Stato di scegliere tra judicare e dedere[68]. In tali convenzioni al criterio di giurisdizione universale ci si è molto avvicinati, essendo stato posto l’obbligo della repressione a carico di tutti gli Stati che concretamente hanno gli strumenti per esercitarla, liberi tutti gli altri di farlo essi stessi sulla base di un eventuale ulteriore criterio di giurisdizione accolto nelle loro legislazioni. Tutti gli Stati parti, hanno assunto un obbligo di accogliere nel loro ordinamento i criteri indicati.
Una scelta più complessa è stata fatta nella Convenzione di Vienna del 1988 per gli atti più gravi legati al traffico illecito di stupefacenti: per tali atti si è seguita la via di porre una competenza obbligatoria sulla base del criterio territoriale e del criterio di detenzione, quest’ultimo però combinato col principio aut dedere aut judicare nel caso di competenza territoriale o personale. Resta peraltro ferma una libertà di repressione secondo qualsiasi altro criterio contemplato dalla legislazione interna. Nonostante l’esistenza di incisivi obblighi in materia repressiva posti a carico degli Stati da questo ampio sistema convenzionale in materia di crimini di guerra, contro l’umanità e contro la pace, rimane fondamentale l’istituzione di una corte penale internazionale che, in modo permanente ed imparziale, curi di reprimere i crimini, tanto del tempo del conflitto armato quanto del tempo di pace, che gli Stati (o i gruppi armati) non vogliano o non siano in grado di reprimere. L’aspetto su cui si è portati a riflettere, è quello dell'opportunità e della possibilità effettiva, se non della legittimità, del funzionamento di una giustizia ad hoc, che venga sostanzialmente imposta da alcuni Stati contro altri Stati o gruppi di insorti[69]. È necessaria una giustizia penale organizzata, a livello internazionale, in modo preventivo, che funzioni in modo permanente, universale ed uniforme dal punto di vista geografico[70], ad opera di chiunque e dovunque i delicta juris gentium vengano commessi, per agire da fattore deterrente contro la possibilità di futuri crimini. Il futuro della corte penale internazionale è principalmente legato ad un’accettazione preventiva della sua competenza[71], non già ad una eventuale accettazione ex post facto, in quanto una scelta di tale ultimo senso, voterebbe l’organo al totale fallimento.
(Altalex, 12 luglio 2012. Articolo di Catello Avenia)
[1] T.H.Bagley, General principles and problems in the International protection of minorities, Populaires, Geneve, 1950
2 Bisogna infatti distinguere tra le tradizionali questioni "minoritarie" e quelle "nazionali" di più recente sviluppo, dato che molti sono i gruppi che negli ultimi decenni si sono riconosciuti una propria coscienza che li vincola alla nazione "madre", ritagliandosi una propria autonomia: per essi il termine minoranza appare riduttivo. Fra le piccole comunità greche e albanesi presenti in Sicilia e Calabria e la popolazione musulmana di Bosnia, o quella turca di Cipro, la differenza non è numerica, ma di fondo. C. Zanghì, Tutela delle minoranze ed autodeterminazione dei popoli, in Riv. Int. dei diritti dell'uomo, n°2, Milano, 1993
[3] Report of the Committee of experts on human rights. 9 novembre 1973, Consiglio d'Europa DH\EXO 73-47
[4] Nei rapporti J.Deschenes (E\CN.4\sub2\1985\31) e A.Eide (E\CN.4\sub2\1992\37) non vengono effettuati cambiamenti radicali rispetto alla dottrina del rapporto F.Capotorti (E\CN.4\sub.2\384\rev.1).
[5] “Per la volontà di salvaguardare la propria identità ed un sentimento di solidarietà”, così come espresso nel Trattato sulle relazioni di buon vicinato, intercorso tra Polonia e Germania il 17 giugno 1991, relativo alla minoranza tedesca in Slesia.
[6] C. Zanghì, op.cit.
[7] M.Toscano, Le minoranze del diritto internazionale, Torino, 1931
[8] H.Witgens, Der volwerrechtliche schutz der nationalem, sprachlichen und religiosen Minderheiten, Stuttgart, 1930
[9] F.Maldestam, La protection dés minorités, Paris, 1923
[10] F.L.Israel, Major peace treaties of modern history, Mc Graw Hill, New York, 1967
[11] H.Witgens, op.cit.
[12] Maldestam, op.cit.
[13] M.Toscano, op.cit.
[14] Actes de la troisiéme Assemblée. Procés verbaux de la sixiéme Commission, Société des Nations, 1922
[15] E.C.Mower, International government, Boston, 1931
[16] A.Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Cedam, Padova, 1988
18 Risoluzione 532 B (VI) 4 febbraio1952
19 A.Cassese, op.cit
[19] Anno della spartizione, ma la vera tragedia si attesta tra il ‘69 e l’87, quando per mano dei gruppi paramilitari della minoranza cattolica e dell'esercito britannico, più di duemila e cinquecento vittime sono cadute nell'ambito di un conflitto che a tratti si riaccende nel modo più aspro, senza alcuna speranza di uno sblocco.
[20] Risoluzione n°573 del 29-7-1974.
[21] A.Sinagra, The Turkish Republic of Northern Cyprus in the international law: proposals for a reasonable solution to the crisis, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1, 1990
[22] ONU, Assemblea generale, Ris.421, V\1950
[23] F.A.Casadio, Patti sui diritti dell’uomo, 1968
[24] F. Capotorti, Patti internazionali sui diritti dell’uomo, Cedam, Padova, 1967
[25] F.Capotorti, Studio sui diritti delle minoranze, ONU, 1991
[26] F.Capotorti, op.cit., 1967
[27] artt.8-16 Convenzione per l'eliminazione del razzismo; artt.19-59 Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo; artt.21-29 Carta sociale europea
[28] Consiglio economico e sociale per il PDESC, Comitato per i diritti dell'uomo del PDCP: il primo per la osservanza degli obblighi, l’altro solo allo scopo di super visione e di stimolo.
[29] G.Sperduti, La tutela internazionale dei diritti dell’uomo, Roma, 1962
[30] F.Capotorti, op.cit., ONU, 1991
[31] Id..
[32] Art.14 costituzione
[33] Assemblea generale ONU, Ris.1781 (XVII) dicembre 1962
[34] I.O.Bokatola, La declaration des Nations Unies sur le droits des personnes appartenant a des minorites nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, in Revue generale de droit international public, tome 97/1993/3
[35] “Nulla in questa dichiarazione può farsi valere come contrario agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica degli stati”.
[36] A.Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Cedam, Padova, pag.88
[37] art.25, competenza facoltativa della Commissione europea dei diritti umani, per i ricorsi contro gli Stati che abbiano dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione in tale materia.
[38] Come disse il Presidente Laroque, nel suo discorso introduttivo, in G.Sperduti, Colloquio sulla Carta sociale europea, SIOI, Roma, 1977
[39] G.Sperduti, op.cit.,1977
[41] F.Capotorti, op.cit., 1967
[42] C.Zanghì, Tutela delle minoranze e autodeterminazione dei popoli, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, Milano, n°2, 1993
[43] C.Zanghì, op.cit.
[44] Id.
[45] Id.
[45] Tale termine viene usato nell’accezione societaria proposta da P.Schmitter, G.Lehmbruck ed altri, in W.Safran, Non separatist policies regarding ethnic minorities, in International Political Science Review, vol.15 n°1, 1994
[46] F.Capotorti, op.cit., ONU, 1991
[47] ONU - Research papers n° 21 - 1993
[48] P.Lendvai, Tensions nationales et menace sur la securitè dans les Balkans, in Politique Etrangere, n.3, 1991
[49] Assemblea parlamentare CSCE, Budapest 5 luglio 1992
[50] E. Chossudovsky, Pour un règlement pacifique au Kosovo, in Le Monde diplomatique, n.471, giugno, 1993
[54] E cioè libertà di scelta, senza alcuna interferenza esterna, nella determinazione delle forme della propria autonomia politica, delle proprie istituzioni e del proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
[55] C. Zanghì, Tutela delle minoranze ed autodeterminazione dei popoli, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 2, 1993
[53] ONU - Commissione per i diritti dell'uomo- lavori della 44^ sessione - relatore M.Bossuyt, Ginevra 3/28 agosto 1992
[54] Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 3175^ riunione, risoluzione 808, 22 febbraio 1993
[55] ONU rapporto S/25274, 1992
[56] ONU - Commissione per i diritti dell'uomo, lavori della 45^ sessione, relatore I.Maxim, Ginevra 2/27 agosto 1993
[57] L. Daniele, La prima ordinanza sulle misure cautelari nell'affare tra Bosnia-Erzegovina e Iugoslavia, in Rivista di Diritto Internazionale, vol. LXXVI, 1993
[58] par.13 dell’ordinanza. La Corte richiama in proposito l'art.7, par.2, lett.a) della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.
[59] Lo stesso orientamento può ricavarsi dalla giurisprudenza che ammette la teoria del forum prorogatum. Starace, La competenza della Corte internazionale di giustizia in materia contenziosa, Napoli, 1970
[60] W. Safran, op.cit.
[61] La quale responsabilità si esprime innanzitutto nell'obbligo per lo Stato (o gruppo) di riparare il torto con la punizione dei propri organi e con altre forme di riparazione, secondo il principio codificato dalla Conferenza dell’Aja del 1907. Anche nel colpire direttamente gli individui si fa peraltro spesso valere una responsabilità dello Stato: e ciò accade quando gli individui siano organi di tale Stato e vengano penalmente perseguiti da altri Stati non più tenuti al rispetto dell'organizzazione straniera, proprio in virtù della riferibilità di un illecito internazionale allo Stato stesso. F. Lattanzi, Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale, Milano, 1983
[62] D. Anzillotti, L'azione internazionale contraria al diritto internazionale, in Riv. di dir. int. e di legislazione comparata, Napoli, 1902
[63] Bierzanek, War crimes: history and definition, in International criminal law, vol.III, Dobbs Ferry, N.Y., 1986
[64] M.C. Bassiouni, The time has come for an International Criminal Court, in Indiana Int. and Comparative Law Review, 1991; MacPherson, An International Criminal Court applying world law to individuals, Washington, aprile 1992
[65] F. Lattanzi, Riflessioni sulla competenza di una corte penale internazionale, in Riv. di Dir. Internazionale, 1993, vol. LXXVI, n.3
[66] United Nations draft convention on the establishment of an international penal tribunal for the suppression and punishment of the crime of apartheid and other international crimes.
[67] Neppure l’ordinamento italiano, che pure contiene già una norma come l’art.7,5°co. del c.p., si è mosso per consentire l’effettiva applicazione da parte dei giudici italiani del criterio universale di giurisdizione per le infrazioni gravi al sistema convenzionale di Ginevra. F.Lattanzi, op.cit., 1993
[68] Convenzione dell'Aja 16 dicembre 1970 sulla repressione della cattura illecita di aeromobili; Convenzione di Montreal 23 settembre 1971 sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, integrata dal Protocollo di Montreal 24 febbraio 1988; Convenzione di New York 14 dicembre 1973 sulla prevenzione e repressione dei reati commessi nei confronti delle persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici; Convenzione di New York 17 dicembre 1979 contro la presa di ostaggi; Convenzione 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti.
[69] Circa la competenza del Consiglio di Sicurezza ONU ad istituire tali tribunali, ampio è stato il dibattito già fin dagli anni ‘50: l’unica eventualità prospettata fu quella di una risoluzione dell' Assemblea generale, ma a tal fine si ritenne essere necessaria una modifica della Carta perchè, si disse, si sarebbe trattato di permettere ad un organo ONU di svolgere funzioni rientranti nella domestic jurisdiction; la modalità istitutiva più adatta sembrò a quel tempo la stipulazione di un accordo internazionale. G. Gaja, Rèflexions sur le role du Conseil de Sècuritè dans le nouvel ordre mondial, in Revue gènèrale de droit int.public, 1993
[70] Contro la comune tendenza propositiva di tribunali preventivi, ma speciali o di tribunali penali misti, composti dai giudici dello Stato territoriale, di quello nazionale dell'accusato e della vittima, nonchè dai giudici di alcuni Stati "neutrali", o quella di tribunali regionali. Conclusions and recommendations of world conference on the establishment of an international criminal tribunal to enforce international criminal law and human rights, Siracusa 2\5 dicembre 1992
[71] F.Lattanzi, op. cit., 1993
estratto da http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=18879
Del concetto di Minoranza
1. Definizioni proposte
2. Il riconoscimento ufficiale delle minoranze da parte dei singoli stati
Evoluzione storica della protezione delle minoranze
1. Fino alla Grande Guerra
2. L'assetto dopo la conferenza di Parigi
3. L’ONU, la dichiarazione universale dei diritti umani ed il Consiglio d’Europa
Attività di protezione
1. Patti internazionali sui diritti dell'uomo
2. Art.27 Patto sui diritti civili e politici: principi ed applicazioni
3. Convenzione europea sui diritti umani
Analisi del sistema
1. Obiettivi perseguiti dai governi
2. Il caso dei conflitti nella ex Iugoslavia
3. L’intervento della comunità internazionale
4. La richiesta di misure cautelari alla Corte di Giustizia Internazionale
5. Risultati conseguiti
6. Ulteriori strumenti da adottare
Bibliografia
Testi e monografie
Atti e Documenti
Del concetto di Minoranza
1. Definizioni proposte
 “Il problema delle minoranze è in realtà una congerie di singoli e specifici problemi ognuno dei quali gravante su un complesso di fattori politici, etnici, economici, sociali e, non ultimo, storici”: con queste parole si presentava, all'inizio degli anni cinquanta, un rappresentante dell'Assemblea generale dell'ONU[1] al fine di trovare una giustificazione alla difficoltà di raggruppare insieme sotto un’unica ed esaustiva definizione tutti i problemi relativi alla moltitudine di gruppi di minoranze, per apprestar loro adeguati sistemi di normative per la protezione dei loro diritti.
“Il problema delle minoranze è in realtà una congerie di singoli e specifici problemi ognuno dei quali gravante su un complesso di fattori politici, etnici, economici, sociali e, non ultimo, storici”: con queste parole si presentava, all'inizio degli anni cinquanta, un rappresentante dell'Assemblea generale dell'ONU[1] al fine di trovare una giustificazione alla difficoltà di raggruppare insieme sotto un’unica ed esaustiva definizione tutti i problemi relativi alla moltitudine di gruppi di minoranze, per apprestar loro adeguati sistemi di normative per la protezione dei loro diritti.Nonostante il tempo trascorse, non è ancora chiara una definizione univoca del termine “minoranza” e le difficoltà dipendono dalle diverse metodologie adottabili per delimitarne il contenuto, sia in termini numerici (ossia il rapporto tra il gruppo di moniranza ed il resto della popolazione) che nella recisa opposizione a tale criterio. Oppure, nell’adottare, quali determinanti, fattori soggettivi di identificazione piuttosto che oggettivi, come la necessità di considerare o meno come minoranze i flussi migratori. La sociologia ci suggerisce l’esistenza di almeno tre correnti di studio delle minoranze: una europea – di matrice storico-giuridica ed etnografica - attiva sulle tradizioni autoctone, contraddistinte dalla lingua, dalle peculiarità nazionali, dalle religioni, che vengono in evidenza quale conseguenza di riordinamenti territoriali nazionali; una nordamericana, impegnata sulle minoranze alloctone, risultato congiunto di migrazione ed urbanizzazione, e che ricorre anche alla psicologia sociale per studiare i problemi razziali; ed infine una terza corrente, tendente a classificare tra le minoranze tutti i poveri, i subordinati, gli emarginati ed i deviati della società.
Con queste basi teoretiche, gli studiosi avanzano, con approssimazioni, verso l’individuazione del significato di concetti più o meno interconnessi, come naizone, popolo, gruppo etnico, minoranza nazionale e gruppi linguistici. È bene sottolineare che simili teorizzazioni, anche se rilevani per l’indagine conoscitiva, sono devianti a livello operativo, specialmente per le diverse qualificazioni che all’interno dei singoli ordinamenti il problema assume, in ragione della diversa importanza riconosciuta ai singoli fattori ed alle relative componenti. Individuare una precisa definizione di minoranza risiede, con molta probabilità, nella necessità di limitare la tendenza espansiva del movimento minoritario, evitando, così, di ricomprendervi anche gruppi fondati su bas inconsistenti. Con il risultato, di non poco peso, di facilitare la sicura applicazione dei trattati. In opposizione a tale tendenza oggettiva, alcuni studiosi considerano che l’appartenere ad una minoranza sia una questione non di fatto ma di volontà, sottolineando quindi implicazioni decisamente soggettive. Diversamente ha statuito la Corte Permanente di Giustizia Internazionale che, in due pronunce (una del 1928 relativa all’interpretazione sul trattato delle minoranze da parte della Polonia ed un’altra del 1930 in occasione della migrazione di comunità greco-bulgare in attuazione della convenzione intercorsa tra i due paesi) affermò che il diritto di reclamare i benefici riservati, dai trattati, alle minoranze, fosse una questione di fanno e non di volontà o di diritto.
Successivamente la Sottocommissione ONU per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione delle minoranze auspicò ,’adozione, da parte della Commissione per i diritti umani, di una risoluzione per la definizione del termine “minoranze” ai fini della loro protezione da parte dell'ONU. In tal senso vennero individuati i fattori da considerare: a) l’esistenza di gruppi riconosciuti come minoranze ed aventi caratteristiche etniche, religiose o linguistiche proprie e differenti da quelle del resto della popolazione, meritevoli di tutela internazionale per la loro conservazione ed il loro sviluppo; b) la circostanza che sebbene minoranza evochi “un minor numero di individui rispetto alla popolazione”, questi possono comunque rappresentare il gruppo dominante per le loro caratteristiche peculiari; c) il non voler interferire con lo sviluppo che spontaneamente si produce in una società posta a diretto contatto con un nuovo ambiente, con ciò che i moderni mezzi di comunicazione comportano, in termini di una rapida evoluzione razziale, sociale, culturale o linguistica; d) il rischio di adottare misure che possano comportare abusi nei confronti di una minoranza; e) il non voler concedere protezione a pratiche incompatibili con i diritti proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti umani; f) le problematiche connesse al riconoscimento dello "status" di minoranza da parte di gruppi così piccoli da poter determinare, se accolte, un carico spropositato per le risorse economiche di quello Stato. Altri elementi da considerare dovevano essere: 1) che il termine minoranza includesse solo i gruppi non dominanti di un popolo, desiderosi di salvaguardare le proprie tradizioni linguistiche, etniche e religiose, qualora segnatamente differenti da quelle del resto della popolazione; 2) che talune minoranze dovrebbero già comprendere in sé un numero sufficiente di membri a proteggere le proprie tradizioni; 3) che tali minoranze debbano essere fedeli allo Stato in cui si trovano.
Il lavoro della Sottocommissione si svolse secondo le direttive ricevute ed il materiale raccolto venne consegnato alla Commissione per i diritti umani; ma le critiche, anche dure, comunque arrivarono. Soprattutto per l’eventualità che il gruppo dominante della popolazione avrebbe potuto giustificare la mancata astensione dell’uguaglianza dei diritti ai gruppi minoritari, qualora fosse mancata in questi la volontà di mantenere la propria individualità. Carattere decisamente soggettivo ma discriminante. Altri, invece, evidenziarono la mancanza, nel disegno proposto, dela circostanza che la minoranza non può includere stranieri residenti nello Stato, od i gruppi formatisi per effetto di ondate migratorie.
Nel 1950 il Segretario Generale ONU, in un memorandum, mise in risalto come il termine “minoranza” possa riferirsi a comunità nazionali o gruppi similari che differiscono da quello predominante nel paese in quanto costituite in un vero e proprio Stato indipendente, già parti di un’unica nazione e poi da esse separatesi, o per essere (o essere stati) dei gruppi locali che non solo riusciti a costituire un grado, seppur minimo, di assimilazione reale con il gruppo dominante. Il Capotorti, relatore speciale della Sottocommissione, sottopose ai pareri dei governi e delle organizzazioni locali, alcune sue notazioni: la rilevanza del fattore soggettivo costituito dal desiderio più o meno espresso dei gruppi minoritari di salvaguardare le proprie tradizioni, il numero dei membri dei singoli gruppi, la possibile costituzione di una società multirazziale e l’applicabilità dei principi enunciati all’art.27 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.
In ragione delle risposte ricevute su tali teorie, la Sottocommissione ha conferito particolare importanza al fattore numerico, non solo in senso assoluto, ma anche in rapporto all’estensione territoriale di stanziamento del gruppo. Pari importanza venne riservata al fattore soggettivo, ovvero il desiderio del gruppo al mantenimento delle tradizioni e presupposto per la costituzione di ogni minoranza in un’entità autonoma, culturale e sociale. Infine, elemento ricognitivo venne considerato il senso di comunità persistente tra i singoli membri del gruppo, oltretutto definito dall’esistenza dei rapporti sociali intercorrenti tra gli individui. L’interpretazione del Capotorti fu considerata troppo estensiva dalla Sottocommissione, nonché inapplicabile a determinati paesi anche per la diversa natura dei problemi gravanti sulle minoranze tribali rispetto ai gruppi viventi all’interno di una società industriale. In tale ottica, i gruppi costituiti da immigrati, od i loro discendenti, non potrebbero essere inclusi nella definizione di “minoranza” poiché di volontaria assimilazione[2].
Si pone, così, la necessità di considerare la differenza tra “minorities by force” (minoranze coatte od involontarie) e “minorities by will” (minoranze volontarie): le prime tendono a far attuare i principi d’eguaglianza nel senso di divieto di trattamenti differenziati, come nel caso di gruppi minoritari contro cui vengono attuate discriminazioni razziali o politiche; le minoranze volontarie, invece, desiderano che cessino le discriminazioni di cui sono bersaglio e chiedono vengano tutelati i caratteri differenziali tra esse e la parte dominante della popolazione. Nel secondo caso, la tutela apprestata non necessita di uniformità di trattamento ma di una disciplina differenziata, come nel caso di minoranze etniche o linguistiche, per le quali un trattamento paritario costituirebbe una vera e propria oppressione delle loro legittime rivendicazioni. Nel 1973 il Consiglio d’Europa ha riferito, nell’ambito della Commissione europea sui diritti umani, di “persons belonging to National minorities” a proposito della questione sollevata dal suo organi governativo, sul contrasto tra l’art.14 della Convenzione, che parla di “national minorities”, e l’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici dell’ONU, che invece riferisce “ethnic, religious or linguistic minorities”, come appunto per differenziare.
Nella susseguente indagine, la Commissione ha osservato, inoltre, che manca il termine “minoranze nazionali” all’interno dei trattati conclusi dalla prima guerra mondiale in poi, e che appare per la prima volta, usato nella Convenzione contro la discriminazione nella educazione, adottata dalla Conferenza Generale dell’Unesco (art.5) nel 1960, anche se in modo tale da non rendere chiara la sua applicazione[3]. Dovrebbero essere qualificati come minoranza nazionale i gruppi che si differenziano tradizionalmente e consapevolmente per i loro caratteri distintivi, dalla maggioranza della popolazione dello Stato in cui stabilmente risiedono, esclusi gli stranieri non inseriti in forma stabile, gli emigrati e tutti i gruppi che aspirano all’assimilazione, ovvero le “minorities by force”.
Una citazione merita il seminario tenutosi ad Ohrid nel 1974 (nell’attuale Repubblica di Macedonia), nel corso del quale, posto l’accento sull’impossibilità di dar vita ad una definizione plurivalente di “minoranza”, venne avanzata una formula: “E’ minoranza un gruppo di cittadini sufficiente per numero a perseguire le aspirazioni della collettività, ma inferiore numericamente al resto della popolaizone, legato insieme da tradizioni storiche, etniche, culturali, religiose o linguistiche e desideroso di conservare integri tali legami, differenti da quelli propri dal gruppo dominante”. Seguiranno altri rapporti ONU[4], ai fini dell’applicazione della tutela dei diritti umani, ma grossi cambiamenti non sono ancora intervenuti. È bene, però, riassumere i due criteri principali fino a ora proposti: uno oggettivo, cioè l’esistenza nell’ambito di uno Stato, di gruppi distinti che ne posseggono la nazionalità e stabili caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono in modo palese da quelle del resto della popolazione, rispetto cui è in una relazione di non dominanza ed inferiore di numero; l’altro soggettivo, ovvero il desiderio dei membri dei gruppi in questione, si tutelare i caratteri peculiari, il quale desiderio, se si assumesse che debba preesistere all’applicazione dell’art.27, può far temere che lo Stato approfitti della sua assenza per giustificare il proprio rifiuto alla protezione dell’individualità del gruppo. Il desiderio emerge dall’esercizio continuato, da parte di quel gruppo, nelle sue tradizioni[5]: e questo, se considerato complementare al criterio oggettivo, già contribuisce a definire in modo esauriente il concetto di “minoranza”.
2. Il riconoscimento ufficiale delle minoranze da parte dei singoli stati
I comportamenti assunti dagli Stati nei riguardi delle minoranze, hanno assunto spesso toni di antiteticità: sal riconoscimento della loro esistenza riportato in una Carta costituzionale, alla mancanza di una qualsiasi forma di tutela giuridica. E tra questi estremi vi sono, spesso, numerose posizioni intermedie, come legislazioni speciali, specifiche misure amministrative od il semplice riconoscimento di organizzazioni private che rappresentino gli interessi di questi gruppi minori. Ma anche il termine “riconoscimento”, assume diversi significati, potendo indicare lo status di persona giuridica, una serie coordinata di diritti miranti a garantire i membri di alcune comunità(in base ai principi di protezione dell’identità minoritaria).
Nella maggior parte dei casi, l’unica misura utile è la garanzia di alcuni diritti specifici, senza il ricorso ad una sovraposizione organica ed in questo caso il riconoscimento della minoranza deriva dal fatto stesso della tutela – anche se parziale – apprestata. La difficoltà di ottenere un significato unitario del concetto di minoranza influisce direttamente sulla protezione internazionale, anche se elementi sufficienti a dimostrare la sua esistenza, consentirebbe l’applicazione delle regole internazionali, a cominciare dall’art.27 del Patto sui diritti civili e politici. Il problema così presentato, può esser considerato da due punti di vista: secondo il senso del concetto giuridico di riconoscimento ufficiale di determinati gruppi della popolazione, ed attraverso l’esame del procedimento logico secondo cui si mette in relazione un singolo individuo ad un gruppo, al momento di applicare il particolare status che lo riguarda. Tutto è però complicato non solo dal diverso approccio da tenere in relazione a Stati diversi, ma anche a causa delle diversità che si possono manifestare nell'ambito dello stesso paese, per le diverse caratteristiche che rivestono i singoli gruppi.
Vi sono poi casi in cui lo Stato, anche ammettendo l’esistenza di un gruppo minoritario all’interno della sua popolazione, mette in campo misure rigide nei confronti proprio dei suoi membri, come nel caso del Regno Unito quando ribadisce l’inesistenza di procedure ufficiali di riconoscimento di una minoranza, al fine di salvaguardare i diritti che le sono propri e sempre fino a quando tale minoranza non necessiti un riconoscimento ufficiale per la sua sopravvivenza. All’opposto, molti sono i paesi ove si è proceduto ad un riconoscimento ufficiale di determinati gruppi etnico-linguistici come minoranze, per concedere una diversità di trattamento, in relazione alle loro esigenze. Ed alcuni di questi paesi, hanno provveduto ad inserire, il diritto di riconoscimento, nel loro sistema normativo, come risulta da trattati internazionali o da accordi bilaterali, nell’ambito dei quali, i gruppi vengono qualificati come “minoranze nazionali”, “nationalities”, “cultural communities” o molto semplicemente, come avviene i Svizzera, come gruppi linguistici.
In molti Stati, poi, le leggi ed i regolamenti interni riguardano l’uso delle lingue dei vari gruppi linguistici, se questi non siano stati ufficialmente riconosciuti come minoranze. Quattro, dunque, sono le categorie di soluzioni adottate: 1) il riconoscimento costituzionale dell'esistenza di gruppi distinti e del diritto dei loro membri a godere di un regime speciale, soprattutto di tutela dello sviluppo collettivo; 2) il riconoscimento di determinate minoranze e la loro salvaguardia, sulla base di strumenti giuridici internazionali ad hoc; 3) il riconoscimento implicito, attuato attraverso leggi e regolamenti concernenti lo sviluppo della cultura di determinati gruppi linguistici; 4) non riconoscimento di minoranze nel sistema di diritto locale, dovuto ad atteggiamenti politici di totale rifiuto della loro esistenza, o ad esigenze di neutralità, comportanti misure privatistiche di tutela.
Le prime due soluzioni, sono decisamente ottimali, per riscontrare ordinati sistemi di tutela diretta. Ma se l’esistenza di una minoranza è obiettivamente dimostrabile all’interno di uno Stato, quest’ultimo non è dispensato dall’applicare l’art.27. Questo è facilmente realizzabile se leggi locali o regolamenti vengono adottati, anche senza un riconoscimento a livello costituzionale. Con l’espansione della democrazia, e delle sue garanzia, è possibile risolvere il problema tramite misure di diritto interno; con il diritto internazionale si può supportare ed indirizzare la normativa interna, tendendo a realizzare un diritto comune delle minoranze, fondato sui principi di libertà ed uguaglianza[6].
Evoluzione storica della protezione delle minoranze
1. Fino alla Grande Guerra
Pochi sono gli Stati in Europa che non prevedono un riconoscimento costituzionale dell’esistenza delle minoranze ed una tutela del principio di uguaglianza tra i cittadini nei confronti di qualsiasi discriminazione. Ma sono nel 1966, si avrà l’enunciazione di un principio internazionalmente accettato, ovvero l’art.27 del Patto sui diritti civili e politici. Il processo per arrivare a tale risultato, ha origini molto lontane ed una comune base: tutte le principali religioni si richiamano al principio di fratellanza, al di sopra di ogni distinzione di razza, colore o linguaggio; inoltre sono state proprio le persecuzioni religiose a costituire le prime occasione di ricerca di questi valori fondamentali di fratellanza universale. Bisogna tenere distinte le minoranze religiose da quelle nazionali anche al fine di evidenziare la sproporzione tra i due tipi, ed in relazione al tempo, distinguere il periodo che ha inizio dalla Riforma protestante - che ha originato le minoranze di fede - fino alla Rivoluzione francese - che ha invece sottolineato il principio della nazionalità - da quello che arriva dal congresso di Berlino del 1878 ed a tutte le convenzioni che precedettero lo scoppio del primo conflitto mondiale[7].
Punto di partenza sono i trattati di Passau ed Augsburg (rispettivamente del 1552 e del 1555) che rappresentano un tentativo di applicare la protezione della libertà di culto, sotto l'imperatore Carlo V[8]. Segue l’editto di Nantes del 1598, promulgato da Enrico IV, limitato alle minoranze religiose, regolando in maniera più completa il libero esercizio della fede protestante, ed istituendo dei tribunali speciali. Inoltre, la Capitolazione concertata in Milano il 3-9-1639 in nome di S.M. Cesarea e Cattolica, tra il conte di Daun e gli ambasciatori Grigioni quanto a religione, governo ed altri particolari spettanti ai contadi di Bormio e Chiavenna in Valtellina, che agli artt. 26 e 27 garantiva di fare osservare la religione cattolica apostolica romana con esclusione di ogni altra. Con i trattati di Westfalia del 1648 si fece, però, un notevole passo a ritroso: la libertà religiosa è accordata solo ai Prìncipi, mentre per il popolo vale il detto “cuius regio, eius religio”, da cui l’esigenza di norme per regolare la migrazione di quei sudditi fedeli al culto, entro due anni dalla data del trattato. Il primo trattato di pace, modificativo di tale ordine, fu quello di Oliva del 1660[9] che stabiliva fra l’altro, il libero esercizio della religione cattolica ai residenti del territorio di Livonia, ceduto dalla Polonia alla Svezia.
Analogamente il trattato di Nimega del 1678 tra Francia ed Olanda, garantì libertà di culto cattolico alla minoranza di fede residente nel territorio di Maastricht, ceduto dalla Francia all'Olanda[10]. Pari principio fu sancito fra le stesse parti nell’accordo di Ryswick del 1697, per la restituzione di altri territori, i cui abitanti poterono continuare a professare la propria fede. Nel trattato di Utrecht del 1713, con cui la Francia cedette all’Inghilterra la baia di Hudson e l’Acadia, si ebbe un rinvio alla legislazione interna inglese, accordando protezione ai sudditi solo se non in contrasto con l’ordine pubblico; si concedette inoltre agli abitanti dei luoghi ceduti una parvenza di opzione della cittadinanza, esercitabile entro un anno dalla data del trattato.
Analogo a questo, il trattato di Parigi del 1763, a cui parteciparono anche Spagna e Portogallo per ciò che riguardava il trasferimento dei francesi del Canada e degli spagnoli delle isole Grénade in altri territori, in rispetto del loro culto cattolico romano[11]. Prossimi alla Rivoluzione francese sono i trattati di Breslau (1742), Dresda (1745) e Varsavia (1772), tutti inerenti il libero esercizio del culto esercitato dalla popolazione del territorio ove era avvenuto un mutamento dell’autorità secolare.
Dalle disposizioni citate non si comprende se tale libertà venne poi realmente rispettata e tutelata anzi bisogna osservare che, quando l’evoluzione dei diritti civili dell’individuo pervase le coscienze delle classi più progredite, venne meno l’esigenza di tale tutela, ormai radicata. Infatti dopo la Rivoluzione francese (1789), rinveniamo il trattato di Vienna del 1815 concluso tra Austria e Regno d’Olanda (frutto dell’unificazione tra Belgio e Paesi Bassi), recante speciali garanzie in favore della minoranza cattolica belga, per il libero credo religioso e l’ammissione ai pubblici uffici. In contemporanea, nel Protocollo finale del Congresso di Vienna, si riservò ampio spazio al problema della salvaguardia delle minoranze nazionali, intesa come principio di autodeterminazione politica dei paesi firmatari (Austria, Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Prussia, Svezia) avviando il riconoscimento e la garanzia dei diritti di una nazione: art.1"...les Polonais, sujects respectifs de la Russie de l'Autriche et de la Prusse, obtiedront une representation et des institutions nationales, reglées d'aprées le mode d'existance que chacun des gouvernements aux quels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder"[12].
Il protocollo non chiarisce quali fossero i diritti nazionali da garantire: alcuni autori propendono per i diritti politici, altri fanno riferimento all'identità culturale delle minoranze considerate. Nel trattato di Parigi del 1856, tra Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Regno di Sardegna e Turchia, l'art.IX riporta una comunicazione tra il Sultano turco e gli altri contraenti, a proposito della legislazione da lui introdotta per il riconoscimento di un trattamento egualitario anche per i cristiani ivi abitanti, senza discriminazione alcuna. Il trattato di Berlino del 1878, rafforzò l’ideale antidiscriminatorio in materia di culto all’interno dei paesi Balcani; così pure la convenzione internazionale di Costantinopoli vergata nel 1881 in relazione all'uguaglianza ed al libero esercizio della propria religione, per i musulmani residenti nei territori annessi alla Grecia.
In questi ultimi trattati, nessun diritto riguardò mai le minoranze di lingua, tranne il protocollo finale del Congresso di Vienna, che sancì la libertà di usare il polacco nel territorio di Poznan, unitamente al tedesco.
Quanto ai diritti delle minoranze etniche, invece, il Congresso di Berlino stabilì all'art.4 del trattato che, nei paesi in cui i bulgari convivevano con altre popolazioni, i diritti e gli interessi di tutti, sarebbero stati presi nella considerazione loro attribuita dal disegno di legge in questione. Il sistema di protezione delle minoranze fino ad ora esaminato, basato su speciali trattati multilaterali garantiti dalle potenze, fu condannato al fallimento dall’inadeguatezza degli scopi, dalla vaghezza delle sue formulazione previsionali, dalla rudimentale natura della sua organizzazione materiale e, non ultimo, dall’indeterminatezza e mancanza di effettività delle sanzioni da esso previste, spesso suscettibili di facili e prevedibili abusi[13].
È innegabile il ruolo rivestito, nel corso del XX secolo, dalla Società delle Nazioni, organizzazione internazionale voluta dalle grandi potenze vincitrici della prima guerra mondiale ed istituita il 28 aprile del 1919 nell’ambito della Conferenza di pace di Parigi, entrata poi in vigore nel gennaio dell’anno successivo. Woodrow Wilson, presidente statunitense, ottenne l’incusione nel trattato istitutivo di una clausola in base alla quale i nuovi Stati, come condizione per il riconoscimento della loro indipendenza, si impegnavano a garantire uguaglianza di trattamento nei confronti delle loro minoranze nazionali o razziali, di fatto o di diritto. Lo stesso Wilson estese, successivamente, tale clausola anche ai paesi che avessero aderito, nel tempo, alla Società.
Gli Stati Uniti non presero parte al consesso di Stati, nonostante il ruolo importante svolto dal loro presidente né ratificarono il patto, originariamente concluso da 13 paesi che, nel momento di massima partecipazione, registratosi nel 1934, divennero 58. La Società visse vicende alterne fino a conoscere la sua estinzione nel 1946. Il suo fine principale era il mantenere la pace e la sicurezza internazionale ed a tal fine era preordinato l’mpegno dei suoi Stati-membri di risolvere, tramite arbitrato o sottoponendo all’esame del Consiglio o dell’Assemblea, le controversie che potevano sorgere tra essi. E poi c’era l’impegno di non ricorrere alla guerra, se non dopo almeno tre mesi dal lodo o dal rapporto emesso dagli organi cui si erano rivolti. Come vietata era la guerra nei confronti del paese che in buona fede avesse attuato le disposizioni derivanti dal ricorso agli organi della Società e comunque, se mirante ad annessioni od a conquiste territoriali.
Il sistema sanzionatorio non era abbastanza efficace e molte disposizioni della Società furono disattese. Gli organi principali erano l’Assemblea dei rappresentanti degli Stati-membri, il Consiglio (formato da rappresentanti permanenti delle grandi potenze cioè Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, URSS e da un certo numero di membri temporanei, che variarono dai 4 iniziali agli 11 sul finire), quindi il Segretario, organo esecutivo e di collegamento tra gli altri due. Istituti internazionali collegati erano, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che aveva il compito di elaborare convenzioni e raccomandazioni in materia, e la Corte permanente di Giustizia internazionale, col compito di risolvere le controversie attraverso il ricorso all'arbitrato. La differenza tra la Corte ed il Consiglio, per la loro attività consultiva, stava nel fatto che la prima poteva essere investita di una questione da parte, sia degli Stati firmatari, sia dei membri del Consiglio. Uno dei motivi principali dello scontento che generò la Società fu certamente il fatto che gli Stati minoritari, fin dal giorno in cui furono invitati a firmare i trattati per la protezione delle minoranze, protestarono contro quella che definirono una diminuzione della loro sovranità, derivante dal divario esistente tra essi e le grandi potenze. Proprio contro questa disparità di trattamento, si concentrarono numerosi interventi in sede assembleare ed in uno di questi, nel 1922, il prof. Murray, tra le altre proposte, chiese che gli Stati non firmatari osservassero almeno lo stesso grado di tolleranza e giustizia che scaturiva dai trattati.
La situazione di allora era tale che alcuni paesi erano tra di essi legati da trattati speciali, altri da semplici promesse non vincolanti, altri ancora, del tutto liberi da ogni impegno; e non c’era paese in Europa che non avesse gruppi minoritari[14]. La proposta fu accolta dall’Assemblea, ma come invito affinché che tali paesi non firmatari si attenessero alla sostanza dei trattati in argomento, invece di un più pressante invito a sottoscrivere una convenzione generale; rimedio che in più occasioni suscitò le obiezioni di molti paesi, tra cui Italia, Belgio, Inghilterra, Francia. L’obiettivo di perseguire la protezione dei membri delle minoranze fu ottenuta imponendo agli Stati un comportamento standard rispetto al divieto di ogni discrinazione razziale, linguistica o religiosa. Furono inoltre adottate misure tendenti a salvaguardare l’identità nazionale ed i valori propri dei singoli gruppi conto il pericolo di un loro smarrimento causato dalle intercorse mutazioni territoriali.
Nulla era richiesto alle minoranze come contropartita, in cambio di tali strumenti e di ciò ne è prova la Risoluzione della Società del 21 settembre 1922, in cui si dichiara che, oltre al riconoscimento del diritto principale delle minoranze ad essere protette contro ogni forma di oppressione, è ben evidenziato il dovere dei membri di tali gruppi di cooperare come sudditi fedeli della nazione dalla quale dipendono. Nonostante il fallimento, la Società costituì il più importante centro di elaborazione della politica internazionale nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, e di coordimento in caso di cooperazione tra gli Stati-membr.
Doveva inoltre servire a garantire l’assetto territoriale stabilito dalla Conferenza di pace del 1919, ovvero un allargamento dei territori di Serbia, Romania e Grecia e la definizione dei confini di Polonia e Cecoslovacchia, assetto che aveva prodotto una notevole quantità di gruppi che per tradizioni e cultura, oltre che per lingua e religione, si trovavano in situazione di minoranza, che doveva essere tutelata attraverso la stipula di cinque trattati speciali, denominati Trattati minoritari, tra le grandi potenze alleate e quelle firmatarie, a riguardo dei territori summenzionati. In tal modo - si disse[15]- il numero delle minoranze etniche fosse diminuito sensibilmente, dai 50 milioni iniziali a meno di 20 milioni, per mezzo di strategie politiche non sempre soddisfacenti nei risultati, dando oltre tutto inizio a quelle frizioni politiche che di lì a poco sarebbero sfociate nel secondo conflitto.
3. L’ONU, la dichiarazione universale dei diritti umani ed il Consiglio d’Europa
Il sistema della Società delle Nazioni, ormai esaurito nella sua efficacia, fu sostituito, alla fine del secondo conflitto mondiale, dalla proclamazione dei diritti umani fondamentali espressa nella Carta delle Nazioni Unite del 1945. La Carta, oltre a sancire il rispetto dei diritti umani e la realizzazione dell’autodeterminazione dei popoli, affidava ad una serie di organi, il compito di agire in tali settori e l’organo più importante è sicuramente l’Assemblea generale, composta dai delegati dei 159 Stati-membri, divisa in commissioni, a loro volta esecutive anche tramite sottocommissioni. Ai fini della presente riflessione, sono rilevanti la Commissione per i diritti umani, collegata al Consiglio economico e sociale, - organo governativo dell’ONU, composto da 54 delegati – ed è ad essa subordinata la Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze - composta da 26 esperti che agiscono a titolo individuale, anche se eletti dai singoli Stati in seno alla Commissione. Altro organo in dipendenza dall’Assemblea è il Centro per i diritti umani, un segretariato con funzione propagandistica.
Nella Carta troviamo espressi, all’art.1, gli scopo di cooperazione internazionale per la promozione e l’incoraggiamento al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di tutti i popoli, senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione. All’art.56 si raccomanda a tutti gli stati membri di prestare la propria azione, per cooperare al raggiungimento dei fini precedentemente stabiliti, poi ribaditi agli artt. 13 e 55. Tali principi antidiscriminatori costituiscono quindi un cambiamento radicale, se paragonati agli intenti delle passate esperienze, che si limitavano a stabilire misure speciali volte a regolare casi specifici nel contesto di questi nuovi ed universali intenti protezionistici. Anche nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948, non fu fatto riferimento alcuno a specifici diritti di soggetti in condizione di minoranza etnica, linguistica o religiosa e molti considerarono tale mancanza una riduzione degli scopi della Dichiarazione, mentre i più decisero che, data l’estrema complessità dell’argomento, sarebbero serviti tempo, spazio e studi ulteriori. Non trovò accoglimento una proposta dell’ex-URSS di introdurre una clausola che nominasse le minoranze nazionali, i cui diritti andavano garanditi ma l’Assemblea, con Ris. 217 C (III) del 1948, stabilì che le Nazioni Unite non potevano restare indifferenti alle sorti delle minoranze anche se evidenziò la difficoltà di concordare una soluzione equilibrata.
Altri importaiti testi normativi furono la Convenzione sul Genocidio, del 1948, ed i Patti sui diritti umani del 1966, divisi in due parti, sui diritti civili e politici con annesso Protocollo facoltativo, e sui diritti economici, sociali e culturali, con i quali si addiviene alla prima formulazione di norma universalmente volta a garantire i diritti degli individui in situazione di minoranza e, come tale, universalmente accettata. Nel 1965 vede la luce la Convenzione contro la discriminazione razziale (la più ratificata, con 124 Paesi firmatari), la Convenzione contro orgni forma di tortura (1984), e molti altri ancora, seguendo sempre un duplice approccio sul piano normativo[16]: testi generali come la Dichiarazione, i Patti e le risoluzioni sul diritto di autodeterminazione dei popoli; e testi specifici come ad esempio il genocidio, la libertà di informazione, i diritti della donna, la schiavitù, il matrimonio, il razzismo, i detenuti e così via. Risolutiva, a proposito dell’autodeterminazione dei popoli, è stata l’azione dell’ONU che tra il 1950 ed il 975 ha promosso l’indipendenza politica di tutte quelle popolazioni ancora soggette al dominio coloniale.È giusto sottolineare che, in ambito assembleare, tutte le discussioni aventi per oggetto la protezione delle minoranze, vennero considerate da un punto di vista socio-culturale ed umanitario piuttosto che politico, come invece avveniva nell’Assemblea delle Società delle Nazioni. Il problema venne affrontato dall’Assemblea nel 1952[17], statuendo che la prevenzione delle discriminazioni e la protezione delle minoranze erano da considerare come due tra le branche più importanti del lavoro dell’ONU. Volendo rintracciare qualcosa di non positivo nell’azione dell’ONU in materia di garanzia internazionale del rispetto dei diritti umani, lo si rinverrebbe nell’efficacia, non sempre puntuale, dell’azione stessa. Infatti tutti i trattati, fino ad ora menzionati, contengono strumenti di controllo ma la loro attuazione è spesso devoluta agli Stati membri: sono previste due procedure, ben distinte, promuovibili a seguito di comunicazioni di individui o di gruppi a relativi a “gravi e massicce violazioni dei diritti umani”.
La prima (del 1967) ha carattere pubblico, la seconda (del 1970) ha carattere confidenziale ed entrambe possono comportare motivo di inchiesta della Commissione per i diritti umani, se lo Stato interessato accetta il potere oppure la formulazione di un rapporto sulle violazioni constatate. Se valutiamo che dietro la Commissione vi sono gli Stati che si rendono colpevoli delle violazioni, si comprendono le forti limitazioni con le quali l’ONU deve operare, vista l’estrema eterogeneità dei paesi membri, in fatto di regime politico ed economico.
Diversamente dall’Assemblea Generale ONU, il Consiglio d’Europa è un’organizzazione intergovernativa, nata da un’idea di Winston Churchill del 1943 e concepito quale istituzione internazionale, volta ad unire e rafforzare, politicamente, ma anche sul piano ideale e culturale, i paesi democratici dell’Europa occidentale ed a promuovere il rispetto dei diritti umani[18]. Nel 1948, al congresso dell’Aja si dovette scegliere tra un modello inglese, con un’Europa fontata sulla operazione interministeriale dei vari Stati, ed un modello franco-belga, con un’integrazione da attuarsi tramite la creazione di un Parlamento.
Il trattato istitutivo fu quindi un compromesso, coesistendo accanto ad un organo intergovernativo – il Comitato dei Ministri – un organo collegiale – l’Assemblea consultiva – con deputati eletti dai Parlamenti nazionali, ma senza poteri decisionali. Nel preambolo del trattato, viene espresso "il forte vincolo ai valori spirituali e morali dei popoli che lo compongono, che sono all'origine dei principi di libertà individuale e politica ed al principio di supremazia del diritto, valori sui quali si fonda ogni democrazia". Frutto dell’elaborazione dell’Assemblea consultiva del 1949, fu un importantissimo trattato internazionale: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, concepita nel segno della protezione dei diritti civili e politici, mentre i diritti economici e sociali vengono tutelati dalla più recente Carta sociale europea del 1961. In questo modo sono garantiti il diritto alla vita, la proibizione della tortura, della schiavitù, delle pene inumane e degradanti, il divieto di ricorrere retroattivamente alla legislazione penale, il diritto alla corretta amministrazione giudiziaria, il rispetto della privacy del domicilio e della corrispondenza, le libertà di pensiero, coscienza e religione, opinione ed espressione, di riunione, di matrimonio e della costituzione di un nucleo familiare, i diritti a libere elezioni, a riunirsi in partiti e sindacati ed a scegliere l’istruzione per i propri figli.
Le norme relative ai diritti economici e sociali, non conferiscono ai destinatari una soggettività giuridica, ma vengono considerate come princìpi cui informare l’attività legislativa dai singoli Stati. Per ciò che concerne le minoranze, la Convenzione costituì un notevole progresso rispetto alla Dichiarazione universale dell'ONU, in quanto, a differenza di questa, menziona in forma chiara il termine “minoranze nazionali” e contiene disposizioni che prevedono sistemi di controllo e garanzia, nel caso di violazione dei diritti tutelati. In pratica, tale menzione costituisce una formulazione positiva ed esplicita dei singoli diritti riconosciuti, mentre nella Convenzione ONU, all’art.27, si enunciano delle premesse cui non possono essere negati gli stessi diritti, solo che questo si può soltanto desumere implicitamente.
Gli orani previsti nella Convenzione europea sono la Commissione europea dei diritti dell’uomo, composta da tanti membri quante sono le parti contraenti ed a cui può ricorrere ogni parte se un altro Stato non abbia assicurato, nella sua giurisdizione, i diritti e le libertà previste, od anche qualsiasi individuo od organizzazione non governativa, a patto che lo Stato contro cui è diretta la petizione abbia dichiarato di riconoscere tale particolare competenza. Viene poi la Corte europea dei diritti dell’uomo, cui possono ricorrere le parti contraenti e la Commissione stessa se questa non sia riuscita a dirimere la controversia ma a patto che le parti interessate abbiano riconosciuto tale giurisdizione obbligatoria. Nonostante la complessità del sistema, in alcuni casi gli Stati hanno apportato modifiche alla legislazione nazionale sulla base delle critiche degli organi di controllo, mentre in altri casi l’incapacità d’intervento degli organi stessi ha creato situazioni di tensione, come avvenne nel 1921 in Irlanda del Nord[19], nei Paesi baschi e nel luglio 1974 a Cipro, dove in virtù dell’art 4 di un Trattato intercorso il 16 agosto del 1960 tra i governi di Turchia, Grecia ed Inghilterra, l’intervento dell’esercito turco, legittimato a livello internazionale dal Consiglio d'Europa[20], pose un argine alle sofferenze in cui versava la comunità turco-cipriota[21].
Attività di protezione
1. Patti internazionali sui diritti dell'uomo
A questo punto, osserviamo gli strumenti di recente fattura e di rilevante importanza, a cominciare dai Patti sui diritti umani del 1966, frutto di una intensa e lunga stagione dibattimentale della Commissione ONU per i diritti dell'uomo, iniziata nel 1947 sulla base dell'incarico affidatole dal Consiglio economico e sociale: formulare proposte per una dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo e circa i mezzi necessari ad affermarne il rispetto. Si avvertì subito la necessità di redigere, insieme alla dichiarazione, un progetto di convenzione che definisse i singoli diritti ed i limiti posti al loro esercizio, in connessione con un certo numero di misure di applicazione. Apparve però impossibile definire contemporaneamente alla dichiarazione, un progetto di convenzione che chiarisse i singoli diritti ed i limiti posti al loro esercizio, in connessione con un certo numero di misure di applicazione. Da cui la decisione di concentrare gli sforzi sul progetto di dichiarazione che vide la luce nel dicembre 1948, rimandando a numerose sessioni della Commissione il lavoro rimasto.
Ricordiamo, l’inserimento dei diriti economici, sociali e culturali seguiti da quelli civili e politici – già considerati[22]- e la divisione in due Patti (nel 1952), introducendo però in entrambi, un articolo sul diritto di autodeterminazione dei popoli. Nonostante la contrapposizione in blocchi delle grandi potenze, l’Assemblea portò a termine il lungo dibattito, complice l’approvazione nel 1965 della Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, comprese una serie di misure di applicazione. In proposito, va sottolineato come gli organismi internazionali attivi nel campo economico e sociale, ponendo in essere progetti specifici di attività, siano stati indotti ad astrarre taluni principi di base relativi ai diritti dell’uomo, dalle linee generali dell’azione pratica che verso gli anni ’60 aveva ad oggetto la condizione umana. In secondo luogo, l’applicazione pratica di misure tendenti a risolvere problemi di carattere economicoe sociale, ha decisamente contribuito ad indicare quali dovessero essere le condizioni necessarie all’attuazione dei singoli diritti, e quindi non solo venne enunciato il diritto ma anche elencate le condizioni, premesse per l’attuazione del diritto in questione[23].
Osserviamo allora, i vantaggi e gli svantaggi del dualismo di due Patti al posto di uno solo. Il carattere programmatico dei diritti economici, sociali e culturali che comportano un’azione positiva dello Stato, è sicuramente diverso dal carattere precettivo dei diritti civili e politici, la cui natura assoluta presuppone l’astensione dello Stato da ingerenze in una sfera individualmente tutelata[24]. Infatti per garantire il godimento dei primi, ogni Stato svolge un’azione di concreto intervento, con misure amministrative nonché tecniche graduali; mentre per godere dei diritti civili e politici, bastano le norme presenti nell’ordinamento, compreso il ricorso al giudice, in caso di loro violazione. Tali confini non sono sempre netti, e quindi si dovrebbe sostenere che l’immediatezza e la gradualità nella realizzazione dipendono dalle strutture economiche preesistenti, politiche e sociali, invece che dalla pura natura dei singoli diritti[25].
Molti sono gli aspetti comuni tra i due Patti, dalla strutturazione al contenuto di alcune clausole. Entrambi si aprono con un preambolo e continuano con l’enunciazione del principio di autodeterminazione dei popoli (art.1). Le parti seconda, terza e quarta regolano rispettivamente, le misure di applicazione interna, i singoli diritti e le misure di applicazione internazionale, mentre la parte quinta del Patto sui diritti civili e politici si compone di due articoli che nell'altro Patto sono stranamente inseriti nella parte quarta. In entrambi l'ultima parte è formata dalle clausole finali d'uso comprendenti firme, ratifiche, adesioni ed emendamenti. Il Protocollo opzionale, annesso al Patto sui diritti civili e politici, contiene due gruppi di disposizioni: le competenze del Comitato per i diritti dell'uomo a ricevere od esaminare comunicazioni individuali, e per ultime, le clausole finali. Oltre l’esame dei singoli articoli, è bene considerarne il contenuto evidenziando da subito che i diritti enunciati nei Patti sono ugualmente assicurati a tutti gli individui e si riferiscono ad ogni persona. Il rafforzamento di tale principio di uguaglianza degli individui nel godimento o nell’esercizio di tali diritti, proviene dalle clausole di non discriminazione, poste all’art.2 dei Patti, con una duplice funzione: implicare che gli obblighi assunti dai contraenti in virtù delle norme materiali dei Patti debbano eseguirsi senza discriminare tra i beneficiari e dar vita ad un elenco delle più diffuse cause di discriminazione.
Nelle convenzioni del 1964-’65 erano previste misure atte a prevenire il fenomeno; nei Patti, invece, l’eliminazione delle discriminazioni è strumentale rispetto alla realizzazione dei vari diritti tuelati. I beneficiari dei patti sono cittadini, apolidi, stranieri, soggetti al potere in qualsiasi nazione (art.2.1 Patto internazionale sui diritti civili e politici) e ciò si desume osservando in maniera speculare l’art 2.3 del Patto sui diritti economici, sociali e civili che stabilisce che solo i paesi in via di sviluppo possono determinare in che misura garantiranno ai non cittadini i diriti economici previsti nel Patto. E di conseguenza quelli sociali e culturali non possono essere limitati. Il principio di non discriminazione viene ulteriormente ribadito all’art.26 del Patto sui diritti civili e politici, con una norma che affermando l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge (in conformità dell’art.7 della Dichiarazione universale), assume una funzione autonoma quando sancisce l’uguaglianza formale dei soggetti, rispetto a ciascun ordinamento giuridico considerato nel suo complesso[26].
Altro principio importante è quello dell’autodeterminazione dei popoli in relazione ad essi stessi, alle proprie ricchezze e risorse naturali ed al rispetto da parte degli Stati sottoscrittori di tali diritti. In merito, forti furono le perplessità manifestate prima del suo inserimento all’art.1 di entrambi i Patti. Ricordiamo quella di Sperduti, rappresentante italiano nella Commissione ONU per i diritti umani, che ne evidenziava la natura politica e la conseguente azione governativa; altri, invece, lo difendevano strenuamente al pari di uno dei più importanti diritti da riconoscere agli uomini.Quanto alle modalità di esecuzione dei Patti, tre indicazioni sono fornite all’art.2.1 del Patto sui diritti economici, secondo cui occorre una realizzazione progressiva dell’esercizio dei diritti, ma commisurata alla disponibilità di risorse economiche e tecniche dello Stato in questione. In relazione al modo, esso viene indicato programmaticamente nelle misure legislative apprestate dagli ordinamenti interni, in quanto da tali Patti innovati, a seconda della natura e dell’oggetto delle singole clausole. L’art.2.1, invine, menziona anche le misure da prendere tramite l’assistenza e la cooperazione internazionale, relativa all’opera prestata dalle organizzazioni internazionali.
Nel Patto sui diritti civili e politici, invece, diversamente si esprime l’art.2.2. Mancano le previsioni circa la progressività d’azione ed i contraenti sono tenuti a compiere i passi necessari, in conformità alle procedure costituzionali, per attuare i diritti sanciti dal Patto. In relazione al tipo delle misure, primo spazio viene riservato a quelle legislative ma in realtà prevalgono le clausole precettive, la cui esecuzione si effettua con mezzi normativi. Diverse sono le clausole programmatiche presenti nel Patto, come all’art.23.1 sulla protezione della famiglia, ed all’art.24.1 su quella dei fanciulli, la cui realizzazione richiede almeno misure di tipo amministrativo.
Per i diritti già riconosciuti negli ordinamenti interni, le misure previste dalle relative clausole perdono significato normativo, ma mantengono la loro funzione di garanzia nell'evenienza mai remota di una loro possibile violazione. Per quanto poi riguarda la natura dei ricorsi, spetta a ciascuno Stato di indicare l'organo competente, visto che il Patto ha solo funzione programmatica ed accessoria – e mai sostitutiva – dei rimedi interni. Altra differenza tra i due Patti sta nel campo di eventuale introduzione di limitazioni.
Se nel Patto sui diritti economici sociali e civili è permesso alle parti di limitare la portata di ciascuna clausola, in relazione alla materia trattata (art.4), nel Patto sui diritti civili e politici invece, ciò è possibile solo ove concesso da specifiche clausole (artt.12-18-19-21-22-25). Affinché ciò si verifichi, è necessario la venuta in evidenza di tre condizioni: 1) i limiti siano fissati con legge, 2) non oltrepassino le misure compatibili con la misura del diritto, 3) rispondano allo scopo di "favorire il benessere di una società democratica". Con l’espressione “misure internazionali di applicazione”, si indicano gli strumenti collettivi mediante i quali, gli Stati che abbiano stipulato accordi multilaterali o le organizzazioni internazionali che abbiano promosso accordi tra i membri, cercano di assicurare l’adempimento degli obblighi assunti da ogni contraente, stabiliti con apposite clausole dagli accordi stessi[27].
Sono riscontrabili tre tipi di misure di applicazione: a) rapporti periodici che i contraenti devono trasmettere sul loro operato, nell'adempimento degli obblighi; il loro esame viene compiuto da un organo già esistente[28] o da uno creato ad hoc, e può comportare delle "raccomandazioni" che invitano lo Stato in questione a svolgere un'azione ulteriore per il rispetto dell'accordo; b) un procedimento per la risoluzione delle controversie, relative all'esecuzione dell'accordo, sorte tra i contraenti, in seguito al quale il reclamante può anche sollecitare in ultima istanza, una decisione giudiziaria e non solo compromissoria; c) con cui, anche se raramente, un apposito organo può ricevere od esaminare comunicazioni o petizioni di individui che si ritengano vittime di violazione degli accordi: in tal caso, l'organo può formulare pareri, raccomandazioni o anche sentenze, in qualità di giudice internazionale. In relazione ad a), questi sistemi di rapporti saranno in tanto più efficaci, in quanto divengano più incisivi ed omogenei in relazione ad elementi oggettivi e soggettivi quali, la forma dei rapporti, la composizione dell'organo cui saranno trasmessi, la possibilità della partecipazione o meno di altri organi al loro esame, la natura ed il risultato dell'esame stesso.
Per quanto invece su b), il procedimento in questione riguarda solo gli Stati che avranno dichiarato di riconoscere la competenze del Comitato dei diritti dell'uomo a ricevere ed esaminare i loro reclami. Esso consta di tre fasi. Una di contatto preliminare, in cui si cerca di far dialogare i due Stati interessati attraverso il reciproco invio di "comunicazioni" sul problema, cui dare risposta entro tre mesi, risolvendo bonariamente la controversia. Una seconda fase in cui il problema viene deferito al Comitato dei diritti dell'uomo (art.28 Patto sui dir. civili e politici parte V) se siano trascorsi invano i primi tre mesi dalla prima comunicazione, più altrettanti, senza che si sia raggiunta una composizione amichevole; il Comitato presterà i suoi buoni uffici chiedendo alle parti ogni opportuna delucidazione, quindi, entro ulteriori sei mesi, dovrà elaborare un rapporto e sottoporlo alle parti: se verrà accettata la soluzione amichevole, il Comitato ne prenderà atto, altrimenti unirà al rapporto le allegazioni scritte dalle parti. Una terza fase del procedimento avviene se la controversia continui ad esistere ad un anno dal suo inizio; in tale fase, il Comitato nomina una Commissione di conciliazione di cinque membri, che partecipano a titolo individuale, scelti dalle parti, se d'accordo, altrimenti dal Comitato stesso, tra i suoi membri.
Entro altri dodici mesi, tale Commissione sottoporrà un rapporto al Presidente del Comitato: se non completano l’esame se ne darà atto, se invece si sia raggiunta una soluzione amichevole, se ne redige un resoconto dettagliato, mentre, se non si addiviene a ciò, tale rapporto conterrà i dati di fatto e le opinioni dei compilatori sulle possibilità di concordato (in tal caso le parti hanno tre mesi dalla notificazione del rapporto per accettare o meno le conclusioni della Commissione).
Questo secondo tipo di misure è risultato essere totalmente innovativo nella disciplina internazionale. Arriviamo quindi all'ipotesi c): è il caso del Protocollo opzionale, aggiunto al Patto sui diritti civili e politici, diretto a realizzare uno strumento auspicato già nel 1962 come probabilmente l'unico in grado di accordare una reale garanzia nell'ambito dei diritti dell'uomo[29], cioè il diritto di petizione, in base al quale un individuo possa ricorrere ad uno strumento internazionale contro la violazione di uno dei diritti pattizi. Tale organo è il Comitato dei diritti dell'uomo che deve verificare l’ammissibilità del ricorso, in base alla sottoscrizione, alla compatibilità con il Patto, all’essenza di parte rispetto al Patto, ma anche al Protocollo, dello Stato colpevole della violazione, di quello sotto la cui giurisdizione si trova il ricorrente ed infine, all’avere già fatto appello a tutti i ricorsi interni disponibili e ragionevoli. Se ritenuta ammissibile, la comunicazione viene portata a conoscenza dello Stato chiamato in causa il quale, entro sei mesi, dovrà fornire spiegazioni scritte o dichiarazioni chiarificatrici che indichino il rimedio adottato.
Alla fine della procedura, il Comitato potrà rivolgere suggerimenti e raccomandazioni allo Stato o all’individuo. La particolarità del sistema è tanto più importante, se si considera l’obbligo di avere esaurito tutti i mezzi di ricorso dell’ordinamento interno, i quali hanno negato il diritto reclamato dal soggetto. Ciò fa comprendere la natura opzionale di questo rimedio cui fa però riscontro un modesto risultato: solo una raccomandazione, anche se in conseguenza di una violazione governativa, a causa della natura non giudiziaria del Comitato.
2. Art.27 Patto sui diritti civili e politici: principi ed applicazioni
Fissati i capisaldi teoretici del problema dei gruppi minoritari, nelle loro pretese legittime di uguaglianza di trattamento nei confronti della maggioranza della popolazione e delle misure legislative speciali che, in aggiunta alle leggi ordinarie, ne garantiscano la protezione, possiamo osservare l’art.27 del Patto sui diritti civili e politici, il quale afferma chiaramente che: “In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze, non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”.
L’evoluzione storica dell’articolo fu decisamente segnata dal succedersi di varie formulazioni: ad esempio il concetto di appartenenza al gruppo fu suggerito per fornire l’idea della totale impossibilità dell’individuo ad essere soggetto di diritto mentre la frase “In quegli stati nei quali esistono…” è stata aggiunta successivamente. Rientrano nella discussione dottrinaria, tutti i problemi, già affrontati, relativi alla corretta definizione del termine “minoranza” ma ricordiamo che è solo nel 1966 che si raggiunse il risultato a lungo atteso: un principio sovranazionale di protezione, onnicomprensivo ed universalmente accettato, in base alla Ris. 220 A (XXI) dell’Assemblea Generale ONU, nella sua 1496^ sessione plenaria del 16 dicembre 1966.
Un simile principio aveva subito in passato, già degli attacchi dalle grandi potenze che non riconoscevano agli organismi internazionali la maturità necessaria per formulare il principio e per la sua garanzia. In tal senso, nel determinare la natura delle obbligazioni imposte agli Stati, fu inserita la menzione “..non possono essere privati”, con la quale gli Stati si impegnavano a non negare od impedire tale uguaglianza di diritto promessa, ma senza concedere il potere ai singoli membri dei gruppi minoritari, di agire personalmente per l’attuazione da parte di uno Stato di tale tutela. In questo modo, però, il meccanismo poteva manifestare delle lacune, perché praticamente solo un effettivo esercizio dei diritti posti dall’art.27 poteva garantire il diritto all’uguaglianza reale e non solo formale[30].
Fu quindi avvertita la necessità di creare misure speciali di garanzia, atte a bilanciare le diseguaglianze in relazione allo status etnico, linguistico o religioso, di un determinato gruppo sociale in un paese e la loro stretta interconnessione con i principi dell’art.27, con quali danno vita a due aspetti dell’unico problema, ovvero quello di assicurare una piena uguaglianza di diritti a tutti i membri della popolazione in quanto collettivamente tali. Più che conferire una situazione privilegiata ad un gruppo rispetto agli altri, bisogna adottare un trattamento speciale, per indirizzare lo Stato in questione a considerare, come membri di un determinato gruppo, i soggetti in situazione di minoranza, attuando così quei provvedimenti richiesti per la protezione dei diritti umani ed il rispetto delle libertà fondamentali. L'enunciazione, poi, di diversi tipi di minoranze etniche, linguistiche o, religiose, non comporta che tali situazioni non possano coesistere, anzi, per esempio, tra la lingua e la cultura c'è una linea di demarcazione molto più sottile di quanto non si pensi, così come tra cultura e religione e per di più, con minori difficoltà d'individuazione, per cui molti aspetti dei diritti relativi alla cultura, concernono anche persone in situazione di minoranza linguistica o religiosa: quindi di tali tre categorie, sebbene considerate separatamente, non si può negare la complementarità, ai fini della disciplina della materia. E tutte queste fattispecie vengono considerate dalla lettera dell’art.27. Cominciando dai diritti alla cultura, osserviamo che quando le minoranze etniche sono uniformemente presenti su determinate aree, hanno migliori possibilità per mantenere e tutelare la loro cultura.
Ovviamente, se ottengono un’autonomia politica in relazione alla loro estesa territorialità, la responsabilità per la politica culturale, a quel punto, ricade su di esse e non più sul governo centrale. Le misure prese a tutela di queste minoranze riguardano il campo letterario, attraverso la pubblicazione e traduzione di libri nella lingua del gruppo, l’assistenza finanziaria per i loro scrittori o l’istituzione di case editrici specifiche; la creazione di enti istituzionali come dipartimenti della cultura, la promozione di ricerche sulla cultura, la lingua e le tradizioni del gruppo in questione; nel campo artistico, la creazione di fondi pubblici di utilità da investire, da parte dei governi, nel settore per la tutela e l’incoraggiamento delle manifestazioni artisiche locali; l’organizzazione di festival per le arti, mostre e compagnie stabili di teatro, danza o altre arti figurative. In questa direzione si è affermata la convinzione che, per rendere efficace una politica culturale, bisogna diversificarla concedendo una grande varietà di opportunità perchè raggiunga una vasta diffusione multidirezionale.
La tendenza principale è di un sistema di diritto che protegga in maniera uniforme tutto il paese: in alcune realtà locali, specie in Asia od Africa, dove l’autonomia politica viene garantita a quelle aree di stanziamento di gruppi minoritari, si sommano ai principi fondamentali dell'autorità statale quelli particolari del diritto privato locale che consentono integrazioni difficilmente controllabili a un sistema più rigido. Sembrerebbe però opportuno che debba essere la politica legislativa statale a regolamentare in assoluto i rapporti relativi a tali gruppi[31].
Altro campo è quello dell’educazione: l’accesso a scuole speciali come anche il diritto di scegliere una qualsiasi scuola, sono elementi chiave per l’attuazione di una corretta politica non discriminatoria nei confronti di tali soggetti. Per le minoranze linguistiche, il problema principale è la selezione di una lingua, all’interno di una società poliglotta, da considerare come ufficiale. È una decisione politica, basata su diversi fattori, come quello numerico, della consistenza di un ceppo linguistico oppure la sua posizione politica od economica all’interno di un paese, l’esistenza ai confini di un tale paese di uno Stato nel quale la lingua ufficiale sia quella che nel paese in questione è considerata minoritaria. Gli approcci proposti sono quattro. Una soluzione è quella di dichiarare nazionali od ufficiali, tutte le lingue parlate dai vari gruppi, come avviene in Svizzera dove, nonostante il 75% della popolazione sia di ceppo germanico, le lingue ufficiali sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre altri ceppi linguistici minori, come il romancio, godono di autonomia locale cantonale. Altra soluzione prevede la limitazione ad alcune soltanto tra le lingue dei vari ceppi, la designazione di ufficiale come avviene in Finlandia per la lingua della minoranza svedese - ma non per quella dei Sami – che è stata aggiunta al finnico come lingua ufficiale[32].
Una terza soluzione è quella di riconoscere alla lingua parlata dalle minoranze, uno status di ufficialità a livello regionale, come nel caso dell’accordo del 1946 tra governo italiano ed austriaco per la risoluzione del problema del bilinguismo in Alto Adige, o tra l’Austria e le minoranze serbo-croate site in Carinzia e Stiria, tra l’Italia e la Francia per le popolazioni valdostane, tra l’Italia e l’ex-Jugoslavia per la parte slovena del territorio di Trieste. Quarto approccio al problema è il caso in cui non venga garantito uno status di ufficialità alla lingua della minoranza ma il diritto al suo utilizzo viene garantito costituzionalmente o da leggi e trattati. Altro problema, considerato dall’art.5 della Convenzione UNESCO del 1960, contro le discriminazioni nel campo dell’educazione, è che l’apprendimento della lingua del ceppo di appartenenza, non deve essere di ostacolo all’apprendimento della lingua parlata dalla comunità nel suo insieme, cosa che porterebbe, diversamente, ad un ulteriore trattamento discriminatorio.
Giungiamo infine alla categoria di minoranze religiose ed i loro diritti di professare liberamente il credo di appartenenza. In ambito ONU, il problema venne sollevato sin dal 1962 con la predisposizione di uno studio in materia da parte della Commissione per i diritti umani[33], completato due anni dopo ed adottato parzialmente dall’Assemblea per poi essere infine ripreso nel 1972 con un laborioso iter di ricerca per pervenire ad uno specifico testo legislativo ovvero una dichiarazione per l’eliminazione di ogni forma di intolleranza religiosa con un relativo Patto. È evidente che, insieme al conseguimento delle libertà fondamentali è necessaria una politica di sussidi tramite i quali lo Stato possa dare materiale assistenza all’attività delle comunità minoritarie. Al momento è solo l’art.27 del Patto a riservare la considerazione dovuta per le comunità che professano un culto non ufficiale, sia che venga loro riconosciuto un particolare status, sia che ciò non rientri nell’ordinamento locale.
È già previsto un eventuale finanziamento per la comunità religiosa da parte dello Stato in cui si trova, sia a vantaggio della comunità che rispetto ai sussidi riconosciuti alla religione di Stato o tramite le tasse che gli appartenenti al gruppo devono versare a beneficio di culti non professati. Altre situazioni di svantaggio per le minoranze religiose sono l’impossibilità di contrarre matrimonio secondo le regole del proprio culto, l’imposizione di feste religiose in disaccordo con il loro culto oppure l’impossibilità di esercitare l’obiezione di coscienza nei riguardi del servizio militare o di prestare giuramento secondo il proprio credo. In tale ottica il disegno di legge per un Patto internazionale per l’eliminazione di tutte le discriminazioni religiose, contiene previsioni circa le libertà suddette ed anche quella di aderire o meno ad una religione o ad un credo, di cambiarla, di manifestarne i principi in pubblico ed in privato, di esprimere pareri in ambito di culti.
Gli Stati, dal canto loro, devono assicurare le libertà in materia di riunione, di disponibilità di posti, di insegnamento di ogni credo e della sua pratica attraverso l’istituzione di organismi assistenziali ed educativi, nonché una protezione legale per tutti i luoghi di culto, di non contrarre giuramento secondo il credo nazionale, e di organizzazione connessa all’esercizio del culto professato. Il 18 dicembre 1992, l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la “Dichiarazione sui diritti delle persone in situazione di minoranza nazionale, etnica, religiosa o linguistica”[34], ove si ribadisce che gli Stati sono tenuti ad incoraggiare la promozione dell’identità delle minoranze e che gli individui appartenenti a tali gruppi minoritari hanno il diritto di partecipare in maniera effettiva alle decisioni prese a livello nazionale e regionale che concernono la minoranza stessa, compatibilmente con l’ordinamento interno.
Le linee guida di come questa discriminazione positiva prende forma, sono enunciati all’art. 4, ove è statuito che lo Stato è tenuto ad adottare misure atte a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizioni della minoranza, a prevedere l’insegnamento anche nella lingua della minoranza ed a promuovere la conoscenza della cultura della minoranza nel resto del paese. Tuttavia, come evidenziato nel corollario della Dichiarazione[35], si è assunto un atteggiamento di cautela per evitare che gli Stati indulgano alle rivendicazioni separatiste e secessioniste di cui è potenzialmente portatrice ogni minoranza, facendo ricorso ad una serie di concessioni che permettano un dispiego di diritti sufficiente a non determinarne l’estinzione, senza dover mettere in discussione i propri confini.
3. Convenzione europea sui diritti umani
Proviamo ad approfondire il discorso sul sistema di garanzie approntato dal Consiglio d’Europa con la Convenzione europea sui diritti umani, siglata a Roma il 4 novembre 1950, e con i Protocolli addizionali, il primo dei quali firmato a Parigi il 20 marzo del 1952 i cui articoli da 1 a 4 sono parte integrante della Convenzione. Il sistema di garanzia che emerge, appare più improntato a quelli civili e politici che a quelli economici, sociali e culturali, già garantiti dalla Carta sociale europea, sancendo così un compromesso tra esigenze sovrane degli Stati ed umanitarie degli individui[36].
Il meccanismo internazionale di controllo creato a garanzia dei diritit umani, è formato da una serie di operazioni: l’individuo od il gruppo che sostenga di essere vittima di una violazione, commessa da uno Stato che abbia riconosciuto ed accettato l’art.25 della Convenzione[37], può inoltrare ricorso alla Commissione europea per i diritti umani che, dopo aver esaminato la ricevibilità del ricorso e affermatane la correttezza procedurale nonché la fondatezza, lo esamina nel merito. L’organo in esame può proporre alle due parti un componimento amichevole della vicenda attraverso un indennizzo forfettario o l’impegno di abolire le misure criticate. Se tali proposte non trovano accoglimento, la Commissione redige e trasmette il suo rapporto alla Corte europea dei diritti umani ma se lo Stato accusato non ne ha accettato previamente la giurisdizione o se il caso non riveste particolare importanza per la Commissione, il rapporto viene allora sottoposto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, organo politico. Ed il risultato del procedimento può essere una sentenza della Corte – di assoluzione o di condanna – oppure una decisione. In caso di condanna, lo Stato può essere tenuto a fornire “un’adeguata soddisfazione” alla vittima della violazione, anche pecuniaria ed il Comitato dei Ministri ha il dovere di sorvegliarne l’ottemperanza. Requisiti per l’ammissibilità del ricorso sono, la sua sottoscrizione, il carattere della novità e l’aver esaurito tutti i rimedi giurisdizionali interni da non più di sei mesi.
Il procedimento si può inoltre svolgere nella lingua del ricorrente e viene garantito, a certe condizioni il diritto al patrocinio gratuito. Come si può notare, è con la Convenzione che si realizza la prima attuazione al diritto di petizione, attraverso cui è il cittadino a ricorrere direttamente contro uno Stato anche straniero, a causa della violazione di un diritto o libertà fondamentale da parte di questo, quasi limitandone la sovranità nazionale, attraverso l’eventuale sua condanna, per mezzo dell'organo giurisdizionale, reale e non limitata a formulare inviti o raccomandazioni allo Stato riconosciuto colpevole.
Il Comitato dei Ministri deve altresì esaminare le misure atte a realizzare gli scopi del Consiglio d’Europa tra cui la salvaguardia e l’ulteriore sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il collegamento tra i poteri statutari del Comitato dei Ministri ed il sistema di garanzie esaminato, si può dedurre dalla possibilità di esercitare questi poteri in seguito all’esercizio del potere di interpellanza, devoluto al Segretario generale del Consiglio d’Europa dall’art.57, per il quale “ogni parte contraente fornirà su domanda del Segretario generale le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l’effettiva applicazione delle disposizioni della Convenzione”.
In relazione alle domande provenienti dagli Stati contraenti, la Commissione ha competenza obbligatoria; facoltativa nel caso di ricorsi individuali, di gruppi non governativi o di privati, che peraltro costituiscono la maggior parte.
Esercita la sua competenza sotto diversi profili: ratione personae, materiae, temporis, loci ed inoltre non si attiene strettamente al petitum, ma esamina se i fatti, anche se sommariamente allegati, possono far dedurre possibili violazioni – pur se non espressamente fatte valere dal ricorrente - senza che ciò costituisca deroga ai rigidi criteri di ammissibilità di cui sopra. Il ruolo della Commissione risulta quindi definito dall’art.19, e consiste nell’assicurare il rispetto degli impegni risultanti dalla Convenzione per le Alte Parti contraenti come necessario tramite tra i ricorrenti e la Corte europea per i diritti umani.
Le parti contraenti hanno voluto conferire carattere facoltativo a quelle clausole della Convenzione che condizionano l’effettivo raggiungimento dello scopo o, a seconda dei casi, il suo migliore raggiungimento: si tratta delle clausole degli articoli 25 e 46 rispettivamente relativi ai ricorsi individuali ed alla giurisdizione della Corte, sottoscritte dalla quasi totalità degli Stati contraenti, in attuazione del principio ispiratore della Convenzione, espresso nel suo art.1, di riconoscimento ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione dei diritti e delle libertà oggetto delle stipulazioni delle parti contraenti, senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, colore od opinione politica, di appartenenza ad una minoranza nazionale, di nascita o altra condizione (art.14), pietra miliare della formazione di un sistema di diritto pubblico europeo. La fattispecie dei diritti economici e sociali viene considerata nel quadro della Carta sociale europea del 1961, entrata in vigore quattro anni più tardi e vincolante vari Stati europei in materia di diritto al lavoro, equità retributiva e di condizione lavorative delle donne e dei fanciulli, diritti sindacali ed alla sicurezza sociale. Si tratta comunque di disposizioni che prevedono vengano prese delle misure di ordine interno, attraverso leggi od altri mezzi appropriati, affinchè sia concessa agli interessati la titolarità dei diritti considerati. Sono i lavori preparatori a chiarire la formula di garanzia espressa dalla Carta sociale, introdotta precipuamente per “escludere ogni possibilità per gli interessati di valersi direttamente delle disposizioni della Carta, davanti alle autorità o giurisdizioni nazionali”[38].
A tale sistema di garanzia partecipano gli organi: lo sbocco del controllo può consistere in una raccomandazione rivolta allo Stato contraente risultato colpevole, adottata dall’organo politico, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, a maggioranza di due terzi, cioè almeno 14 membri. Qui si nota come tale garanzia sia meno incisiva di quella prevista dal meccanismo composto da Commissione e Corte europea, stante la diversa natura dei diritti considerati, che in questo caso necessitano di adozione, da parte degli Stati, di preventive misure sociali di ordine interno. Da ciò deriva la difficoltà di portare a conoscenza degli organi internazionali di controllo, le misure interne che di volta in volta vengono adottate in attuazione alla Carta sociale. Risulta necessaria una distinzione tra norme giuridiche che mirino a stabilire direttive obbligatorie per l’azione governativa in ambito sociale e norme giuridiche comportanti l’effettivo riconoscimento dei diritti in questione. Le prime norme si trovano nella Carta sociale come nel Patto dell’ONU e sono pertanto di diritto internazionale; le seconde, invece, competono alla normativa giuridica interna degli Stati contraenti. Di conseguenza la tutela delle prime è devoluta agli appositi organismi internazionali, mentre spetta alle istanze nazionali dei singoli Stati, che venga rispettato il diritto interno conforme alle prescrizioni internazionali. Bisogna però accertare che queste prescrizioni indicate dagli ordinamenti interni, servono effettivamenti a conferire ai soggetti tutelati uno status internazionale conforme ai diritti previsti dalla Carta sociale europea. Una dottrina sostiene che ciò avvenga e che in sostanza si materializza così un raccordo ideale tra la Carta sociale e la Convenzione europea[39].
Infatti se si considera la garanzia giudiziaria apprestata si deve riconoscere, alle persone sul piano internazionale, il diritto alla buona amministrazione giudiziaria ricompreso all’art.6.1 della Convenzione - quando istituisce un tribunale speciale per la risoluzione delle “controversie sui diritti di carattere civile” - parole che hanno anche nel Patto sui diritti civili e politici ONU all'art.4.1 un ampio significato, in contrapposizione a quello di diritti politici. Ne consegue che l’art.6.1 della Convenzione non si applica solo alle contestazioni fra privati, ma anche qualora venga messa in causa la responsabilità della pubblica autorità.
Analisi del sistema
1. Obiettivi perseguiti dai governi
L'analisi delle misure internazionali di applicazione – in particolare quelle incluse nei Patti e nel Protocollo opzionale – evidenzia le deficienze del sistema a cominciare dai rapporti degli Stati che, oggetto di un esame superficiale, può concludersi con raccomandazioni di ordine generale, non specifico e neanche con segnalazioni di determinati episodi.
La procedura per la risoluzione delle controversie, che si fonda esclusivamente sulla buona volontà degli Stati, può inoltre essere interrotta da una parte prima della nomina della Commissione di conciliazione e non consente il ricorso unilaterale ad organi giudiziari nel caso che l’accordo si riveli impossibile. Il sistema della petizione individuale può essere bloccato da una dichiarazione di inammissibilità da parte dell'organo che la riceve ed in ogni caso, se ammissibile, non dà luogo ad alcun esame sul fatto, nè a valutazioni giuridiche: è infatti previsto che il Comitato per i diritti dell'uomo, che non è organo giurisdizionale, si limiti ad esprimere le sue vedute. Complessivamente si è portati a ritenere il sistema dei rapporti previsti dai due Patti, come uno strumento di informazione più che di controllo: riescono quindi maggiormente utili quelli in materia economica, sociale e culturale, nei quali l’informazione può servire per una azione internazionale di assistenza[40].
Così come era stata l’enunciazione del principio di autodeterminazione dei popoli, contenuto nei Patti agli artt.1, a rivestire il carattere di diritto fin dal 1966. Se ne trova conferma ulteriore in sede europea, nell’Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975 (l’Atto di Helsinki), in cui si ribadisce il diritto di tutti gli Stati a scegliere liberamente la loro forma di Stato, di politica, di governo e di economia. Sempre in materia, ed in ambito ONU, altri atti furono la Dichiarazione per l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati, mentre al di fuori dell'ONU, tale diritto fu considerato anche nella Carta Africana dei diritti dell'uomo (1981) come imprescrittibile ed inalienabile. Si può quindi affermare che l'esistenza di questo diritto per i popoli e la sua natura di vero e proprio diritto, e non soltanto di un principio di ordine generale, sia ormai universalmente accolta nella comunità internazionale[41].
Bisogna però verificare se il diritto all’autodeterminazione appartenga al popolo quando questo costituisce l’unica collettività presente in una organizzazione statuale, oppure alle singole collettività quando più d’una coesistano nell'ambito dello stesso territorio. Nella prima ipotesi, un unico popolo, è noto che non sono sorti particolari contrasti nel riconoscere il diritto all’autodeterminazione ad uno o più popoli “coloniali”; ma, esauritosi il fenomeno, si è visto anche che il contenuto di tale diritto andava ben oltre tale implicazione. Quando si è tentato di applicare tale principio alle spinte nazionalistiche in qualche area, europea o non, è subito sorta la preoccupazione che se autodeterminazione equivale a dare via libera all’autonomia di qualunque nazionalità, ciò avrebbe significato automaticamente il crollo per l'Europa dei confini politici mantenuti in vigore per oltre trent’anni[42].
Le Nazioni Unite dovevano quindi trovare un limite a questo principio, con nuove e convincenti argomentazioni giuridiche: ed infatti nell’ambito della Dichiarazione sui principi delle relazioni amichevoli fra gli Stati, si è introdotto il concetto dell'integrità territoriale, secondo il quale sembrerebbe che il diritto all’autodeterminazione non possa essere riconosciuto ad un popolo, laddove l’esercizio del diritto stesso porti allo smembramento dell’unità territoriale. Ma ciò sarebbe una contraddizione in termini, in quanto non si può limitare il diritto ad un soggetto soltanto sulla base di una mera circostanza di fatto e cioè sull'esistenza nell'ambito territoriale di uno o più di un popolo. Com molta probabilità questo concetto di integrità territoriale ha un significato politico: evita che siano incoraggiati i processi di smembramento o di secessione nell'ambito degli stati. Ma la stessa Dichiarazione contiene anche dei limiti a tal principio, laddove per esempio, si considera legittimo il diritto all’autodeterminazione di un popolo, anche se il suo esercizio dovesse condurre allo smembramento dello Stato, qualora il potere costituito nell'ambito di quel territorio non rispetti i diritti dell’uomo[43].
Nonostante i numerosi esempio di esercisio del diritto di autodeterminazione – come in Congo, Nigeria e Pakistan – da cui si sono scissi altrettanto Stati col placet della comunità internazionale, ci sono altre istante autonomiste contro cui è stato invocato il principio dell’integrità territoriale: a Cipro, dove non si può dar luogo all’autodeterminazione turco-cipriota o nei territori dell’ex-Jugoslavia, ove si riutilizzano termini ormai desueti come balcanizzazione - invitando cautamente ad invitarla – cioè la frammentazione di queste ex unità territoriali in nome di un’integrità non più voluta dal popolo. Ponendosi la questione di perché tutto ciò, è forse possibile e legittimo pensare che gli Stati europei hanno continuato a giudicare della legittimità di un avvenimento solo per finalità politiche ben chiare, come la intangibilità dei confini dei paesi europei o dei paesi sui quali gli europei avevano una particolare influenza o degli interessi economici e/o strategici[44].
In presenza di una politica pluralistica nei confronti dei gruppi etnici o linguistici minoritari, l’istituzione di strutture di governo federalistico per le garanzie autonomistiche di particolari regioni, si sono rivelate efficaci per salvaguardare l’identità culturale ed i diritti fondamentali di tali gruppi. È presupposto fondamentale, l’allocazione geografica in un dato territorio; diversamente nel corso del tempo potrebbe verificarsi uno sbilanciamento rispetto ad altri gruppi minoritari non omogenei, residenti in aree differenti dello stesso paese. In altri paesi la concezione pluralistica è stata completata con misure speciali per la garanzia ai gruppi minoritari dei diritti loro specifici, nell’ambito di un unitario disegno di governo.
L’effetto del corporativismo dei gruppi etnici[45] sul pluralismo etnico non è però chiaro: l’incorporazione di gruppi etnici può avere una notevole varietà di conseguenze, in relazione all’estensione del paese ed alla coesione del gruppo stesso. Nei paesi, poi, in cui i gruppi di minoranza non siano riconosciuti implicitamente od esplicitamente, la politica adottata è normalmente quella dell’assimilazione. Nei paesi in via di sviluppo, a causa della facilmente riscontrabile fragilità di governo, valori fondamentali come unità nazionale e sicurezza dello Stato sono spesso calpestati: in tal caso i caratteri multilinguistici ed etnici vanno valutati di volta in volta, e spesso si è verificato che tali requisiti, apparentemente contrastanti, abbiano guidato molti di questi paesi al riconoscimento dell’integrazione dei gruppi minoritari, quasi a perseguire un preordinato disegno politico.
Capotorti considera che il sistema dell’integrazione non può essere, in nessun caso, imposto ai membri dei gruppi di minoranza, dipendendo dalla loro libera volontà[46]. Infatti, l’esperienza ha mostrato che in una società multirazziale, il modo più efficiente e soprattutto pacifico per edificare una nazione unitaria, consiste nell’adottare una politica di salvaguardia delle tradizioni proprie dei singoli gruppi che lo compongono. Evitare il separatismo e difendere l’integrita dello Stato è l’obiettivo di ogni governo. È un grosso limite per introdurre ogni politica minoritaria ma è il risultato da perseguire per le istanze equalitaristiche dei gruppi minoritari, al fine di registrare una società in grado di garantire unitariamente le specifiche esigenze dei suoi componenti.
2. Il caso dei conflitti nella ex Iugoslavia
La Yugoslavia, Stato federale multinazionale, ha cessato di esistere già prima del 27 aprile 1992, data della proclamazione di una nuova Repubblica federale di Yugoslavia, formata dal Montenegro e dalla Serbia. Si presentava decisamente meno omogeneo rispetto agli altri Stati del continente: fondato su di un sistema composto da tre elementi, sei nazionalità ufficialmente riconosciute cioè croati, macedoni, montenegrini, musulmani, serbi e sloveni e ciascuno formante la base di una Repubblica; dieci gruppi etnici yugoslavi tra i quali occorre ricordare gli albanesi del Kossovo e gli ungheresi della Voivodina; infine le due minoranze austriaca ed ukraina.
Il sistema era quindi precario, considerando che il gruppo più numeroso – i serbi – al censimento del 1981 rappresentava solo il 35% dell’intera popolazione. Completano il quadro le dichiarazioni di indipendenza di Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Macedonia, che hanno generato la frammentazione territoriale che ha condotto alle note tragedie umanitarie. Se la Slovenia non ha creato problemi, complice la sua omogeneità etnoculturale, e la questione macedone si risolta con la cessazione delel rivendicazione greche ad una territorialità estesa, il problema Bosnia e Croazia si manifesterà fino a quando la predominanza serba è stata avvertita, in tutta la Yugoslavia, come una minaccia incombente.
La situazione ante-dissoluzione vedeva il territorio bosniaco controllato al 65% dai serbi, al 30% dai croati ed il rimanente dai musulmani, tanto da costituire una repubblica serba in territorio bosniaco, avversata da un’alleanza costituita da bosniaci e croati, non scevra da contraddizioni e diffidenze reciproche a causa dei timori che tra alleati le legittime aspirazioni di un gruppo nazionale, si tramutavano in egemonia ed accentramento politico. Arrivano quindi le dichiarazioni di principio fatte in occasione della Conferenza di Ginevra sull’ex-Jugoslavia, ma anche le strumentalizzazioni delle minoranze nazionali locali, sia da parte della Serbia che della Croazia. Prova ne è il testo costituzionale della nuova Jugoslavia, ristretta a Serbia e Montenegro, che prevede che il nuovo Stato possa allargarsi a tutte le repubbliche che lo desiderino, incoraggiando le repubbliche secessioniste serbe di Bosnia e Croazia, autoproclamatesi tali, a far valere il loro diritto all’autodeterminazione in vista dell’annessione. Ecco perché ciascuna parte mirasse a consolidare le conquiste territoriali, anche se in danno delle minoranze nazionali contigue, prima del sopravvento del necessario regolamento politico che di lì a poco avrebbe regolamentato gli statuti delle minoranze nazionali del nuovo Stato[47]. La situazione nel Kossovo presentava alta instabilità con un milione di albanesi – il 90% della popolazione – privati del loro statuto autonomo dal 1991 ed occupati dalle più agguerrite milizie serbe impegnate – con difficoltà – a mantenere l’ordine.
Le parti erano in aperta contraddizione su tutti i fronti: i serbi si annettono il Kossovo definendolo parte integrante del loro territorio; gli albanesi, invece, rivendicano il diritto dei popoli all’autodeterminazione dei popoli e resistono all’occupazione serba.Indette poi nuove elezioni nel maggio 1992, si sono dotati di un Parlamento ed un Presidente, elezioni che - prontamente qualificate come illegali dalle autorità serbe - non hanno fatto altro che inasprire il contrasto e che negli albanesi hanno rinfocolato sentimenti irredentisti mai sopiti, votati all'unificazione col Governo centrale di Tirana, per la costituzione di una "grande Albania", dato che più del 50% del ceppo albanese vive al di fuori dei confini del paese, nel Kossovo, in Macedonia e in Montenegro (3,2 milioni contro i 2,5 milioni entro confine)[48]. Una missione della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione Europea ha cercato di smorzare questi sentimenti[49], producendo parallelamente pressioni sulle autorità serbe per la concessione di uno statuto autonomo agli albanesi del Kossovo, ma inutilmente, dato che questi rifiutano il ruolo di cuscinetto tra gli stati serbi; in effetti si può parlare più che di una tensione di gruppo minoritario, della ben più grave situazione di una nazione divisa.
Per risolvere in modo pacifico la questione del Kossovo, ci fu chi avanzò la proposta di separare la controversia in esame dall’insieme dei conflitti allora in atto[50], designando, da parte ONU, un gruppo di personalità serbe e kossovare, che convenissero all’elaborazione di un accordo tra le parti, affiancando tale comitato alle misure già in atto per la ristabilizzazione della pace. Le due delegazioni dovevano ricevere l’approvazione del mediatore ONU nominato dal Segretario generale, incaricato di organizzare gli incontri, come delle rispettive controparti. Ma i problemi da considerare spaziavano dall’educazione alla sanità, dall’economia alla composizione delle discriminazioni in materia di lavoro, sino ai diritti culturali, linguistici, religiosi e comunque etnici senza riguardare minimamente lo Statuto territoriale autonomo, che da parte albanese veniva ovviamente auspicato nonché la delimitazione delle frontiere. Il mediatore doveva istituire una procedure di ricorso presso un ombudsman ed un meccanismo di supervisione sul rispetto degli accordi trattati.
Con questa separazione del problema politico da quello culturale si voleva evitare di giungere necessariamente alla nascita di un nuovo Stato. Si trattava sempre del principio di autodeterminazione, come espresso dall’art.1 dei Patti[51], ma completato dall’autolimitazione in entrambi i sensi: la nazione maggioritaria, che costituisce lo Stato, doveva rinunciare all’interpretazione esclusiva della dottrina della sovranità nazionale se la conduce a ritenersi unica depositaria dell’identità Stato-nazione, escludendo così le aspirazioni autonomistiche degli altri gruppi nazionali; questi ultimi dovevano limitare le rivendicazioni autonomistiche cioè permetterne lo sviluppo e la realizzazione nell’ambito istituzionale dello Stato[52]. In tale ottica, autodeterminazione significava qualsiasi forma di autonomia richiesta dal gruppo, per la preservazione della sua identità nazionale, realizzabile all’interno di un ordinamento democratico: così, ai fini della tutela delle minoranze, si raggruppano tutte le nazionalità presenti in Europa.
3. L’intervento della comunità internazionale
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU con la Ris.713 del 25 settembre 1991 decise l’adozione dell’embargo commerciale sulle armi dirette in Yugoslavia. Successivamente venne istituito, nell’ambito della Sottocommisisone ONU per la lotta contro le discriminazioni e la protezione delle minoranze, un osservatorio per “tastare il polso” alla situazione ed adottare le misure cautelative necessarie. In tale senso, la Sottocommissione, nella 14^ seduta del 13 agosto 1992, ribadì che alla base del suo mandato c’era la protezione dei differenti gruppi etnici e religiosi e che in funzione degli orrori suscitati dalle politiche di pulizia etnica e di esodo forzato di rilevanti parti della popolazione musulmana, nella ex Yugoslavia, esigeva che venissero adottati provvedimenti d’urgenza per porre fine alle massicce violazioni dei diritti garantiti internazionalmente ai popoli, ponendo fine alle politiche ed alle pratiche di pulizia etnica, garantendo il rientro ai luoghi d’origine degli esuli e la loro sicurezza, risarcendo integralmente i danni nonché l’assicurazione alla giustizia dei responsabili dei crimini commessi,a nche tramite misure particolari d’urgenza[53].
Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha risposto proprio a quest’ultima istanza della Sottocommissione, decidendo la creazione di un Tribunale internazionale per perseguire i responsabili diretti ed indiretti delle gravissime violazioni alle convenzioni umanitarie internazionali, commesse nei territori della ex Yugoslavia a partire dal 1991[54], in relazione anche al paragrafo 10 della risoluzione 764 del 13 luglio 1992 in cui si confermava che tutti gli individui colpevoli o mandanti di gravi violazioni delle convenzioni internazionali, ed in particolar modo di quella di Ginevra del 1949, vengono ritenuti responsabili personalmente di dette violazioni. Richiamava inoltre la risoluzione 771 (1992) nella quale veniva imposto a tutte le parti in conflitto di deporre le armi e cessare da ogni violazione delle leggi umanitarie internazionali, la risoluzione 780 (6-10-1992) in cui richiedeva al Segretario generale dell'ONU di istituire come misura d'urgenza un’imparziale commissione di esperti, per esaminare ed analizzare i dati informativi relativi alle citate risoluzioni nonché il rapporto che tale commissione aveva poi elaborato, in cui si confermava che l'istituzione di un Tribunale internazionale ad hoc sarebbe stata coerente con le finalità perseguite dal Consiglio di Sicurezza ONU[55].
Ribadiva, nella stessa risoluzione 808(93), che “la situazione attuale costituisce minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, a causa delle deportazioni di massa ed epurazioni intese come operazioni di pulizia etnica, oltre che dei gravissimi crimini commessi a tal fine, in special modo su moltissime donne musulmane”. Successivamente, la Sottocommissione per la protezione delle minoranze, ribadendo il rigetto unanime per qualsiasi forma di violazione dei diritti umani ed in riferimento agli abbozzi programmatici di un accordo costitutivo per la nascita di un Unione delle Repubbliche di Bosnia ed Erzegovina, nega la validità di qualsiasi accordo, non volto alla cessazione delle ostilità, aprendo la via ad una maggiore stabilità geopolitica, basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite[56].
Viene quindi, nello stesso rapporto, espresso il parere che l’inizio del disarmo delle parti sia il modo migliore per giungere all'elaborazione di un piano di pace, purchè esteso anche alle fazioni non controllate dall'attuale Governo, senza impunità per i responsabili degli eccidi e, a tal fine, viene sollecitato l'impianto del Tribunale internazionale introdotto dalla risoluzione 808(92) del Consiglio di Sicurezza.
4. La richiesta di misure cautelari alla Corte di Giustizia Internazionale
Nella vicenda si innesta il ricorso di Governo di Bosnia presso la Corte di Giustizia Internazionale, organo giurisdizionale sovranazionale, per ottenere l’indicazione di misure cautelari ai sensi dell’art.41 dello Statuto, un giudizio di netta riprovazione nei confronti della nuova Federazione Yugoslava, al fine di dissuadere quest’ultima dal partecipare alla guerra[57].
Nell’atto introduttivo, insolitamente lungo, e dopo aver descritto una numerosa serie di episodi di estrema gravità, la Bosnia chiedeva che la nuova Yugoslavia (Serbia e Montenegro) fosse riconosciuta colpevole di aver violato nei suoi confronti alcune norme internazionali tra le più importanti, oltre alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, il primo Protocollo aggiuntivo del 1977 e le norme consuetudinarie, compreso il regolamento dell’Aja sulla guerra terrestre del 1907, e altri principi fondamentali del diritto umanitario internazionale, molte disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della Carta delle Nazioni Unite.
Inoltre chiedeva che la Corte riconoscesse: il diritto all’autodifesa ai sensi dell'art.51 della Carta e del diritto internazionale consuetudinario; la non applicabilità della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 713(91), che aveva disposto l’embargo sulle armi contro la Yugoslavia e delle successive risoluzioni sullo stesso argomento; la facoltà degli Stati membri delle Nazioni Unite di esercitare in relazione alla Bosnia il diritto all’autodifesa collettiva ai sensi dell'art.51 della Carta. Infine il governo bosniaco chiedeva alla Corte di dichiarare che la Yugoslavia ed i suoi alleati erano tenuti a cessare dal commettere atti in violazione delle predette norme internazionali e condannati a riparare i danni subiti dalla Bosnia. L’atto introduttivo è stato immediatamente seguito dalla richiesta di misure cautelari pendente lite, in gran parte relative alle conclusioni dell’atto introduttivo stesso, e cioè:
- la Yugoslavia "togheter with its agents and surrogates" deve cessare immediatamente da qualsiasi atto di genocidio contro popolo e Stato di Bosnia;
- la Yugoslavia deve cessare altresì di appoggiare ogni nazione, gruppo, organizzazione, movimento, milizia o individuo impegnato o che intenda impegnarsi in attività militari o paramilitari contro popolo, Stato o Governo di Bosnia;
- il Governo bosniaco ha diritto di chiedere e ricevere aiuto (anche militare) da altri Stati per difendersi e, viceversa, ogni Stato ha il diritto di intervenire a difesa "anche armata" della Bosnia.
La procedura sulla richiesta di misure cautelari si è svolta con la maggiore celerità possibile. La Yugoslavia ha scelto di prendervi parte. Le udienze furono fissate per giorni 1 e 2 aprile 1993 e una richiesta di proroga del Governo Yugoslavo venne respinta. Lo stesso Governo, anche se non espressamente autorizzato a farlo, il 1° aprile aveva prodotto delle osservazioni scritte in cui chiedeva venissero adottate misure in parte corrispondenti a quelle suddette, nei confronti delle “authorities controlled by A.Izetbegovic”.
Ricordiamo la prima di queste richieste, in cui si raccomandava alle autorità bosniache di conformarsi strettamente all'allora ultimo accordo sul cessate-il-fuoco, entrato in vigore il 28 marzo 1993. Nel primo argomento avanzato dalla difesa yugoslava, si contestava al Presidente Izetbegovic, la competenza a nominare gli agenti di parte bosniaca e a decidere la proposizione del giudizio avanti alla Corte. Ma la Corte ha constatato che il Presidente bosniaco è riconosciuto dall’ONU come capo legittimo dello Stato e quindi universalmente riconosciuto come il potere di un capo di Stato di agire per conto di esso, in materia di relazioni internazionali[58].
La competenza della Corte a conoscere il merito della controversia (competenza principale), è stata subito oggetto di contestazione, cosa che le ha imposto di prender posizione al riguardo cercando di accertare l’esistenza di una competenza almeno “prima facie”, ma con una formula lievemente innovata rispetto al passato: la Corte infatti annuncia di voler esaminare se sussista tale competenza, alla luce non solo delle disposizioni invocate dalla parte istante, ma anche di quelle “found in the Statute”, come a volersi riservare il potere di indicare d’ufficio, titoli di competenza non indicati dalla parte istante, almeno quando si tratti di disposizioni contenute nello stesso Statuto, autoattribuendosi un’autonomia maggiore dalle richieste di parte. Questa è la prima volta che la Corte si è trovata nella necessità di verificare la propria competenza non solo in termini di “ratione materiae” ma anche “ratione personae”. Quest’ultima competenza è definita dal combinato disposto dell’art.93 della Carta e dell’art.35 dello Statuto, da cui si ricava che hanno legittimazione attiva presso la Corte: a)gli Stati membri delle Nazioni Unite; b) gli Stati non membri ma divenuti parte dello Statuto secondo le condizioni stabilite dall’Assemblea Generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza (art.93 par.2); c)gli Stati non parti dello Statuto, alle condizion prescritte nell’art.35 par.2 dello Statuto.
I dubbi, nella fattispecie, riguardavano la possibilità della partecipazione all’ONU della Yugoslavia, dopo che l’Assemblea Generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, aveva adottato la risoluzione 47/1 del 22 settembre 1992, ove si affermava che la nuova Yugoslavia, non potendo assumere automaticamente la qualità di membro già assunta dall’ex Jugoslavia, doveva presentare una nuova domanda d’ammissione e nelle more, non poteva partecipare ai lavori dell’Assemblea. La questione di competenza è stata risolta, considerando l’adesione del nuovo stato, ad un trattato in vigore come la Convenzione sul genocidio, sufficiente a fondare “prima facie”, la competenza “ratione personae” della Corte, in base all’art.35 par.2 dello Statuto. I dubbi circa la competenza “ratione materiae” riguardavano la Bosnia. Infatti, nell’atto introduttivo del giudizio, la competenza della Corte veniva fondata sulla clausola compromissoria contenuta nell’art.IX della Convenzione sul genocidio. Ma per poter invocare tale titolo di competenza, era necessario che la Bosnia dimostrasse di essere divenuta parte della Convenzione.
La Corte non ha ritenuto necessario esaminare se la notificazione di successione dal Governo bosniaco trasmessa all’ONU fosse realmente tale, conferendo quindi alla Bosnia qualità di parte della Convenzione immediatamente od a partire dalla data della proclamazione di indipendenza. A giudizio della Corte la Bosnia è divenuta parte alla scadenza di un periodo di 90 giorni dalla predetta notificazione; tale termine cadeva dopo l’atto introduttivo, ma prima delle udienze, e ciò, secondo la Corte non costituisce necessariamente un ostacolo all’indicazione di misure cautelari ex art.41 dello Statuto, dal momento che per la Corte vengono in rilievo fatti presenti e futuri e non fatti passati[59]. La competenza “prima facie”, è limitata secondo la Corte ai profili della controversia che riguardano interpretazione ed applicazione della Convenzione; per gli aspetti non coperti dal citato articolo, la Bosnia aveva invocato in una memoria supplementare del 31 marzo 1993, un ulteriore titolo di competenza, tratto da una lettera in cui i presidenti di Serbia e Montenegro demandano proprio al giudizio della Corte le questioni giuridiche derivanti dalla disgregazione dell’ex Yugoslavia in merito alle quali le parti non avessero raggiunto un accordo. Secondo la Bosnia tale lettera, inviata al Presidente della Commissione d’arbitrato istituita dalla conferenza internazionale per la pace in Iugoslavia, in unione alla sua accettazione da parte bosniaca, era sufficiente a fondare la competenza della Corte.
La Yugoslavia, invece, la contestava sia perchè non inserita nell’atto introduttivo, sia perchè non vincolante. Questo documento non è stato accettato come probante la competenza della Corte, perchè dubbio era il significato da attribuirgli, nel senso richiesto dalla Bosnia, producendo come unica conseguenza negativa quella di limitare le misure cautelari ai soli profili della controversia riconducibili alla violazione della Convenzione sul genocidio. Da tutto ciò consegue che il diritto da proteggere attraverso l’indicazione delle misure cautelari è, secondo la Corte, quello che ciascuna parte trae dall’art.1 della Convenzione: il diritto di ottenere che l’altra parte prevenga la commissione di atti di genocidio per l’avvenire. La Corte non deve prendere posizione nè sul se atti di genocidio siano già stati commessi, nè tantomeno sul se la Yugoslavia abbia responsabilità dirette o indirette su tali atti. Nell’ordinanza si deduce la presenza dei presupposti per l’indicazione delle misure cautelari solo dall’accenno che al par.45 la Corte fa al rischio di grave danno al diritto di cui si chiede la provvisoria protezione, e dalla sua imminenza da cui discende l’urgenza dello strumento richiesto. Inoltre la Corte fa riferimento al rischio di un aggravamento o di un’estensione della controversia.
Viene poi sottolineata l’autonomia di valutazione della Corte stessa, in base alla quale possono essere indicate misure diverse da quelle richieste (par.46) ex art.75 par.2 reg.proced.; inoltre la Corte esclude la rilevanza dell’art.VIII della Convenzione, invocato dalla Bosnia (che consente ad ogni Stato membro di invitare gli organi ONU competenti ad assumere le misure di prevenzione o repressione degli atti di genocidio più appropriate), in quanto non amplia i poteri previsti dallo Statuto per la Corte. Sono, infine, state adottate dalla Corte, tre distinte misure, la prima e la seconda dirette alla sola Yugoslavia, mentre la terza ad entrambe le parti: la prima ha contenuto generico e si limita a richiamare la Yugoslavia all’obbligo di prevenire la commissione di crimini di genocidio, senza alcun riferimento agli episodi in corso in Bosnia; la seconda misura è più specifica ed impone alla Yugoslavia di assicurarsi che nessuna unità militare sotto il suo controllo, commetta atti di genocidio, di incitamento pubblico o di cospirazione a commettere genocidio, o di complicità in genocidio contro la popolazione musulmana di Bosnia-Erzegovina, o di qualsiasi altro gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. La terza ed ultima misura, indica ad entrambe le parti di non assumere alcuna iniziativa che possa aggravare o estendere la controversia.
Le decisioni della Corte in questa materia, hanno per natura lo scopo di assicurare la difesa temporanea ed in tempi stretti, dei diritti delle parti, mai in modo definitivo: la Corte si riserva sempre, attraverso apposite clausole, piena libertà di giudizio per le fasi successive del procedimento. L’ordinanza non ha affrontato le questioni più difficili della controversia, soprattutto l’eventuale responsabilità yugoslava sugli atti già commessi in territorio bosniaco; in mancanza di una provvisoria presa di posizione sul tema, anche il contenuto delle misure indicate dalla Corte, rischia di essere troppo generico, e solo una previa qualificazione delle azioni commesse in Bosnia come atti di genocidio avrebbe dato un contenuto concreto all’inibitoria inserita nelle prime due misure indicate, che funzionasse almeno da deterrente contro il possibile ripetersi di tali atroci eventi.
5. Risultati conseguiti
Oltre agli strumenti già considerati precedentemente, esistono numerose convenzioni ed organismi interni che hanno sortito effettivi risultati operativi, spesso in attuazione delle normative internazionali, secondo il principio per cui è lo Stato la variabile che trasforma una o più primigenie comunità in una Nazione, i membri della quale la determinano politicamente e non come parti di un gruppo etnico più o meno importante, ma principalmente da individui provenienti dalle più varie estrazioni però accomunati da criteri oggettivi[60].
Da questo punto di vista sono stati fatti un buon numero di sforzi per organizzare la convivenza di diverse comunità etniche senza arrivare al separatismo od allo smantellamento di uno Stato. Il federalismo, inteso secondo criteri etnici, in Svizzera, India, ex USSR, ex Iugoslavia ed in parte in Canada. Il quasi-federalismo e pseudo-federalismo in Belgio, Spagna (Catalogna), Italia (Trentino Alto Adige e Val d’Aosta), Cecoslovacchia (alternativamente, dopo la II guerra mondiale). Le autonomie regionali o locali come i fiamminghi e valloni in Belgio, i polacchi e russi a Vilnius ed i magiari in Transilvania (la cui esistenza come minoranza etnica è negata dal governo rumeno). Il consociativismo in Belgio, Olanda ed, in minor misura, Austria e Svizzera. La decentralizzazione delle funzioni, in Sri Lanka e quella mista, di funzioni ed autonomie nella Polonia del 16° e 17° secolo per il Consiglio (ebraico) delle Quattro Terre.
La rotazione dei pubblici uffici, come nel caso delle presidenze del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige e dell'assemblea provinciale di Bolzano. La garanzia di una rappresentanza legislativa per minime quote, per i gruppi etnici più rilevanti a Trinidad e nelle Figi. Sistemi legislativi e giurisdizionali multipli, funzionalmente differenziati in Nigeria, Stati Uniti del sudovest, Canada ed Israele. La creazione di commissioni di controllo, come in Austria, presso la Cancelleria federale, per le minoranze (slovene e croate) che si riuniscono periodicamente con lo scopo di influenzare la politica di governo in attuazione dei diritti di tali gruppi, attraverso l’inserimento di loro rappresentanti al governo federale, a quello provinciale e nell’ambito del sistema dei partiti. Altri casi sono rappresentati dal Belgio ove sono costituzionalmente previsti dei Consigli culturali per le comunità francese e fiamminga, che decretano su problemi culturali, linguistici e cooperativi; tali decreti hanno chiaramente efficacia limitata al territorio delle rispettive comunità, ma unitaria nella regione metropolitana bilingue di Bruxelles, in forza della normativa prevista. Possono muovere o ricevere petizioni scritte e devono perseguire la cooperazione tra le due comunità, attraverso un apposito Comitato.
Similmente, in Canada, è stato creato l’ufficio del Commissario delle lingue ufficiali (1969), che annovera tra i suoi doveri quello di attuare ogni misura necessaria ad assicurare il riconoscimento dello status di ognuna delle due lingue, francese ed inglese, nello spirito e con gli intenti dell’Atto istitutivo. In Finlandia il governo ha istituito una Commissione sugli affari lapponi, composta tra gli altri anche da rappresentanti di questa minoranza, la cui funzione è quella di suggerire al Consiglio di Stato le misure da prendere in relazione alla promozione della cultura del gruppo ed alle sue necessità materiali. Con analoghe funzioni esistono, in Svezia un’omonima commissione ed in Norvegia due organi, il Consiglio norvegese sui lapponi - composto da otto membri lapponi, col compito di apprestare raccomandazioni sulle misure relative alla situazione economica, sociale e culturale del gruppo - ed il Comitato di scelta - formato da rappresentanti governativi dei lapponi - per esaminare i problemi dello sviluppo educativo della minoranza. Sempre in Finlandia esiste la Gipsy mission del 1906, creata allo scopo di regolare i rapporti interrazziali tra la minoranza Gipsy ed il resto della popolazione.
Anche in Ungheria opera una commissione apposita con compiti analoghi ai suddetti. In India è previsto dalla Costituzione un Ufficio per le minoranze linguistiche, che cerca di risolvere i problemi relativi alla salvaguardia di tali gruppi, attraverso rapporti periodici, trasmessi direttamente al Presidente e ad ognuna delle Camere del Parlamento. In Nuova Zelanda sono stati creati due uffici governativi per trattare i problemi relativi ai Maori: il Dipartimento degli affari maori e dell’isola, che coordina ed integra la politica statale relativa, ed il Consiglio neozelandese dei maori che, da organo consultivo, esprime pareri su ogni questione riguardante la minoranza. Inoltre col Race Relation Act del 1971, fu creato l’Ufficio del Conciliatore, con poteri investigativi sia autonomi sia basati su istanze relative a qualsiasi atto in violazione alle previste disposizioni antidiscriminatorie, col compito di determinare un accordo tra le parti in questione ed, eventualmente, fornire le assicurazioni contro il ripetersi di tali atti. A Singapore esiste un Consiglio presidenziale per i diritti delle minoranze, razziali e religiose in prevalenza, col compito di riferirne in Parlamento.
Negli Stati Uniti, attraverso il Civil Rights Act del 1957, sono stati istituiti due organi relativi alle problematiche minoritarie: la Commissione sui diritti civili ed il Community Relations Service. I compiti della prima comprendono lo studio degli sviluppi legali e delle politiche federali, in relazione ad un’eguale protezione legislativa in settori come quello dell’educazione e con funzioni informative. Il secondo invece aiuta le comunità a sviluppare piani per il miglioramento delle politiche interrazziali attraverso conferenze, pubblicazioni ed assistenza tecnica. Per ciò che concerne poi le comunità indiane, esistono all'interno del Congresso, ben quattro commissioni specifiche.
6. Ulteriori strumenti da adottare
Il miglior deterrente contro i crimini lesivi di interessi comuni alla generalità degli Stati – i delicta juris gentium – è sicuramente il maggior rischio per l’individuo di essere penalmente perseguito, piuttosto che dalla possibilità di far valere l’eventuale responsabilità statale[61].
Il rischio per l’individuo - privato od organo di Stato - di essere punito, aumento nella misura in cui gli Stati realizzino a tal fine una cooperazione nella repressione penale del crimine, tanto più difficile quanto più il crimine sia collegato con un ambito di sovranità statale, per evidenti ragioni di rispetto della libertà di ciascuno Stato nei rapporti con i propri sudditi. È così che, in relazione al caso classico della pirateria marittima, l’esigenza della repressione a livello internazionale trova facile attuazione attraverso il riconoscimento della facoltà di qualunque Stato di esercitare atti di giurisdizione su pirati anche se la loro nave non ne porti la bandiera, o il fatto sia accaduto in un luogo non soggetto al suo potere giurisdizionale[62]. Si è invece pervenuti a permettere a Stati diversi da quello di appartenenza, la repressione penale di crimini commessi in una sfera di controllo statale, spesso come sistema di governo o di condotta delle ostilità nel corso di un conflitto armato[63].
Inizialmente si è arrivati a ciò solo a fini di tutela del combattente, con la possibilità per gli Stati di perseguire penalmente gli individui responsabili di crimini di guerra, anche se organi dello Stato straniero. Fino al Trattato di Versailles, i giudizi erano limitati al periodo del conflitto, qualora il criminale in questione, membro delle forze armate di una Parte belligerante, si trovasse nelle mani dell’altra. Era il principio della reciprocità che rimetteva le cose in pari, seppure sempre in conformità col diritto internazionale, poiché, in deroga alla norma che lo vieta in via generale, l’esercizio della giurisdizione penale nei confronti di organi stranieri, era in questo caso lecito.
A Versailles, invece, abbandonata la prassi delle amnistie fino ad allora contemplate dai trattati di pace, si fece emergere l’esigenza di assicurare i criminali alla giustizia anche a conflitto ormai concluso, e peraltro, non solo i membri delle forze armate dello Stato vinto, ma anche il più diretto responsabile della stessa guerra di aggressione del 1914, ovvero Guglielmo II. Inoltre, nel Trattato di Sèvres del 1923 tra le potenze alleate e l’Impero ottomano erano contemplati anche i "crimini contro le leggi dell'umanità", in riferimento al genocidio di un milione e mezzo di armeni ad opera delle autorità turche, per la cui repressione la Turchia si impegnava ad estradare i responsabili. È noto che il sistema repressivo pensato in tali trattati fallì anche a causa dei Paesi Bassi che rifiutarono l'estradizione di Guglielmo II e per la mancata ratifica del Trattato di Sèvres, sostituito nel 1927 con quello di Losanna che, per quegli atti di genocidio, prevedeva l’amnistia. Tale fallimento, nonchè l’intento di operare al di fuori della logica dei vincitori che si ergono a giudici di vinti, contribuirono fra le due guerre mondiali, all’emergere dell’idea di istituire una corte penale internazionale, per la quale furono elaborati numerosi progetti, tanto a livello intergovernativo che non governativo[64].
In particolare, nel quadro della Società delle Nazioni, già nel 1937, in aggiunta alla Convenzione contro il terrorismo, firmata da 24 Stati, venne adottato un Protocollo, firmato da 13 Stati, che prevedeva una corte penale internazionale, mai istituita anche a causa delle vicende belliche che impedirono l’entrata in vigore di entrambi gli strumenti. Neanche il sistema creato dopo il secondo conflitto mondiale, ha dato risultati soddisfacenti, nonostante abbiano funzionato tue tribunali definibili internazionali: anzitutto per il sospetto di parzialità che non può non accompagnare una giustizia amministrata dai vincitori nei confronti dei vinti[65], ma anche perchè la giustizia di Norimberga e di Tokio ha raggiunto in verità ben pochi criminali e ha dunque rappresentato un fenomeno marginale di repressione dei crimini di guerra. Fin dal primo operare delle Nazioni Unite, si sono poi tentate vie diverse nel campo della cooperazione interstatale per la repressione dei delicta iuris gentium, vie che peraltro non sembrano aver dato risultati migliori. E' così che nell’elaborazione della Convenzione contro il genocidio ci si è resi subito conto che l’unica via praticabile è quella della competenza preventiva di una corte penale internazionale, contemplata nell’art.VI accanto a quella dello Stato del locus commissi delicti. Nessuno dei progetti per lo statuto di una tale corte, elaborati nel 1947 dal Segretario generale delle NU, ha avuto seguito. Ed era poco probabile che lo Stato territoriale rispettasse l’obbligo di reprimere il crimine, o che qualche altro Stato parte si facesse carico del rispetto di tale Convenzione, facendo valere l’eventuale responsabilità statale davanti alla Corte internazionale di giustizia, sulla base della clausola giurisdizionale prevista dall’art.IX. Lo stesso destino della corte penale internazionale contro il genocidio hanno avuto, tanto il progetto di corte elaborato da un comitato ad hoc delle N.U. del 1953, quanto il progetto del 1981 di quella corte la cui competenza è prevista dalla Convenzione contro l’apartheid del 1973, accanto alla competenza obbligatoria dello Stato territoriale[66].
Una via diversa si era nel frattempo seguita nella Conferenza di Ginevra del 1949 sul diritto applicabile nel corso dei conflitti armati: la previsione di un obbligo di repressione o di estradizione (aut judicare aut dedere) a carico di tutte le Parti contraenti, a prescindere da qualsiasi collegamento con la fattispecie criminosa. È noto che le Parti delle quattro Convenzioni di Ginevra, nonchè dei Protocolli aggiuntivi del 1977, non si mostrarono sollecite a conformare a tale principio i propri ordinamenti[67], con la conseguenza che la repressione penale ad opera degli Stati terzi dei crimini perpetrati in tempi di conflitto armato internazionale ed interno non trova effettiva realizzazione. L’obbligo di adattamento previsto infatti nelle quattro Convenzioni e nei Protocolli, non significa che la repressione o l’estradizione possano direttamente operarsi: è necessario che sia adempiuto tale obbligo con specifici provvedimenti, e non con semplici norme di rinvio, a meno che, naturalmente, l’ordinamento interno non sia già conforme.
Anche in altre Convenzioni che si occupano della prevenzione e della repressione di delicta juris gentium ci si pone nella logica di lasciare agli Stati stessi l’esercizio dell’attività punitiva, provvedendo soltanto ad ampliare l’ambito della giurisdizione penale statale con la previsione di criteri obbligatori in aggiunta a quello territoriale: infatti, secondo le convenzioni che si occupano di prevenire e reprimere la pirateria aeronavale, gli atti diretti contro persone particolarmente protette e le torture, l’obbligo della repressione opera nei confronti dello Stato del locus commissi delicti, ricomprendente la nave o l’aeromobile immatricolati nello Stato, di quello di appartenenza attiva (collegato cioè con l’autore del crimine o con colui che ha noleggiato il mezzo), o passiva (collegato cioè con la vittima del crimine), e, per alcuni crimini, dello Stato leso in un suo interesse particolare (criterio protettivo), nonchè di quello di detenzione, con la libertà di questo Stato di scegliere tra judicare e dedere[68]. In tali convenzioni al criterio di giurisdizione universale ci si è molto avvicinati, essendo stato posto l’obbligo della repressione a carico di tutti gli Stati che concretamente hanno gli strumenti per esercitarla, liberi tutti gli altri di farlo essi stessi sulla base di un eventuale ulteriore criterio di giurisdizione accolto nelle loro legislazioni. Tutti gli Stati parti, hanno assunto un obbligo di accogliere nel loro ordinamento i criteri indicati.
Una scelta più complessa è stata fatta nella Convenzione di Vienna del 1988 per gli atti più gravi legati al traffico illecito di stupefacenti: per tali atti si è seguita la via di porre una competenza obbligatoria sulla base del criterio territoriale e del criterio di detenzione, quest’ultimo però combinato col principio aut dedere aut judicare nel caso di competenza territoriale o personale. Resta peraltro ferma una libertà di repressione secondo qualsiasi altro criterio contemplato dalla legislazione interna. Nonostante l’esistenza di incisivi obblighi in materia repressiva posti a carico degli Stati da questo ampio sistema convenzionale in materia di crimini di guerra, contro l’umanità e contro la pace, rimane fondamentale l’istituzione di una corte penale internazionale che, in modo permanente ed imparziale, curi di reprimere i crimini, tanto del tempo del conflitto armato quanto del tempo di pace, che gli Stati (o i gruppi armati) non vogliano o non siano in grado di reprimere. L’aspetto su cui si è portati a riflettere, è quello dell'opportunità e della possibilità effettiva, se non della legittimità, del funzionamento di una giustizia ad hoc, che venga sostanzialmente imposta da alcuni Stati contro altri Stati o gruppi di insorti[69]. È necessaria una giustizia penale organizzata, a livello internazionale, in modo preventivo, che funzioni in modo permanente, universale ed uniforme dal punto di vista geografico[70], ad opera di chiunque e dovunque i delicta juris gentium vengano commessi, per agire da fattore deterrente contro la possibilità di futuri crimini. Il futuro della corte penale internazionale è principalmente legato ad un’accettazione preventiva della sua competenza[71], non già ad una eventuale accettazione ex post facto, in quanto una scelta di tale ultimo senso, voterebbe l’organo al totale fallimento.
(Altalex, 12 luglio 2012. Articolo di Catello Avenia)
[1] T.H.Bagley, General principles and problems in the International protection of minorities, Populaires, Geneve, 1950
2 Bisogna infatti distinguere tra le tradizionali questioni "minoritarie" e quelle "nazionali" di più recente sviluppo, dato che molti sono i gruppi che negli ultimi decenni si sono riconosciuti una propria coscienza che li vincola alla nazione "madre", ritagliandosi una propria autonomia: per essi il termine minoranza appare riduttivo. Fra le piccole comunità greche e albanesi presenti in Sicilia e Calabria e la popolazione musulmana di Bosnia, o quella turca di Cipro, la differenza non è numerica, ma di fondo. C. Zanghì, Tutela delle minoranze ed autodeterminazione dei popoli, in Riv. Int. dei diritti dell'uomo, n°2, Milano, 1993
[3] Report of the Committee of experts on human rights. 9 novembre 1973, Consiglio d'Europa DH\EXO 73-47
[4] Nei rapporti J.Deschenes (E\CN.4\sub2\1985\31) e A.Eide (E\CN.4\sub2\1992\37) non vengono effettuati cambiamenti radicali rispetto alla dottrina del rapporto F.Capotorti (E\CN.4\sub.2\384\rev.1).
[5] “Per la volontà di salvaguardare la propria identità ed un sentimento di solidarietà”, così come espresso nel Trattato sulle relazioni di buon vicinato, intercorso tra Polonia e Germania il 17 giugno 1991, relativo alla minoranza tedesca in Slesia.
[6] C. Zanghì, op.cit.
[7] M.Toscano, Le minoranze del diritto internazionale, Torino, 1931
[8] H.Witgens, Der volwerrechtliche schutz der nationalem, sprachlichen und religiosen Minderheiten, Stuttgart, 1930
[9] F.Maldestam, La protection dés minorités, Paris, 1923
[10] F.L.Israel, Major peace treaties of modern history, Mc Graw Hill, New York, 1967
[11] H.Witgens, op.cit.
[12] Maldestam, op.cit.
[13] M.Toscano, op.cit.
[14] Actes de la troisiéme Assemblée. Procés verbaux de la sixiéme Commission, Société des Nations, 1922
[15] E.C.Mower, International government, Boston, 1931
[16] A.Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Cedam, Padova, 1988
18 Risoluzione 532 B (VI) 4 febbraio1952
19 A.Cassese, op.cit
[19] Anno della spartizione, ma la vera tragedia si attesta tra il ‘69 e l’87, quando per mano dei gruppi paramilitari della minoranza cattolica e dell'esercito britannico, più di duemila e cinquecento vittime sono cadute nell'ambito di un conflitto che a tratti si riaccende nel modo più aspro, senza alcuna speranza di uno sblocco.
[20] Risoluzione n°573 del 29-7-1974.
[21] A.Sinagra, The Turkish Republic of Northern Cyprus in the international law: proposals for a reasonable solution to the crisis, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1, 1990
[22] ONU, Assemblea generale, Ris.421, V\1950
[23] F.A.Casadio, Patti sui diritti dell’uomo, 1968
[24] F. Capotorti, Patti internazionali sui diritti dell’uomo, Cedam, Padova, 1967
[25] F.Capotorti, Studio sui diritti delle minoranze, ONU, 1991
[26] F.Capotorti, op.cit., 1967
[27] artt.8-16 Convenzione per l'eliminazione del razzismo; artt.19-59 Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo; artt.21-29 Carta sociale europea
[28] Consiglio economico e sociale per il PDESC, Comitato per i diritti dell'uomo del PDCP: il primo per la osservanza degli obblighi, l’altro solo allo scopo di super visione e di stimolo.
[29] G.Sperduti, La tutela internazionale dei diritti dell’uomo, Roma, 1962
[30] F.Capotorti, op.cit., ONU, 1991
[31] Id..
[32] Art.14 costituzione
[33] Assemblea generale ONU, Ris.1781 (XVII) dicembre 1962
[34] I.O.Bokatola, La declaration des Nations Unies sur le droits des personnes appartenant a des minorites nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, in Revue generale de droit international public, tome 97/1993/3
[35] “Nulla in questa dichiarazione può farsi valere come contrario agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica degli stati”.
[36] A.Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Cedam, Padova, pag.88
[37] art.25, competenza facoltativa della Commissione europea dei diritti umani, per i ricorsi contro gli Stati che abbiano dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione in tale materia.
[38] Come disse il Presidente Laroque, nel suo discorso introduttivo, in G.Sperduti, Colloquio sulla Carta sociale europea, SIOI, Roma, 1977
[39] G.Sperduti, op.cit.,1977
[41] F.Capotorti, op.cit., 1967
[42] C.Zanghì, Tutela delle minoranze e autodeterminazione dei popoli, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, Milano, n°2, 1993
[43] C.Zanghì, op.cit.
[44] Id.
[45] Id.
[45] Tale termine viene usato nell’accezione societaria proposta da P.Schmitter, G.Lehmbruck ed altri, in W.Safran, Non separatist policies regarding ethnic minorities, in International Political Science Review, vol.15 n°1, 1994
[46] F.Capotorti, op.cit., ONU, 1991
[47] ONU - Research papers n° 21 - 1993
[48] P.Lendvai, Tensions nationales et menace sur la securitè dans les Balkans, in Politique Etrangere, n.3, 1991
[49] Assemblea parlamentare CSCE, Budapest 5 luglio 1992
[50] E. Chossudovsky, Pour un règlement pacifique au Kosovo, in Le Monde diplomatique, n.471, giugno, 1993
[54] E cioè libertà di scelta, senza alcuna interferenza esterna, nella determinazione delle forme della propria autonomia politica, delle proprie istituzioni e del proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
[55] C. Zanghì, Tutela delle minoranze ed autodeterminazione dei popoli, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 2, 1993
[53] ONU - Commissione per i diritti dell'uomo- lavori della 44^ sessione - relatore M.Bossuyt, Ginevra 3/28 agosto 1992
[54] Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 3175^ riunione, risoluzione 808, 22 febbraio 1993
[55] ONU rapporto S/25274, 1992
[56] ONU - Commissione per i diritti dell'uomo, lavori della 45^ sessione, relatore I.Maxim, Ginevra 2/27 agosto 1993
[57] L. Daniele, La prima ordinanza sulle misure cautelari nell'affare tra Bosnia-Erzegovina e Iugoslavia, in Rivista di Diritto Internazionale, vol. LXXVI, 1993
[58] par.13 dell’ordinanza. La Corte richiama in proposito l'art.7, par.2, lett.a) della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.
[59] Lo stesso orientamento può ricavarsi dalla giurisprudenza che ammette la teoria del forum prorogatum. Starace, La competenza della Corte internazionale di giustizia in materia contenziosa, Napoli, 1970
[60] W. Safran, op.cit.
[61] La quale responsabilità si esprime innanzitutto nell'obbligo per lo Stato (o gruppo) di riparare il torto con la punizione dei propri organi e con altre forme di riparazione, secondo il principio codificato dalla Conferenza dell’Aja del 1907. Anche nel colpire direttamente gli individui si fa peraltro spesso valere una responsabilità dello Stato: e ciò accade quando gli individui siano organi di tale Stato e vengano penalmente perseguiti da altri Stati non più tenuti al rispetto dell'organizzazione straniera, proprio in virtù della riferibilità di un illecito internazionale allo Stato stesso. F. Lattanzi, Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale, Milano, 1983
[62] D. Anzillotti, L'azione internazionale contraria al diritto internazionale, in Riv. di dir. int. e di legislazione comparata, Napoli, 1902
[63] Bierzanek, War crimes: history and definition, in International criminal law, vol.III, Dobbs Ferry, N.Y., 1986
[64] M.C. Bassiouni, The time has come for an International Criminal Court, in Indiana Int. and Comparative Law Review, 1991; MacPherson, An International Criminal Court applying world law to individuals, Washington, aprile 1992
[65] F. Lattanzi, Riflessioni sulla competenza di una corte penale internazionale, in Riv. di Dir. Internazionale, 1993, vol. LXXVI, n.3
[66] United Nations draft convention on the establishment of an international penal tribunal for the suppression and punishment of the crime of apartheid and other international crimes.
[67] Neppure l’ordinamento italiano, che pure contiene già una norma come l’art.7,5°co. del c.p., si è mosso per consentire l’effettiva applicazione da parte dei giudici italiani del criterio universale di giurisdizione per le infrazioni gravi al sistema convenzionale di Ginevra. F.Lattanzi, op.cit., 1993
[68] Convenzione dell'Aja 16 dicembre 1970 sulla repressione della cattura illecita di aeromobili; Convenzione di Montreal 23 settembre 1971 sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, integrata dal Protocollo di Montreal 24 febbraio 1988; Convenzione di New York 14 dicembre 1973 sulla prevenzione e repressione dei reati commessi nei confronti delle persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici; Convenzione di New York 17 dicembre 1979 contro la presa di ostaggi; Convenzione 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti.
[69] Circa la competenza del Consiglio di Sicurezza ONU ad istituire tali tribunali, ampio è stato il dibattito già fin dagli anni ‘50: l’unica eventualità prospettata fu quella di una risoluzione dell' Assemblea generale, ma a tal fine si ritenne essere necessaria una modifica della Carta perchè, si disse, si sarebbe trattato di permettere ad un organo ONU di svolgere funzioni rientranti nella domestic jurisdiction; la modalità istitutiva più adatta sembrò a quel tempo la stipulazione di un accordo internazionale. G. Gaja, Rèflexions sur le role du Conseil de Sècuritè dans le nouvel ordre mondial, in Revue gènèrale de droit int.public, 1993
[70] Contro la comune tendenza propositiva di tribunali preventivi, ma speciali o di tribunali penali misti, composti dai giudici dello Stato territoriale, di quello nazionale dell'accusato e della vittima, nonchè dai giudici di alcuni Stati "neutrali", o quella di tribunali regionali. Conclusions and recommendations of world conference on the establishment of an international criminal tribunal to enforce international criminal law and human rights, Siracusa 2\5 dicembre 1992
[71] F.Lattanzi, op. cit., 1993
estratto da http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=18879





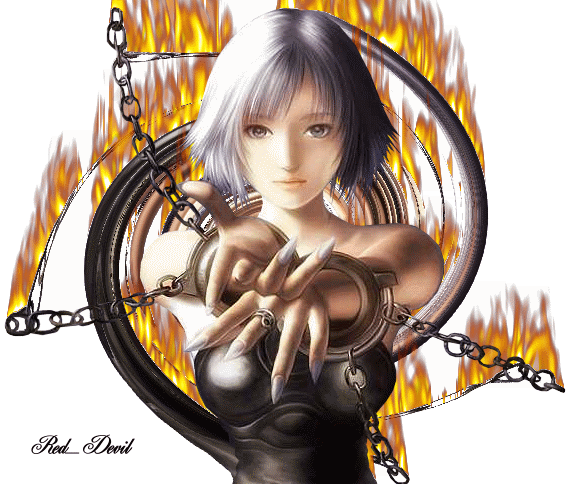
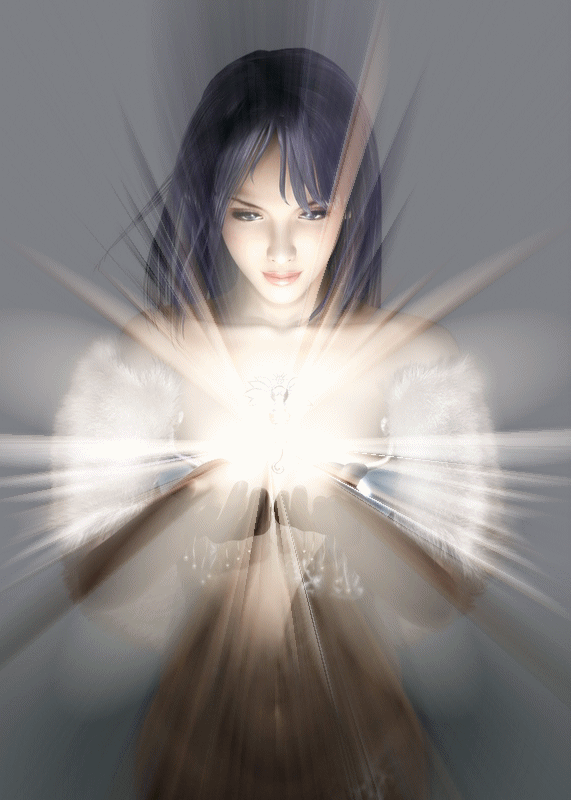
Nessun commento:
Posta un commento